Una Vita Da Mediano
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bilancio Sociale 2015 - 2016 Lega Nazionale Professionisti B Lega Nazionale Professionisti B
Bilancio Sociale 2015 - 2016 Lega Nazionale Professionisti B Lega Nazionale Professionisti B Via Ippolito Rosellini, 4 - 20124 Milano T: +39 02 69 91 01 - F: +39 02 69 00 14 60 www.legab.it BILANCIO SOCIALE 2015-2016 Bilancio Sociale 2015-2016 Lega Nazionale Professionisti B SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA B BILANCIO SOCIALE 2015-2016 Il Bilancio Sociale è ormai per la Lega B un passaggio naturale, un appun- Abbiamo prestato grande attenzione a quelle che definiamo le“infrastrutture tamento programmato, che certifica il consolidato delle attività della Nostra immateriali”, attraverso il crescente impegno nella promozione della respon- Associazione e dei Club nella stagione sportiva sul versante della Responsa- sabilità dei comportamenti sportivi e gestionali: bilità Sociale, arricchito degli impegni futuri che sono, di fatto, il primo mo- dulo di verifica del Bilancio della stagione successiva. Già questa sintetica rap- -il “Cartellino Verde” per sottolineare i grandi esempi positivi di sportività in presentazione del Documento può essere considerata un elemento distintivo campo; e qualificante nell’ambito del sistema calcistico italiano, tanto più valorizza- ta dalla contestualità con la quale la Lega B approva in assemblea il Bilancio - la campagna di formazione verso tutti i tesserati dei 22 Club e le attività d’Esercizio e presenta allo stesso consesso il Bilancio Sociale, associando le di monitoraggio delle 470 partite del Campionato per contrastare il match due pubblicazioni nella descrizione puntuale e organica delle complessive -

Il Talento Di Francesco. Totti E Borromini: Due Fuoriclasse a Confronto
ENRICO MAIDA E FULVIA STRANO IL TALENTO DI FRANCESCO Totti e Borromini fra genio e creatività Edilazio Letteraria PREFAZIONE di Vincenzo Cerracchio “Totti è un genio, questo lo sai...” Quando Fulvia - coautrice di questo libro e, soprattutto, amica mia - iniziò la manovra di aggiramento, io la scambiai ingenua - mente per la solita provocazione da romanista a laziale. Sorrisi scettico e dissi “beh...” “Quello che non sai è che ha lo stesso talento di Borromini, è un genio controcorrente” . Quando Fulvia - coautrice di questo libro e, soprattutto,storica dell’arte - cominciò a sparigliare il discorso, io lo scambiai stupi - damente per un paradosso a effetto. Il sorriso si fece perplesso e dissi “ah...” “Ho idea di scrivere una storia incrociata. E ho bisogno del tuo aiuto”. Quando Fulvia - coautrice di questo libro e, soprattutto, donna - si mette in testa una cosa, le strade sono due: assecondare o fug - gire. Va così con qualsiasi donna, no? Io scelsi la strada intermedia: glissare. Guardai verso un imperdibile orizzonte e dissi “uhm...” “Hai capito male. Mica devi scriverci tu, di Totti. Laziale come sei, sai che schifo ne uscirebbe. Però devi trovarmi un Tottologo”. Spiegava, si accalorava, scalava la terza in doppia debraiata, ma - 5 gnificando il tacco di Totti, il suo cucchiaio, i suoi gol, difficili e inevitabilmente meravigliosi, irridenti come le orecchie d’asino sullo stemma papale di un architetto del Seicento che si chiamava Francesco anche lui. Borromini, quello che ha trasformato la Ro - metta in Roma, senza essere un calciatore. Nati lo stesso giorno, un 27 settembre, diversamente simili: dipenderà dall’ascendente quel poco che non hanno in comune? Feci finta di allacciarmi una scarpa e dissi “boh...” Visto che non la fermavo comunque - o forse avevo finito la gamma di interiezioni - buttai lì una frase così: “Un libro? Ma dai, come fai? Un articolo ci potrebbe anche stare, sarebbe curioso. -

Corea E Giappone, L'oriente Che Diventa Vicino
lunedì 20 maggio 2002 11 lingua mongola. Capitale della penisola paese e che fa della parte nord-occidentale Il Ginseng e il Taekwondo di Corea, il cui nome deriva dalla dina- Budo, arte di affrontare la vita una regione dal clima rigido, tutto il con- stia Koriu che regnò sul paese dal 918 al trario della parte che affaccia sul pacifico. arti rigeneratrici della Corea 1392, è Seul posta su una latitudine pari Giappone, futuro e tradizione Il Giappone estendendosi su 20 gradi di a quella di Enna in Sicilia. Il clima è però latitidune ha una vegetazione estremamen- completamente diverso sia per l’imper- te varia e una foresta che copre il 70% del Dal carattere somatico simile a quello versare dei monsoni nella stagione esti- Con 125 milioni di abitanti su una superfi- territorio, secondo il Giappone alla sola cinese, giapponese e mongolo la popola- va che per i venti siberiani nella stagione cie (il Giappone è un arcipelago di isole) Finlandia. Il Giappone è patria del Budo zione della Corea supera di poco le 46 fredda. Da alcuni anni la Corea è entrata di poco superiore all’Italia, i nipponici arte marziale come mezzo per affrontare milioni di unità. La lingua coreana fa nei costumi degli italiani, sia per le pro- hanno la più alta densità di popolazione le difficoltà della vita. È anche la patria parte delle lingue altaiche, ma ha una duzioni tecnologiche, ma anche per del pianeta con 335 abitanti per km qua- dello Shiatsu, tecnica di massaggio tesa a struttura completamente diversa dal ci- alkcune “arti rigeneratrici” come l’uso drato. -

SERGIO TACCONE RACCONTI ROSSONERI Antologia Casciavit
SERGIO TACCONE RACCONTI ROSSONERI Antologia Casciavit Venti puntate tratte dalla rubrica “L’angolo della Storia” del MilanBlogClub Prefazione di Mirko Morini http://milanblogclub.splinder.com/ 2 "I nostri colori saranno rosso, perché noi saremo dei diavoli, e nero, come il terrore che dovremo incutere agli avversari". Herbert Kilpin (Fondatore e primo capitano del Milan) 3 4 Racconti Rossoneri Antologia Casciavit 5 6 Indice Prefazione – di Mirko Morini “Butirro” ................................................. Introduzione: Storie per Milanisti Veri ......................................................... 1. L’avvocato del diavolo che castigò i nerazzurri 2. Elogio del Piscinin, milanista per eccellenza 3. Maradona ai piedi del Diavolo 4. Maggio 1979, la Stella finalmente 5. La bellissima, inutile prodezza di Dustin 6. Il poker che annientò il Barca di Cruijff 7. Elegia del Golden Boy 8. La classe del Cigno Olandese 9. La resa di Puskas 10. In ricordo di Beppe Viola 11. Mark, ascensore per il paradiso 12. Due rossoneri nel gorgo della guerra 13. Gol di Capra, digiuno finito, bauscia zittito 14. Quando Milan-Juve valeva una Champions 15. “Brillantina”, il giocattore 16. La favola triste di Germano 17. Van Hege, primo bomber della storia rossonera 18. Il “coast to coast” di George 19. Ricordo del Paron 20. Lo strano esonero di Guttmann Qualcuno era (ed è) milanista… Fonti fotografiche 7 8 PREFAZIONE Preservare il ricordo delle grandi storie di Mirko Morini “Butirro” Qualsiasi raggruppamento di persone può chiamarsi comunità se condivide un insieme di valori. Il trasferimento di questi valori fondanti della convivenza avviene con l’emulazione diretta od indiretta di campioni. A questo serve il preservare il ricordo delle grandi storie. -

Paolino Rossi, Un Ragazzo Come Noi
Paolino Rossi, un ragazzo come noi di Luca Rolandi Ci sono due immagini che rimarranno scolpite nella memoria collettiva: il mucchio, ebbro di felicità, della notte di Madrid, l'11 luglio 1982, e i gli stessi giocatori 38 anni dopo che portano sulle spalle il loro compagno verso la chiesa per la cerimonia funebre e l’ultimo viaggio. Campioni del mondo allora e campioni del mondo oggi. Lacrime di gioia e di dolore, ieri e oggi. La metafora della vita. Un lutto collettivo e umanissimo, come si fosse perso un famigliare. Si chiamava Paolo Rossi, nome comune, forse scontato. Nella storia quanti sono i Paolo Rossi famosi o anonimi. Impossibile pensare solo di cimentarsi a contarli. Ma lui è stato unico per quel mondo dello sport e del calcio in particolare, che appare l’ultima grande narrazione universale, collante globale di sentimenti, gioie e dolori. È stato così per la morte di Diego Armando Maradona, celebrata con pagine di carta e digitali, commenti, servizi televisivi, che neppure per un capo di Stato o un benemerito della scienza o un premio Nobel per la letteratura avrebbero avuto, e una settimana dopo con Paolo Rossi. Il ragazzo italiano era della classe 1956, nativo di Prato, ma vicentino di adozione, professione calciatore e poi tante altre cose. La sua morte è un lutto generazionale, una fase di vita che si chiude, non solo quella dell’uomo Paolo Rossi, con il dolore di sua moglie, i suoi figli, i suoi parenti e amici, ma anche per una ampia fascia di donne e uomini che allora bambini o adolescenti avevano visto, vincere, perdere, cadere e risorgere Paolino Rossi, Pablito, in quella calda e indimenticabile estate del 1982. -

Azzurri, Notte Di Rimpianti Marito Stremato: «Dai,Che Saranno Contenti Iviados..» Separabili in Questa Avventura Usa, Sorabile Ma Graduale
,4* %• Martedì 19 luglio 1994 l'I'iiiU'i inyi n i ó LA FINALE. Incubi, rammarico e lunghi addii in Casa Italia alla fine dell'avventura Sconfitta ai rigori? Bossi l'aveva detto... CARLO BRAMBILLA •i MILANO. Quanto sarebbe piaciuto al com pianto Gianni Brera... Che musica, quei peana su difesa e contropiede, su palle lunghe e peda lare. Incosciente provocatore d'un Umberto Bossi. Va 11 alla sua festa leghista di Milano, si siede in prima fila davanti al maxischermo piaz zato dentro l'Arena e per 120 interminabili mi nuti si mette a rievocare, esaltandoli, i fantasmi d'una scuola di pensiero pedatono implacabil mente bollata d'eresia. Sciata insopportabil mente afosa, una minerale via l'altra, una cara- mellina via l'altra. Dietro l'Umberto duemila su- datissimi nordisti che tifano Italia, attentissimi a non aggiungere all'incitamento il berlusconia- no e inviso «Forza». Non sia mai E anche lui, l'Umberto provocatore ed eretico, tiene alla di stinzione: «Tifo - dice sibillino - per l'Italia con la "1" maiuscola». Quella minuscola, dei finti cieli azzurrini, dei fondali fininvcstiani propno non riesce a digcnrla. Al suo lianco c'è l'interi sta Formentmi. Qualche traccia nerazzurra è rintracciabile anche nel dna del Scnatur. Fischio d'inizio, l'Umberto stu dia per un paio di minuti le prime danze italobrasilere e poi spara nell'o recchio del sindaco l'azzardata profezia: «Caro Marco qui si va ai rigori». «Figuriti, non è mai successo», è la replica saccentina del primo meneghi no. Ridanciano finché si vuole, ma è già scontro politico. -

Roberto Baggio
pagina 10 'UnitdJ? Sport (.mudi IO novt mhit IW NAZIONALE. Gesto di solidarietà dello juventino: il trofeo all'asta, il ricavato ai piemontesi Calcio, Nizzola e Matarrese ascoltati al Coni k&r s-0!*»!**^»^ Antonio Matimst I uu ino Ni/ zola rispetto ime nti presidintt della federcalcio i di II i leg i soni stati ascoltati dalli lonimissione Roberto Baggio: del Coni per lesprsto presentato dell ex presidenti del Modena Francesco Farmi sui | resunti ille citi delle socie ta di calcio di seni A eB Le audizioni sono cimate poc< più di due ore Al termine nessun commento dei componenti delia «Il mio Pallone d'oro commissione Cardamone conserva il titolo per gli alluvionati» europeo dei medi Agostino Cardamone ha conserva Roberto Baggio contribuisce alla raccolta di Rivera a Matarrese to il titolo europeo dei medi bii tendo ai punti sul nng dell Anston «Gli azzurri Roof di Sanremo I inglese bhaun fondi per i piemontesi alluvionati regalando il Cummins Ecco il verdetto che ha non sono affar suo assicurato il successo al pugile ita suo Pallone doro. La decisione l'ha presa lune liano Walter MI«JI1 ( I arbitio au •Il presidente della federazione stnaco; 117 a 111 knud Jensen (Danimarca) 117a 1(JC> Ravmond calcio non dovrebbe nemmeno dì, attraversando le zone colpite dal maltempo, Bachelet (Francia) US a 110 Al Interessarsi alla gestione della termine dell incontro Card.uno u mentre andava a Coverciano. squadra azzurra». Sono parole ha detto di aver iniziato il match dell'ex calciatore Gianni Rrvera, teso e un pò nervoso ma poi mi oggi deputato del Patto Segni. -

Il Pugilato Di Gianni Brera
Storia e sviluppi della disciplina del pugilato in Italia IL PUGILATO DI GIANNI BRERA Sergio Giuntini [email protected] Franco Contorbia, uno dei massimi studiosi di Gianni Brera, ha osservato: La vita e l’opera di Brera sono in attesa di un risarcimento degno dell’una e dell’altra. La sua biografia è ancora in cerca d’autore. La formazione alla periferia del giornalismo sportivo italiano; la partecipazione alla guerra fino al vischioso rapporto con il fascismo repubblicano pavese; la scelta, infine, nel maggio 1944, della guerra partigiana sono temi che Brera non ha mai affrontato di buon grado, finendo per coinvolgere i suoi agiografi in un sistema di interdizioni mai venute meno negli anni […]. Lo stato degli scritti si presenta anche più desolante. Intanto, sembra davvero indifferibile l’allestimento di un compiuto inventario dei testi che Brera ha disseminato ovunque con sovrana e un po’ disperata nonchalance; e il soccorso di una filologia duttile, non ossessiva ma nemmeno cialtrona, non potrà che propiziare una selezione capace di superare la soglia della decenza e una “descrizione” plausibile dei suoi stupefacenti strumenti formali e delle sue inattingibili qualità onomaturgiche1. Queste riflessioni confermano quanto resti ancora da fare nell’approfondimento della vicenda umana e giornalistica del pavese nato l’8 settembre 1919 a San Zenone Po. Un’esperienza in gran parte da riscoprire, che offre un enorme ventaglio di possibili interpretazioni e chiavi di lettura. All’interno di questi territori breriani da esplorare, uno dei meno frequentati è dato dal pugilato: disciplina che egli amava (tra gli innumerevoli pseudonimi utilizzò pure quello di Jab, il diretto portato col pugno avanzato) e conosceva bene sin nei suoi risvolti più suggestivi: «La boxe è un’altra cosa» – ebbe ad affermare – «e io sono con San Bernardino, che la raccomandava tanto ai suoi parrocchiani senesi: arrumpetevi lo volto per li pugni et non per li pugnali, che occidono villanamente»2. -

How Italian Football Creates Italians: the 1982 World Cup, the ‘Pertini Myth’ and Italian National Identity
Foot, J. (2016). How Italian Football Creates Italians: The 1982 World Cup, the ‘Pertini Myth’ and Italian National Identity. International Journal of the History of Sport, 33(3), 341-358. https://doi.org/10.1080/09523367.2016.1175440 Publisher's PDF, also known as Version of record License (if available): CC BY-NC-ND Link to published version (if available): 10.1080/09523367.2016.1175440 Link to publication record in Explore Bristol Research PDF-document This is the final published version of the article (version of record). It first appeared online via Taylor & Francis at http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09523367.2016.1175440. Please refer to any applicable terms of use of the publisher. University of Bristol - Explore Bristol Research General rights This document is made available in accordance with publisher policies. Please cite only the published version using the reference above. Full terms of use are available: http://www.bristol.ac.uk/red/research-policy/pure/user-guides/ebr-terms/ The International Journal of the History of Sport ISSN: 0952-3367 (Print) 1743-9035 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/fhsp20 How Italian Football Creates Italians: The 1982 World Cup, the ‘Pertini Myth’ and Italian National Identity John Foot To cite this article: John Foot (2016) How Italian Football Creates Italians: The 1982 World Cup, the ‘Pertini Myth’ and Italian National Identity, The International Journal of the History of Sport, 33:3, 341-358, DOI: 10.1080/09523367.2016.1175440 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/09523367.2016.1175440 © 2016 The Author(s). -

Versione Italiana
ReportCalc o2013 ReportCalc o2013 indice executive summary 11 1 il censimento del calcio italiano 27 2 il profilo delle rappresentative nazionali 43 3 il calcio dilettantistico 61 4 il calcio professionistico: profilo economico finanziario 69 5 il contributo fiscale e previdenziale del calcio professionistico 121 6 il benchmarking internazionale 135 7 stadi, spettatori e sicurezza 153 8 i modelli di governance del calcio professionistico 167 Nota Tutte le tabelle e i grafici potrebbero contenere scostamenti di un valore massimo dell’1% dovuti ad arrotondamenti. 3 di Enrico Letta prefazione Segretario generale dell’AREL ReportCalcio è diventato ormai una consuetudine. Una felice consuetudine, Calcio e a PricewaterhouseCoopers per il prezioso rapporto di fiducia da verrebbe da dire, visto il successo delle prime edizioni e i dibattiti positivi che ne tempo instaurato e ormai collaudato. Un ringraziamento particolare ad Andrea sono scaturiti. Si tratta di uno strumento decisamente innovativo per l’economia Castrignanò, Niccolò Donna, Jacopo Drudi, Emanuele Grasso, Marta Tamburrelli, del calcio in Italia. Ne hanno potuto usufruire operatori, analisti, osservatori che si Fabrizio Tanzilli, Gianfranco Teotino e Michele Uva. sono trovati a disposizione i principali dati, scomposti e aggregati, sul mondo del pallone. Percentuali, cifre, statistiche, osservazione dei trend più significativi, ma ReportCalcio 2013 si trova ad avere oggi un significato particolare perché esce in anche analisi dei contributi fiscali e previdenziali del calcio professionistico, tutti contemporanea con l’apertura di una nuova legislatura del Parlamento italiano. Negli elementi indispensabili per chi si occupa dell’industria calcio in Italia. anni scorsi si sono ricercate riforme necessarie per modernizzare l’intero mondo dello sport e in particolare alcuni aspetti importanti legati al mondo del calcio. -
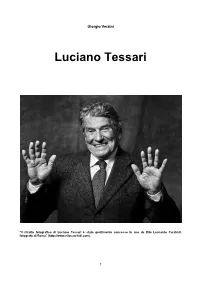
Luciano Tessari
Giorgio Verzini Luciano Tessari "Il ritratto fotografico di Luciano Tessari è stato gentilmente concesso in uso da Elio Leonardo Carchidi, fotografo di Roma" (http://www.eliocarchidi.com). 1 La storia di Luciano Tessari inizia con un “giallo anagrafico”: secondo tutti i siti delle squadre professionistiche Verona Hellas, Roma, Fiorentina, Palermo, dove Tessari ha militato, ma ed anche nel sito dei tifosi del Milan. www.magliarossonera.it dove Luciano per molti anni ha operato nello staff tecnico della società rossonera, sarebbe nato a San Martino Buon Albergo (Verona) il 29 Settembre 1928, data di nascita che lui stesso ha sempre conosciuto. Purtroppo però alcuni anni fa nel richiedere alcuni documenti presso l’ufficio anagrafe del comune di nascita, San Martino Buon Albergo, ha però scoperto di essere nato il giorno successivo e quindi il 30 settembre 1928. Il diretto interessato da me interpellato sul dilemma, ha risolto il problema con una semplice battuta: “Ho così tanti anni che un giorno in più o uno in meno non mi cambia la vita”. Incuriosito, ho voluto svolgere una mia personale ricerca su questo dubbio anagrafico ed ho scoperto che il 2 ottobre del 1928 papà Giuseppe denunciò la nascita del piccolo Luciano Gianfrancesco da mamma Luigia con data 30 settembre, mentre addirittura nel “foglio matricolare”, documento che riportava tutte le informazioni sul suo servizio militare, viene erroneamente indicata come sua data di nascita addirittura il 30 di ottobre 1928. Luciano calcisticamente inizia la sua carriera da portiere nei primi anni ’40 partecipando con amici ad alcuni tornei che si disputano nel territorio. Eccolo qui ritratto in una foto del 1943 quando a 15 anni vince un Torneo disputatosi a Montorio Veronese, con l’inseparabile amico Ugo Pozzan, che lo abbraccia e con Gino Zanoni (il quarto in alto da sinistra) che dopo qualche anno ritroverà nelle fila del Verona. -

Stadio Comunale Bologna: Adani; Roversi, Ardizzon, Furlanis, Battisodo, I.Gregori, Perani, Bulgarelli, Muiesan, Turra, Pace (72
Week 15 Week 16 Bologna FC v Inter Milano 1-2 (1-1) Juventus FC v Atalanta Bergamo 1-0 (0-0) Sunday, 26 January 1969, RF: R.Lattanzi (Roma), Stadio Comunale Sunday, 2 February 1969, RF: Di Tonno (Lecce), Stadio Comunale Bologna: Adani; Roversi, Ardizzon, Furlanis, Battisodo, I.Gregori, Perani, Bulgarelli, Muiesan, Turra, Pace (72. A.Scala) Juve: Sarti; Pasetti, Leoncini, Salvadore, E.Castano, Del Sol, E.Favalli, R.Benetti, Anastasi, Haller, Zigoni Inter: Girardi; Bedin, Facchetti, M.Bertini, Burgnich, G.Cella, Jair, Suarez, A.Mazzola, Corso, Vastola Bergamo: De Rossi; Poppi, Dordoni, Tiberi, Dotti, I.Bertuolo, Nastasio, Lazzotti, S.Clerici, Dell’Angelo, Incerti Scorers: 1-0 Muiesan (7.), 1-1 M.Bertini (20.), 1-2 Vastola (49.) Scorer: 1-0 Haller (75.) US Cagliari v Atalanta Bergamo 1-0 (0-0) AC Fiorentina v AS Roma 0-0 Sunday, 26 January 1969, RF: Francescon (Padova), Stadio Amsicora Sunday, 2 February 1969, RF: Francescon (Padova), Stadio Comunale, sent-off: Bet Cagliari: Albertosi; Martiradonna, Longoni, Cera, Niccolai, M.Longo, Nené, Brugnera, Boninsegna, Greatti, L.Riva ACF: Superchi; Rogora, Mancin, S.Esposito, U.Ferrante, Brizi (73. Chiarugi), F.Rizzo, Merlo, Maraschi, De Sisti, Amarildo Bergamo: De Rossi; Poppi, Dordoni, Tiberi, Dotti, I.Bertuolo, Nastasio, Lazzotti, S.Clerici, Dell’Angelo, Incerti Roma: Ginulfi; Bet, Carpenetti, Salvori, Cappelli, Santarini, Scaratti, D’Amato, F.Landini, Capello, Peiró Scorer: 1-0 Cera (66.) UC Sampdoria v AC Milan 1-1 (0-1) Juventus FC v UC Sampdoria 1-1 (0-0) Sunday, 2 February 1969, RF: De Marchi (Pordenone), Stadio Luigi Ferraris Sunday, 26 January 1969, RF: Giunti (Arezzo), Stadio Comunale Samp: Battara; Sabadini, P.Sabatini, Delfino, F.Morini, G.Vincenzi, G.Salvi, Vieri, Cristin, Frustalupi, A.Novelli Juve: Sarti; Pasetti, Leoncini, Salvadore, E.Castano, Del Sol, E.Favalli, R.Benetti (68.