Laura Piccolo Se C'è Una Stagione Fortunata Per La
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
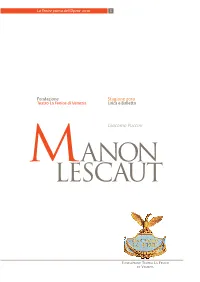
Manon Lescaut
CopertaToPrint_lsc:v 18-01-2010 10:57 Pagina 1 1 La Fenice prima dell’Opera 2010 1 2010 Fondazione Stagione 2010 Teatro La Fenice di Venezia Lirica e Balletto Giacomo Puccini Manon escaut L Lescaut anon anon m uccini p iacomo iacomo g FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA CopertaToPrint_lsc:v 18-01-2010 10:57 Pagina 2 foto © Michele Crosera Visite a Teatro Eventi Gestione Bookshop e merchandising Teatro La Fenice Gestione marchio Teatro La Fenice® Caffetteria Pubblicità Sponsorizzazioni Fund raising Per informazioni: Fest srl, Fenice Servizi Teatrali San Marco 4387, 30124 Venezia Tel: +39 041 786672 - Fax: +39 041 786677 [email protected] - www.festfenice.com FONDAZIONE AMICI DELLA FENICE STAGIONE 2010 Incontro con l’opera Teatro La Fenice - Sale Apollinee lunedì 25 gennaio 2010 ore 18.00 LUCA MOSCA Manon Lescaut Teatro La Fenice - Sale Apollinee venerdì 5 febbraio 2010 ore 18.00 PIERO MIOLI Il barbiere di Siviglia Teatro La Fenice - Sale Apollinee mercoledì 10 marzo 2010 ore 18.00 ENZO RESTAGNO Dido and Aeneas Teatro La Fenice - Sale Apollinee venerdì 14 maggio 2010 ore 18.00 LORENZO ARRUGA Don Giovanni Teatro La Fenice - Sale Apollinee lunedì 21 giugno 2010 ore 18.00 GIORGIO PESTELLI The Turn of the Screw Teatro La Fenice - Sale Apollinee mercoledì 22 settembre 2010 ore 18.00 Clavicembalo francese a due manuali copia dello MICHELE DALL’ONGARO strumento di Goermans-Taskin, costruito attorno alla metà del XVIII secolo (originale presso la Russell Rigoletto Collection di Edimburgo). Opera del M° cembalaro Luca Vismara di Seregno Teatro La Fenice - Sale Apollinee (MI); ultimato nel gennaio 1998. -

The Institute of Modern Russian Culture
THE INSTITUTE OF MODERN RUSSIAN CULTURE AT BLUE LAGOON NEWSLETTER No. 61, February, 2011 IMRC, Mail Code 4353, USC, Los Angeles, Ca. 90089‐4353, USA Tel.: (213) 740‐2735 or (213) 743‐2531 Fax: (213) 740‐8550; E: [email protected] website: hƩp://www.usc.edu./dept/LAS/IMRC STATUS This is the sixty-first biannual Newsletter of the IMRC and follows the last issue which appeared in August, 2010. The information presented here relates primarily to events connected with the IMRC during the fall and winter of 2010. For the benefit of new readers, data on the present structure of the IMRC are given on the last page of this issue. IMRC Newsletters for 1979-2010 are available electronically and can be requested via e-mail at [email protected]. A full run can be supplied on a CD disc (containing a searchable version in Microsoft Word) at a cost of $25.00, shipping included (add $5.00 for overseas airmail). RUSSIA If some observers are perturbed by the ostensible westernization of contemporary Russia and the threat to the distinctiveness of her nationhood, they should look beyond the fitnes-klub and the shopping-tsentr – to the persistent absurdities and paradoxes still deeply characteristic of Russian culture. In Moscow, for example, paradoxes and enigmas abound – to the bewilderment of the Western tourist and to the gratification of the Russianist, all of whom may ask why – 1. the Leningradskoe Highway goes to St. Petersburg; 2. the metro stop for the Russian State Library is still called Lenin Library Station; 3. there are two different stations called “Arbatskaia” on two different metro lines and two different stations called “Smolenskaia” on two different metro lines; 4. -

Romanica XVI-3.Indd
ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA PHILOLOGICA 88 ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA PHILOLOGICA 88 ROMANICA OLOMUCENSIA XVI Numero monografico Dalla letteratura al film (e ritorno) Atti del convegno internazionale Olomouc, 20–21 ottobre 2005 Si ringraziano: Istituto di Cultura Italiana a Praga Orrero, a. s. Facoltà di Teologia dell’Università Palacký di Olomouc e il suo preside uscente doc. Petr Chalupa, Th.D. Ristorante Konvikt 1. vydání Editors © Alessandro Marini, Jiří Špička, Lenka Kováčová, 2006 ISBN 80-244-1439-2 ISSN 0231-634X ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA ROMANICA OLOMUCENSIA XVI – 2006 ISBN 80-244-1439-2 ISSN 0231-634X INDICE Prefazione ......................................................................................................................... 9 RELAZIONE INTRODUTTIVA Nicola Dusi (Università di Modena e Reggio Emilia) Forme, materie e sensorialità nella traduzione intersemiotica: il caso Fanny e Alexander ...............................................................................................13 PROBLEMATICHE, INFLUSSI, RITORNI Lucia Re (University of California, Los Angeles) Il futurismo tra letteratura, guerra, e cinema: Thaïs di A.G. Bragaglia (1917) ...............33 Eusebio Ciccotti (Università di Foggia e Roma Tre) Entrare e uscire dallo schermo: tra letteratura, cinema scritto e cinema ........................ 51 Alfredo Luzi (Università di Macerata) La Notte di Campana: la scrittura come sinergia artistica -

Il Recupero Dell'antico Nell'opera Di Ottorino
SCUOLA DI DOTTORATO IN STORIA E CRITICA DEI BENI ARTISTICI , MUSICALI E DELLO SPETTACOLO XXII CICLO IL RECUPERO DELL’ANTICO NELL’OPERA DI OTTORINO RESPIGHI E L’ARCHIVIO DOCUMENTARIO ALLA FONDAZIONE “GIORGIO CINI” DI VENEZIA Coordinatore: prof. ALESSANDRO BALLARIN Supervisore: prof. ANTONIO LOVATO Dottoranda: MARTINA BURAN DATA CONSEGNA TESI 30 giugno 2010 2 A Riccardo e Veronica 3 4 INDICE PREMESSA ………………………………………..…………………………..……. p. 9 I. IL FONDO “OTTORINO RESPIGHI ” ………………………………………… » 13 1. Configurazione originaria del fondo ………………………………………… » 14 2. Interventi di riordino …………………………………………………………. » 16 3. Descrizione del contenuto ……………………………………………………. » 20 II. RITRATTO DI OTTORINO RESPIGHI ……………………………..……..... » 31 1. L’infanzia e le prime opere …………………………………………………... » 32 2. I primi passi verso il recupero dell’antico …………………………………… » 35 3. L’incontro con Elsa …………………………………………………………... » 38 4. Le trascrizioni di musiche antiche e Casa Ricordi …………………………... » 40 5. Il “periodo gregoriano” ……………………………………………………... » 42 6. L’incontro con Claudio Guastalla …………………………………………… » 44 7. Le opere ispirate al gregoriano ……………………………………………… » 46 8. La nomina all’Accademia d’Italia e il Manifesto…………………………….. » 48 9. La fiamma e l’elaborazione dell’Orfeo ………………………………………. » 53 10. Lucrezia ……………………………………………………………………... » 58 III. IL CONTESTO ………………………………………..………………...……… » 63 1. Il recupero dell’antico ………………………………………………………... » 63 1.1 La rinascita del gregoriano …………………………………………. » 64 1.2 Angelo De Santi, Giovanni Tebaldini e Lorenzo Perosi ……………. -

Choreography#5 : Performance Ed
de - archiving movement research : choreography#5 : performance ed. by Rose Breuss and Claudia Jeschke in cooperation with IDA research lab Francesca Falcone REFORMING DANCE JIA RUSKAJA AND THE ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA Rose Breuss AS IF THERE WERE A NEGATIVE IN THE ARCHIVE TEXTURES OF DOCUMENTATION: A CHOREOGRAPHIC SCORE ON GERTUD BODENEGGER ISBN 978-3-940388- 73-5 © Rose Breuss, Claudia Jeschke, epodium (München) Website: www.epodium.de EMail: [email protected] Alle Rechte vorbehalten/All rights reserved Covergestaltung: Drahtzieher Design & Kommunikaon, Wien Satz: Johannes Novohradsky epodium ist eine eingetragene Marke ISBN 9783940388735 Germany 2019 Reihe dearchiving movement Herausgeber: Rose Breuss, Claudia Jeschke Bibliografische Informaonen Der Deutschen Naonalbibliothek. Die Deutsche Naonalbibliothek verzeichnet diese Publikaon in der Deutschen Naonalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über hp://dnb.ddb.de abruar. Rose Breuss As If There Were a Negative in the Archive Textures of Documentation: A Choreographic Score on Gertrud Bodenwieser Linz, 2018 Choreography and historiography no longer uses the document as “inactive matter through which it attempts to reconstruct what humans have said or done, what is past and of what only a trace remains. It looks for determinations of units, quantities, series, relations in the textures of documentation as such.” 1 The following score applies this concept of documen- tation as a tool for dance specific praxeology, i.e. for artistic exploration and dancers´ agencies. 1 Foucault, Michel: Archäologie des Wissens, Frankfurt am Main 2015, Suhrkamp Verlag, 14. Table of Content P r e l i m i n a r y R e m a r k s / K e y 0: 0.1. -

Tese Maria Joao Castro.Pdf
A Dança e o Poder ou o Poder da Dança: Diálogos e Confrontos no século XX Maria João Castro Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea Dezembro, 2013 1 Ao meu Pai, mecenas incondicional da minha vontade de conhecimento. Ao Pedro, pela cumplicidade do caminho deixando-me respirar... 2 AGRADECIMENTOS Inúmeras pessoas contribuíram de forma decisiva para que esta investigação chegasse a bom termo. O grupo inclui professores, colegas, amigos e desconhecidos que se cruzaram ao longo do projecto e que se dispuseram a ajudar na clareza e compreensão das informações. A primeira expressão de agradecimento cabe à Professora Doutora Margarida Acciaiuoli, por ter aceitado orientar esta tese com todo o rigor, determinação e empenho que a caracterizam, bem como pelo contributo que as suas críticas, sempre pertinentes e cordiais, provocaram na elaboração deste trabalho. A José Sasportes, pela forma como se disponibilizou para co-orientar esta investigação, pela vastíssima informação que me confiou, pelo estímulo e confiança, pela ampliação do campo de referências e pela cumplicidade na partilha da paixão pela dança, o que constituiu um inestimável e insubstituível auxílio. A todos os meus professores de dança com os quais aprendi de variadas maneiras como a dança nos modifica, nomeadamente a Liliane Viegas, João Hydalgo e Myriam Szabo, bem como aos meus colegas a amigos que, de variadíssimas formas, contribuíram para o desenvolvimento deste projecto, nomeadamente a Luísa Cardoso, António Laginha e Miguel Leal. À Vera de Vilhena, pela cuidada revisão do texto e por, com as suas sugestões, me ter ajudado a crescer na escrita. À Fundação para a Ciência e Tecnologia, pela bolsa que me atribuiu, permitindo-me a dedicação exclusiva e a liberdade de poder estar continuamente dedicada a este trabalho. -

Stadttheater / Teatro Civico / Teatro Verdi BOZEN
Hefte zur Bozner Stadtgeschichte, 3. Band STADTTHEATER / TEATRO CIVICO / TEATRO VERDI BOZEN Geschichte eines Theaters an der Grenze (1918–1943) Umschlagbild Nächtliche Ansicht des Teatro Verdi von 1943 Herausgegeben von Massimo Bertoldi und Angela Mura STADTTHEATER / TEATRO CIVICO / TEATRO VERDI BOZEN Stadttheater / Teatro Civico / Teatro Verdi Bozen. Geschichte eines Theaters an der Grenze (1918–1943) war der Titel einer Ausstellung, die, auf Initiative des Assessorats für Kultur, aktives Zusammenleben, Umwelt und Chancengleichheit – Amt für Museen und kunsthistorische Kulturgüter – Stadtarchiv, vom 5. März bis zum 26. Juni 2011 in der Stadtgalerie Bozen stattgefunden hat. Die Ausstellungsleitung und die Koordinierung lagen in den Händen von Massimo Bertoldi und Angela Mura, in Zusammenarbeit mit Silvia Spada; für das Verwaltungssekretariat war Laura Bottesi zuständig; das Ausstellungsprojekt wurde von Roberto Festi erarbeitet, die multimedialen Installationen und Vi- deos von der Magutdesign entworfen und realisiert, das Theatermodell von Lorenzo Nainer ausgeführt; die technologischen Geräte wurden von der Bang & Olufsen, Bozen bereitgestellt; die Übersetzungen ins Deutsche besorgte Wolftraud de Concini; für die grafischen Entwürfe des Werbematerials zeichnete Studio Lupo & Burtscher. Die Kommunikation wurde vom Presseamt der Stadt Bozen betreut. Leihgeber Biblioteca e raccolta teatrale del Burcardo, Rom Brennerarchiv, Innsbruck Gemeinde Pieve di Soligo (TV) Puccini-Theater, Meran Renate Mumelter, Bozen Stadtarchiv, Bozen Stadtmuseum, -
La Danza Nel Futurismo : Giannina Censi E La Danza Moderna Thesis = the Dance of Futurism : Giannina Censi and Modern Dance
博士学位論文(東京外国語大学) Doctoral Thesis (Tokyo University of Foreign Studies) 氏 名 横田 さやか 学位の種類 博士(学術) 学位記番号 博甲第 174 号 学位授与の日付 2013 年 11 月 6 日 学位授与大学 東京外国語大学 博士学位論文題目 未来派の舞踊 -ジャンニーナ・チェンシとモダン・ダンス- Name Yokota, Sayaka Name of Degree Doctor of Philosophy (Humanities) Degree Number Ko-no. 174 Date November 6, 2013 Grantor Tokyo University of Foreign Studies, JAPAN Title of Doctoral La danza nel futurismo : Giannina Censi e la danza moderna Thesis = The Dance of Futurism : Giannina Censi and Modern Dance La danza nel futurismo : Giannina Censi e la danza moderna Sayaka YOKOTA Tokyo University of Foreign Studies PhD Dissertation Sommario Prefazione ........................................................................................................................................ 1 Capitolo I. Il “secondo” futurismo: il problema della periodizzazione ........................................... 5 Capitolo II. La sensibilità corporea di Marinetti ........................................................................... 29 Capitolo III. Danza e futurismo ..................................................................................................... 51 III. 1. Il futurismo attorno alla danza ........................................................................................ 51 III. 2. “Catalisi” tra il futurismo e i Ballets Russes ................................................................... 75 III. 3. Il doppio filone della danza moderna .............................................................................. 99 Illustrazioni -

There Was a Strong Feeling of Backstage Both in the Decoration (Including Ballets Russes Exhibition in London Only Took the Story up to 1914)
200 Jane Pritchard Djaghilev and the Golden Age of the Ballets Russes 1909-1929 201 years dominated by the designs of Bakst and Benois (the last significant There was a strong feeling of backstage both in the decoration (including Ballets Russes exhibition in London only took the story up to 1914). There is working period lights) and the paintings and drawings on the walls. This much less knowledge of the company’s work in the 1920s, so visitors are leads to sections on music and set design. The focus here was on Goncha- less informed about what they might expect to see in the third gallery than rova’s redesigned production of L’oiseau de feu and on the contribution Pa- the first two. In addition several recent major exhibitions at the V&A have blo Picasso made to the Ballets Russes. The Gallery ended with a short film only filled two of the galleries. In Diaghilev there was also almost an hour’s explaining how the V&A acquired much of its collection including footage worth of AV which was integral to the whole and not a simple background of the 1968 Sotheby’s auction and looks at a selection of costumes created add-on. It might also be said that visitors took time to soak up in the back- between 1916 and 1919. stage atmosphere of the exhibition rather than just moving from one exhibit The third gallery returned to a more chronological approach with displays to the next. on Chout, The Sleeping Princess, Le chant du rossignol and Le bal as well as In outline the exhibition began chronologically looking at Diaghilev’s focusing on a handful of key ballets – Les noces, Le train bleu, Pas d’acier, Russia, his early career, and at dance before Diaghilev, the scene in Europe Ode – that stress both the changes in, and a variety of, productions. -

Introduzione Di Fernaldo Di Giammatteo
AIC La storia della cinematografia italiana dal 1895 al 1940 raccontata dagli autori della fotografia (volume 1°) Introduzione di Fernaldo Di Giammatteo ASSOCIAZIONE ITALIANA AUTORI DELLA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA IMAGO AIC AIC AIC • AIC AIC ASSOCIAZIONE ITALIANA AUTORI DELLA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA AIC AIC ASSOCIAZIONE ITALIANA AUTORI DELLA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA AIC Associazione Italiana Autori della Fotografia Membro "Federazione Europea degli Autori della Fotografia Cinematografica" IMAGO AIC costituita il 13 maggio 1950 AIC Presidente Segretario generale Riccardo Grassetti Marcello Gatti Alessandro D'Eva Ennio Guarnieri Marco Incagnoli Vicepresidenti Soci effettivi Luigi Kuveiller Franco Di Giacomo Vittorio Bagnasco Ernesto Lanzi Daniele Nannuzzi Adolfo Bartoli Tonino Maccoppi Giorgio Tonti Eugenio Bentivoglio Gianni Mammolotti Adolfo Troiani Giuseppe Berardini Sandro Mancori Adriano Bernacchi Mauro Marchetti Consiglieri Emilio Bestetti Pasquale Mari Mario Bertagnin Lamberto Caimi Gianni Marras Alessandro D'Eva Maurizio Calvesi Roberto Meddi Franco Di Giacomo Giovanni Cavallini Raffaele Mertes Roberto Girometti Bruno Cascio Marcello Montarsi Giuseppe Lanci Sebastiano Celeste Armando Nannuzzi Daniele Nannuzzi Emilio Della Chiesa Marco Onorato Alessandro Pesci Tonino Delli Colli Pierluigi Piredda Giuseppe Pinori Maurizio Dell'Orco Carlo Poletti Giuseppe Rotunno Danilo Desideri Marco Pontecorvo Sergio Salvati Roberto D'Ettorre - Piazzoli Roberto Reale Vittorio Storaro Carlo Di Palma Charles Rose Giorgio Tonti Dario Di Palma Paolo Rossato Luciano Tovoli Sergio D'Offizi Roberto Salmi Adolfo Troiani Angelo Filippini Luca Santini AICGiuseppe Schifarti Soci onorari Soci sostenitori Gino Sgreva Silvano Agosti A.R.C.O. Due Marco Sperduti Michelangelo Antonioni Dante Spinotti Gianfranco Borgiotti Arri Italia Antonio Carletti Renato Tafuri Mario Ceroli Cartocci F.lli S.r.l. Gianfranco Transunto Henrik Chroscicki Mario Vulpiani Giuseppe Filardi Cartoni S.p.a. -

Ottorino Respighi Vs. Sergei Diaghilev: a Study of the Sources for La Boutique Fantasque, Le Astuzie Femminili, La Serva Padrona
Opera or Ballet? Ottorino Respighi vs. Sergei Diaghilev: a Study of the Sources for La boutique fantasque, Le astuzie femminili, La serva padrona Elia Andrea Corazza Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca”, Vibo Valentia The Fondo Ottorino Respighi was established at the Fondazione Giorgio Cini in Venice in 1967 following a donation made by the composer’s widow, Elsa Olivieri-Sangiacomo.1 This collection brings together a considerable amount of manuscripts, scores, books, letters and photographs, along with a few instruments that belonged to the maestro and his wife. A study of the materials conserved therein is fundamental for any study dedicated to this composer. This article focuses on Ottorino Respighi’s collaboration with Sergei Diaghilev, which between 1917 and 1920 led to the birth of three ballets: La boutique fantasque (1919, Rossini – Respighi), Le astuzie femminili (1920, Cimarosa – Respighi) and La serva padrona (1920, Paisiello – Respighi). The work is aimed at filling a gap in academic research, whether music or dance studies, given that little or nothing had been published on their common artistic endeavours, in spite of the great success of La boutique fantasque and Le astuzie femminili (which later became Ballet de l’astuce feminine and Cimarosiana), both of which count among the ballets most often performed by the Ballets Russes. In particular, this essay is intended to clarify the extent of Respighi’s contribution to the aesthetic turn towards neoclassicism endorsed by Diaghilev’s 1 ARCHIVAL NOTES Sources and Research from the Institute of Music, No. 2 (2017) © Fondazione Giorgio Cini, Venezia ISSN 2499–832X | ISBN 9788896445167 ELIA ANDREA CORAZZA Ballets Russes following the First World War, when they broke away from nineteenth-century music and turned instead to eighteenth-century, pre-classical models and stylistic traits. -

LA FENICE 1792-1996 Il Teatro> La Musica> Il Pubblico> !>Impresa
Anna Laura Bellina Michele Girardi LA FENICE 1792-1996 Il teatro> la musica> il pubblico> !>impresa ricerca iconografica di Maria Ida Biggi Marsilio INDICE I BAGLIORI DELL'ANTICO REGIME LA FENICE NEL MONDO: REPERTORIO, E LA FENICE DEL RISORGIMENTO AVANGUARDIE, RETROGUARDIE, FIAMME Anna Laura Bellina Michele Girardi Dallo sfratto del San Benedetto al giuramento dei delegati (1787-1798) 125 La Fenice, luogo fatale 7 I <<Semplici lumi» del Memmo Giorgio Tinazzi Cesare De Michelis 126 Tra guerre inutili e felici incontri (1897-1915) 12 La Fenice è una bella macchina Manlio Brusatin 135 Fino a Salò (1920-1945) 24 Dalla prima dominazione asburgica al congresso 154 La Fenice «in progress» (1945-1959) di Vi enna (1798-181 5) 156 <<Una Fenice che mai seppe aedo l idoleggiare» 31 Un secolo di gloria Giovanni Morelli Sergio Sega lini 167 Stagioni d'oro (1959-1979) 38 Dalla seconda dominazione asburgica al restauro (1815-1828) 168 Il mio primo incontro con La Fenice Giorgio Pestelli 49 La scenogra/ia alla Fenice nell'Ottocento Maria Ida Biggi 173 Maderno e Nono alla prova del teatro Veniero Rizzardi 50 Dal restauro all'incendio (1828-1836) 183 La scenogra/ia alla Fenice nel Novecento Maria Ida Biggi 62 Dalla ricostruzione alla repubblica di San Marco (1836-1849) 191 « Vers la flarnrne» (1979-1996) Bo Il decoro della Fenice come mito e come techne 194 Il <<viaggio iniziatico» di Giuseppe Sinopoli Francesco Amendolagine Mario Messinis 87 Dalla prima alla seconda guerra di indipendenza (1849-1859) 205 La Fenice 1996 102 Dalla terza guerra d'indipendenza