03.Spacont49.Branciforte.3A Bozza:03.Spacont47.Novarino.1A
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Archivio Centrale Dello Stato Inventario Del Fondo Ugo La Malfa Sala Studio
Archivio centrale dello Stato Inventario del fondo Ugo La Malfa Sala Studio INVENTARIO DEL FONDO UGO LA MALFA (1910 circa – 1982) a cura di Cristina Farnetti e Francesca Garello Roma 2004-2005 Il fondo Ugo La Malfa è di proprietà della Fondazione Ugo La Malfa, via S.Anna 13 – 00186 Roma www.fondazionelamalfa.org [email protected] Depositato in Archivio centrale dello Stato dal 1981 Il riordino e l’inventariazione è stato finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi II INDICE GENERALE INTRODUZIONE .................................................................................................V INVENTARIO DEL FONDO ............................................................................ XI SERIE I. ATTI E CORRISPONDENZA...............................................................1 SERIE II ATTIVITÀ POLITICA .........................................................................13 SOTTOSERIE 1. APPUNTI RISERVATI 50 SERIE III. CARICHE DI GOVERNO ................................................................59 SOTTOSERIE 1. GOVERNI CON ORDINAMENTO PROVVISORIO (GOVERNO PARRI E I GOVERNO DE GASPERI) 61 SOTTOSERIE 2. MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO (VI GOVERNO DE GASPERI) 63 SOTTOSERIE 3. MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO (VI E VII GOVERNO DE GASPERI) 64 SOTTOSERIE 4. MINISTRO DEL BILANCIO (IV GOVERNO FANFANI) 73 SOTTOSERIE 5. MINISTRO DEL TESORO (IV GOVERNO RUMOR) 83 SOTTOSERIE 6. VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO (IV GOVERNO MORO) 103 SOTTOSERIE 7. FORMAZIONE DEL GOVERNO E VICEPRESIDENTE -

Esercitati GRATIS On-Line! N
N. Domanda A B C D 885 DA CHI ERA COMPOSTO IL SERRISTORI, RICASOLI, PERUZZI, GUERRAZZI, LAMBRUSCHINI, GOVERNO PROVVISORIO RIDOLFI, CAPPONI PUCCIONI MONTANELLI, GIORGINI, MORDINI TOSCANO PROCLAMATO L'8 MAZZONI FEBBRAIO 1849 IN SEGUITO ALLA FUGA DA FIRENZE DI LEOPOLDO II? 886 NEL MARZO 1849, DURANTE LA A NOVARA A MONCALIERI A MAGENTA A CUSTOZA SECONDA FASE DELLA PRIMA GUERRA DI INDIPENDENZA, IN QUALE LOCALITA' LE TRUPPE DEL REGNO DI SARDEGNA FURONO SCONFITTE DALLE TRUPPE AUSTRIACHE? 887 IN QUALE LOCALITA' VITTORIO A VIGNALE A VILLAFRANCA A CUSTOZA A NOVARA EMANUELE II ACCETTO' LE CONDIZIONI ARMISTIZIALI DEL FELDMARESCIALLO RADETZKY? 888 QUALE TRA I SEGUENTI FRANCESCO CARLO PISACANE SILVIO PELLICO DANIELE MANIN PERSONAGGI PRESE PARTE ALLA DOMENICO DIFESA DI ROMA NEL 1849? GUERRAZZI 889 IN SEGUITO ALLA RESA DELLA PORTARE AIUTO PORTARE AIUTO AL ATTACCARE I ASSEDIARE PIO IX REPUBBLICA ROMANA, CON ALLA DIFESA DI GOVERNO FRANCESI A A GAETA QUALE OBIETTIVO GARIBALDI, VENEZIA PROVVISORIO CIVITAVECCHIA INSIEME A 4000 UOMINI, LASCIO' TOSCANO ROMA? 890 CHI E' L'AUTORE DELL'OPUSCOLO GIUSEPPE GIUSEPPE GIUSTI GIUSEPPE FERRARI GIUSEPPE MAZZINI "LA FEDERAZIONE MONTANELLI REPUBBLICANA", PUBBLICATO A CAPOLAGO NEL 1851? 891 QUALI POTENZE INTERRUPPERO SPAGNA E PRUSSIA E RUSSIA E IMPERO FRANCIA E LE RELAZIONI DIPLOMATICHE CON PORTOGALLO AUSTRIA OTTOMANO INGHILTERRA IL REGNO DELLE DUE SICILIE NEL 1856? 892 QUALE DIPLOMATICO SABAUDO EMILIO VISCONTI LUIIG AMEDEO COSTANTINO LUIGI PRINETTI COLLABORO' IN MODO DECISIVO VENOSTA MELEGARI NIGRA CON CAVOUR NELLE TRATTATIVE -

Italy's Atlanticism Between Foreign and Internal
UNISCI Discussion Papers, Nº 25 (January / Enero 2011) ISSN 1696-2206 ITALY’S ATLANTICISM BETWEEN FOREIGN AND INTERNAL POLITICS Massimo de Leonardis 1 Catholic University of the Sacred Heart Abstract: In spite of being a defeated country in the Second World War, Italy was a founding member of the Atlantic Alliance, because the USA highly valued her strategic importance and wished to assure her political stability. After 1955, Italy tried to advocate the Alliance’s role in the Near East and in Mediterranean Africa. The Suez crisis offered Italy the opportunity to forge closer ties with Washington at the same time appearing progressive and friendly to the Arabs in the Mediterranean, where she tried to be a protagonist vis a vis the so called neo- Atlanticism. This link with Washington was also instrumental to neutralize General De Gaulle’s ambitions of an Anglo-French-American directorate. The main issues of Italy’s Atlantic policy in the first years of “centre-left” coalitions, between 1962 and 1968, were the removal of the Jupiter missiles from Italy as a result of the Cuban missile crisis, French policy towards NATO and the EEC, Multilateral [nuclear] Force [MLF] and the revision of the Alliance’ strategy from “massive retaliation” to “flexible response”. On all these issues the Italian government was consonant with the United States. After the period of the late Sixties and Seventies when political instability, terrorism and high inflation undermined the Italian role in international relations, the decision in 1979 to accept the Euromissiles was a landmark in the history of Italian participation to NATO. -

Scelba, Mario
Scelba, Mario S. nacque a Caltagirone, in provincia di Catania, nel 1901. Sin da giovane si avvicinò al movimento cattolico, in particolare all’esponente di punta del neonato Partito popolare, don Luigi Sturzo, di cui divenne nel primo dopoguerra uno stretto collaboratore. Ostile al fascismo, come altri giovani esponenti del PPI, visse con amarezza la decisione di vari esponenti popolari di allinearsi al fascismo, nonché il cauto atteggiamento assunto dalla Chiesa cattolica nei confronti del regime. Durante gli anni della dittatura decise di rinunciare a un’attività politica aperta. Nel 1942 fu comunque uno dei primi esponenti cattolici a favorire la nascita nella clandestinità del nuovo partito che avrebbe assunto il nome di Democrazia cristiana (DC). Fin dalle prime fasi di vita della DC S. si collocò su moderate una linea moderata; le sue posizioni si rifacevano a quelle espresse da Alcide De Gasperi, tanto da essere nominato nel 1944, in occasione del primo congresso democristiano tenutosi a Napoli, vicesegretario del partito. Con la formazione del governo guidato da Ferruccio Parri, il ruolo di S. quale esponente di rilievo della DC era confermato dalla sua nomina a ministro delle Poste e Telecomunicazioni, incarico che egli mantenne nei due governi, guidati da De Gasperi tra la fine del 1945 e il 1946. In quest’ultimo anno S. veniva eletto all’Assemblea costituente e nel 1948 sarebbe divenuto deputato, restando membro dell’assemblea di Montecitorio sino al 1968 (da quell’anno fino al 1979 avrebbe ricoperto il ruolo di senatore). Nel 1947, con la fine dell’esperienza di coalizione antifascista e con l’uscita dal governo del Partito comunista italiano (PCI) e del Partito socialista italiano (PSI), De Gasperi formava un primo governo centrista, che avrebbe tra l’altro dovuto affrontare la difficile prova delle prime elezioni politiche dell’Italia repubblicana nell’aspro clima di scontro, accentuato dall’emergere della Guerra fredda. -

Le Elezioni Del 1948, La Democrazia Cristiana Ei Manifesti Elettorali
Il sacro come strumento politico: le elezioni del 1948, la Democrazia Cristiana e i manifesti elettorali Rosaria Leonardi Quale significato assunsero le elezioni del 18 aprile 1948? Come vennero lette e interpretate dalla Democrazia Cristiana, dalla Chiesa e dalle organizzazioni cattoliche? Per quale motivo andò costituendosi un connubio tra loro e perché esso venne ritenuto indispensabile per le sorti del paese e del partito? Quali strumenti vennero usati nella campagna elettorale democristiana? Le elezioni del 18 aprile 1948 furono uno spartiacque della storia repubblicana che sancì la fine del dopoguerra, consacrò la Democrazia Cristiana quale partito di governo per i successivi quarant’anni e definì il sistema all’interno del quale avrebbero dovuto scriversi e svolgersi le vicende politiche e socioeconomiche dello Stato: l’Occidente con le sue libertà, il suo liberismo, i suoi valori. Il 18 aprile 1948, il popolo italiano non fu dunque chiamato a scegliere solo fra due coalizioni politiche ma fra due diversi modelli di civiltà. Si trattò di una guerra ideologica durante la quale, come è stato ampiamente rilevato in numerosi e validissimi contributi, vennero raggiunti livelli di drammaticità cui mai si sarebbe arrivati nella storia repubblicana.1 Tale drammaticità scaturì soltanto dalla estrema lotta politica cui si assistette in quei mesi o altre forze entrarono in gioco durante quella tornata elettorale? Come vedremo, tale drammaticità non fu la conseguenza solo del contrapporsi di due modelli politici antitetici ma fu generata, soprattutto, dallo stretto rapporto che si stabilì tra partito democristiano, Chiesa e organizzazioni cattoliche. Tale legame nacque per scongiurare la vittoria del fronte socialcomunista e per garantire alla Democrazia Cristiana (DC) e alla coalizione che capeggiava un largo successo, ma ebbe come conseguenza la trasformazione della competizione elettorale in uno scontro di civiltà. -

Aldo Moro E L'apertura a Sinistra: Dalla Crisi Del Centrismo Al Centro-Sinistra
1 Dipartimento di Scienze Politiche Cattedra di Teoria e Storia dei Partiti e dei Movimenti Politici ALDO MORO E L’APERTURA A SINISTRA: DALLA CRISI DEL CENTRISMO AL CENTRO-SINISTRA ORGANICO RELATORE CANDIDATO Prof. Andrea Ungari Mirko Tursi Matr. 079232 ANNO ACCADEMICO 2017/18 2 3 INDICE INTRODUZIONE 4 CAPITOLO PRIMO LA CRISI DEL CENTRISMO E L’ASCESA DI MORO NEL PANORAMA POLITICO ITALIANO (1953-1959) 6 1.1 La presidenza del gruppo parlamentare della Dc e la prima apertura ai socialisti 6 1.2 L’elezione di Gronchi alla presidenza della RepubbliCa e la marCia di avvicinamento tra Dc e Psi 9 1.3 Le elezioni politiche del 1958 e l’elezione di Moro a segretario della DC 11 1.4 Il Congresso di Firenze e l’autonomia del partito dalle gerarchie ecclesiastiche 16 CAPITOLO SECONDO LA NASCITA DEL PRIMO GOVERNO DI CENTRO-SINISTRA ORGANICO (1960-1963) 23 2.1 L’ultimo governo di centro-destra e il passaggio al governo delle “convergenze parallele” 23 2.2 Le prime giunte di centro-sinistra e la difficile preparazione all’incontro ideologico tra cattolici e soCialisti 31 2.3 Il Congresso di Napoli ed il programma riformatore del quarto governo Fanfani 35 2.4 Le elezioni politiche del 1963 e la nascita del primo governo di centro-sinistra organico guidato da Moro 44 CAPITOLO TERZO IL DECLINO DELLA FORMULA DI CENTRO-SINISTRA (1964-1968) 53 3.1 La crisi politica del 1964 ed il tormentato avvio del II Governo Moro 53 3.2 L’elezione di Saragat alla presidenza della Repubblica e l’irreversibilità della formula di centro-sinistra 63 3.3 Il III Governo Moro e l’unificazione socialista 70 3.4 La tornata elettorale del 1968: fine dell’esperienza di centro-sinistra 76 CONCLUSIONE 83 ABSTRACT 86 BIBLIOGRAFIA 87 4 INTRODUZIONE Il periodo storiCo Che si estende dal 1953 al 1968 rappresenta un unicum all’interno della politiCa italiana e CostituisCe uno dei temi più affasCinanti della storia della Prima RepubbliCa. -

Denominazione Codice Discrizione Scopo Sedeente OPERA
Denominazione Codice DIscrizione Scopo SedeEnte OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI 1 15/01/1940 EDUCAZIONE FIGLI DEGLI AVIATORI (ORFANI) ROMA - VIALE DELL'UNIVERSITA' N°4 FONDAZIONE DI ASSISTENZA E SOLIDARIETA' - ONLUS 1 21/01/1995 ASSISTENZA SOCIALE ROMA - VIA NAZIONALE N°91 FONDAZIONE TERZO PILASTRO - ITALIA E MEDITERRANEO (scissa in: Fondazione terzo pilastro Internazionale iscritta CULTURALE PER PROMUOVERE SOSTENERE E 1 04/01/1996 ROMA - VIA MARCO MINGHETTI N°17 al n.1275/2018 e nella Fondazione Cultura ed Arte iscritta DIFFONDERE L'IDEA DI IMPRESA SOCIALE ECC. al n.1276/2018) CASSA UFFICIALI 1 07/01/1998 SOVVENZIONE PENSIONI INTEGRATIVE ROMA - VIA MARSALA N°104 PARROCCHIA S. ENRICO 1 13/01/1999 RELIGIONE E CULTO ROMA - VIALE RATTO DELLE SABINE N°7 CONGREGAZIONE DELLE PIE DISCEPOLE DEL DIVIN 1 10/01/2000 RELIGIONE E CULTO ROMA - VIA GABRIELE ROSSETTI N°17 MAESTRO FINALITA' EDUCAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE ROMA - CIRCONVALLAZIONE CLODIA MISSIONE EDUCATIVA CONDIVISA (M.E.C.) 1 19/04/2001 BAMBINI RAGAZZI ADULTI SENZA N°163/171 INT.2 DISCRIMINAZIONI FONDAZIONE EDOARDO AGNELLI 2 15/01/1940 BORSE DI STUDIO A FIGLI DI AVIATORI ROMA - VIALE UNIVERSITA' N. 4 FONDAZIONE "ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE" PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA ECONOMICA PROMUOVERE E DIFFONDERE LA CULTURA 2 23/01/1995 ROMA - VIA NERVA N.1 (trasformata in S.r.l.) (CANCELLATA IN DATA 4 GIUGNO ECONOMICA 2019) FONDO NAZIONALE DI GARANZIA 2 05/01/1996 TUTELA AGENTI DI CAMBIO ROMA - VIA GIACOMO PUCCINI, N°9 PROMUOVERE E FAVORIRE LA RICERCA TECNICO- SCIENTIFICA NEL CAMPO DELL'UROLOGIA LO SOCIETA' ITALIANA DI UROLOGIA 2 16/01/1998 ROMA - VIA GIOVANNI AMENDOLA N°46 SVILUPPO ED IL CORRETTO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE UROLOGICA FONDAZIONE LEONE CAETANI 2 15/01/1999 CONOSCENZA DEL MONDO MUSULMANO ROMA - VIA DELLA LUNGARA N.10 LOGOS INC. -
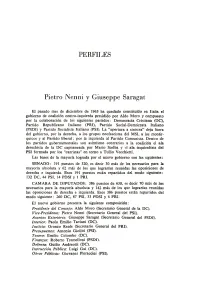
PERFIJ.,ES Pietro N Enni Y Giuseppe Saragat
PERFIJ.,ES Pietro N enni y Giuseppe Saragat El pasado mes de diciembre de 1963 ha quedado constituído en Italia el gobierno de coalición centro-izquierda presidido por Aldo Moro y compuesto por la colaboración de los siguientes partidos: Democracia Cristiana (DC), Partido Republicano Italiano (PRI), Partido Social-Demócrata Italiano (PSDI) y Partido Socialista Italiano (PSI). La "apertura a sinistra" deja fuera del gobierno, por la derecha, a los grupos neofascistas del MSI, a los monár quicos y al Partido liberal; por la izquierda al Partido Comunista. Dentro de los partidos gubernamentales son asimismo contrarios a la coalición el ala derechista de la DC capitaneada por Mario Scelba y el ala izquierdista del PSI formada por los "carristas" en tomo a Tullio Vecchietti. Las bases de la mayoría lograda por el nuevo gobierno son las siguientes: SENADO: 191 puestos de 320, es decir 30 más de los necesarios para la mayoría absoluta y 62 más de los que lograrían reunidas las oposiciones de derecha e izquierda. Esos 191 puestos están repartidos del modo siguiente: 132 DC, 44 PSI, 14 PDSI y 1 PRI. CAMARA DE DIPUTADOS: 386 puestos de 630, es decir 70 más de los necesarios para la mayoría absoluta y 142 más de los que lograrían reunidas las oposiciones de derecha e izquierda. Esos 386 puestos están repartidos del modo siguiente: 260 DC, 87 PSI, 33 PDSI y 6 PRI. El nuevo gobierno presenta la siguiente composición: Presidente del Consejo: Aldo Moro (Secretario General de la DC). Vice-Presidente: Pietro Nenni (Secretario General del PSI). Asuntos Exteriores: Giuseppe Saragat (Secretario General del PSDI). -

Elezione Del Presidente Della Repubblica
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Indice ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA La Costituzione della Repubblica Italiana: norme che riguardano l’elezione del Presidente della Repubblica ..............pag. 5 Elezione dei delegati delle Regioni per l’elezione del Presidente della Repubblica ...........................................................................................pag. 13 Elenco delle legislature della Repubblica Italiana .......................................pag. 15 Dati sintetici delle elezioni del Presidente della Repubblica .......................pag. 16 I Presidenti della Repubblica – scrutinii ed elezioni - Enrico DE NICOLA...........................................................................pag. 19 - Luigi EINAUDI .................................................................................pag. 21 - Giovanni GRONCHI..........................................................................pag. 24 - Antonio SEGNI..................................................................................pag. 27 - Giuseppe SARAGAT.........................................................................pag. 32 - Giovanni LEONE...............................................................................pag. 43 - Sandro PERTINI ................................................................................pag. 54 - Francesco COSSIGA .........................................................................pag. 64 - Oscar Luigi SCALFARO...................................................................pag. 66 -

PDF Cliccando
Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche Università Cattolica del Sacro Cuore 2 2 011 Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche Università Cattolica del Sacro Cuore Anno I - 2/2011 Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 355 del 27.06.2011 Direttore responsabile Massimo de Leonardis Comitato editoriale Romeo Astorri, Paolo Colombo, Massimo de Leonardis (Direttore), Ugo Draetta, Vittorio Emanuele Parsi, Valeria Piacentini Fiorani Segretario di redazione Gianluca Pastori I Quaderni sono liberamente scaricabili dall’area web agli indirizzi www.educatt/libri/QDSP e http:// dipartimenti.unicatt.it/scienze_politiche_1830.html È possibile ordinare la versione cartacea: on line all’indirizzo www.educatt.it/libri; tramite fax allo 02.80.53.215 o via e-mail all’indirizzo [email protected] (una copia € 15; abbonamento a quattro numeri € 40). Modalità di pagamento: – bonifi co bancario intestato a EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio dell’Università Cattolica presso Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo - IBAN: IT 06 W 03309 03200 211609500166; – bonifi co bancario intestato a EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio dell’Università Cattolica presso Monte dei Paschi di Siena- IBAN: IT 08 D 01030 01637 0000001901668; – bollettino postale intestato a EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio dell’Università Cattolica su cc. 17710203 © 2011 EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università Cattolica Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.7234.22.35 - fax 02.80.53.215 e-mail: [email protected] (produzione); [email protected] (distribuzione) web: www.educatt.it/libri ISBN: 978-88-8311-879-1 ISSN: 2239-7302 In copertina: Martin Waldseemller (1470 ca.-post 1522), Mappa della terra, 1507. -

Florence February 2016 Piero Malvestiti
Florence February 2016 Piero Malvestiti © European University Institute - Historical Archives of the European Union, 1994-2016 Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged, save where otherwise stated. Where prior permission must be obtained for the reproduction or use of textual and multimedia information (sound, images, software, etc.), such permission shall cancel the abovementioned general permission and indicate clearly any restrictions on use. More informations about Terms and Conditions of Use Historical Archives of the European Union 2 Piero Malvestiti Table of contents Piero Malvestiti ______________________________________________________________________________________________5 Prima guerra mondiale, antifascismo e Resistenza ___________________________________________________________6 Esilio in Svizzera, Resistenza e Repubblica dell'Ossola _________________________________________________________7 Corrispondenza del periodo clandestino ______________________________________________________________ 10 Stampa del periodo clandestino _____________________________________________________________________ 11 Attività politica e pubblicistica del secondo dopoguerra _____________________________________________________ 12 Sottosegretario alle Finanze (governo De Gasperi IV) _______________________________________________________ 17 Sottosegretario al Tesoro (governi De Gasperi V e VI) _______________________________________________________ 17 Comitato IMI-ERP ________________________________________________________________________________ -

I GOVERNI ITALIANI ( 25 Luglio 1943 - 6 Agosto 1970)
Settembre- Ottobre 1970 756. Governi 1943-1970 I GOVERNI ITALIANI ( 25 luglio 1943 - 6 agosto 1970) DALLA CADUTA DEL FASCISMO ALLA ASSEMBLEA COSTITUENTE 0 I• MINISTERO BADOGLIO (25 Luglio 1943 - 17 aprile 1944) ( ) Pr esid. Consiglio: PIETRO BADOGLIO - Affari Ester i: RAFFAELE GUA RIGLIA - PIETRO BADOGLIO - Interno: UMBERTO RICCI - VITO R.EALE - Africa italiana: MELCHIADE GABBA - PIETRO BADOGLIO - Giustizia: GAETANO AZZARITI - ETTORE CASATI - F inanze: DOMENI CO BARTOLINI - GUIDO JUNG - Guerra: ANTONIO SORICE - TADDEO ORLANDO -Marina: RAFFAELE DE COURTEN -Aeronautica: RENATO SANDALLI - Educazione Nazionale: LEONARDO SEVERI - GIOVANNI CUOMO - Lavori Pubblici: ANTONIO ROMANO- RAFFAELE DE CARO - Agricoltura e Foreste: ALESSANDRO BRIZI - FALCONE LUCIFERO - Co mtmicazioni: FEDERICO AMOROSO - TOMMASO SICILIANI - I ndustr ia, Commercio e Lavoro: LEOPOLDO PICCARDI - EPICARMO CORBINO - Cultura popolare: CARLO GALLI - GIOVANNI CUOMO - Scambi e Valute: GIOVANNI ACANFORA- GUIDO JUNG - Produzione bellica: CARLO FA V AGROSSA - Alto commissario per la Sardegna: PINNA - Alto commissa rio per la Sicilia: FRANCESCO MUSOTTO - Alto commissario per l'epum zlone nazionale: TITO ZANffiONI - Commissario generale per l'alimenta zione: CAMll;RA. n• MINISTERO BADOGLIO (22 aprile 1944 - 18 giugno 1944) P·resid. Consiglio: PIETRO BADOGLIO - Ministri senza portafoglio: BE NEDETTO CROCE, CARLO SFORZA, GIULIO RODINO, PIETRO MANCI NI, PALMIRO TOGLIATTI - Esteri: PIETRO BADOGLIO - Interno: SAL VATORE ALDISIO • Africa italiana: PIETRO BADOGLIO - Giustizia : VINCENZO ARAN·GIO-RUIZ - Finanze: QUINTO QUINTIERI - Guer ra : TADDEO ORLANDO - Marina: RAFFAELE DE COURTEN - Aeronautica: RENATO SANDALLI - Pubblica Istruzione: ADOLFO OMODEO - Lavori Pubblici: ALBERTO TARCHIANI - Agricoltura e Foreste: FAUSTO GUL LO - Comunicazioni: FRANCESCO CERABONA - I ndustria e Commercio: ATTILIO DI NAPOLI - ALto commissario per le sanzioni contro iL fasci smo: CARLO SFORZA - Alto commissario per l'assistenza morale e mate riale dei profughi di guerra: TITO ZANIBONI.