Marcello Aprile – Francesco G
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

M F M F M F M F M F M F M F M F Acquarica Del Capo 87 71 105 90
Tabella 4 - Popolazione residente al 1/1/2019 per sesso, classe di età e comune della provincia di Lecce Classe di età Comune 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 M F M F M F M F M F M F M F M F Acquarica del Capo 87 71 105 90 114 98 118 129 148 123 149 148 133 117 116 116 Alessano 114 106 132 101 161 154 203 155 195 160 184 201 162 175 192 187 Alezio 122 101 131 144 161 137 145 143 154 130 128 134 138 130 169 199 Alliste 130 105 136 141 173 162 195 175 185 186 197 196 177 181 208 223 Andrano 86 72 80 86 91 104 135 97 156 134 162 153 133 99 130 119 Aradeo 184 151 190 205 259 213 220 229 242 236 253 270 261 276 311 300 Arnesano 86 66 109 103 121 111 122 104 107 91 115 95 122 129 135 109 Bagnolo del Salento 42 27 27 22 43 40 49 52 55 50 47 52 47 49 46 46 Botrugno 45 51 61 46 45 49 65 63 67 79 64 69 75 68 67 87 Calimera 109 116 158 153 160 157 140 160 165 154 148 167 160 164 201 193 Campi Salentina 173 153 210 203 245 230 265 269 279 242 303 250 283 292 295 336 Cannole 24 22 39 27 48 33 47 47 39 34 33 36 37 37 43 53 Caprarica di Lecce 36 28 68 49 53 38 56 47 50 44 57 62 60 59 59 79 Carmiano 216 220 278 257 277 282 300 261 304 294 365 359 340 313 388 405 Carpignano Salentino 56 71 69 61 89 83 81 80 68 64 112 83 108 110 106 107 Casarano 387 380 462 439 479 474 570 517 573 569 525 531 548 555 635 635 Castri di Lecce 44 45 65 50 57 50 87 74 107 64 72 85 76 79 87 81 Castrignano de' Greci 62 48 64 60 73 61 81 85 117 111 109 100 104 97 123 112 Castrignano del Capo 97 68 72 84 127 117 139 90 135 121 155 145 140 121 143 126 Castro 21 25 32 -

Dpgr 23 04 2018
REGIONE PUGLIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA N. 2\A? del Registro OGGETIO: Autorizzazione alla A.S.D. C. "Amici del Velodromo" di Monteroni di Lecce (LE) ad effettuare la manifestazione ciclistica in mountain bike specialità Marathon denominata: "2~ Marathon Cicli Manca- Punto Rosso Wilier", che si terrà il 29 aprile 2018. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE: VISTO il decreto legislativo 15/1/2002 n· 9 art. 2; VISTA la Legge l agosto 2002, n· 168; VISTO l'Art. 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n· 285; VISTO il disciplinare delle Scorte Tecniche alle competizioni ciclistiche su strada approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002 (G.U. n· 29 del 5 febbraio 2003); VISTA l'istanza acquisita agli atti prot. n. 1173 del 20/03/2018 con la quale la A.S.D. C. Amici del Velodromo, con sede in Monteroni di Lecce (LE) Via Unità d'Italia n. 50, chiede l'autorizzazione ad effettuare una manifestazione ciclistica in mountain bike specialità Marathon per il giorno 29 aprile 2018, denominata "2~ Marathon Cicli Manca- Punto Rosso Wilier"; PRESO ATIO che la suddetta gara interesserà i Comuni di Martignano, Calimera, Sternatia, Caprarica di Lecce e San Donato di Lecce; VISTI i nulla asta/autorizzazioni degli Enti proprietari delle strade interessate dal percorso: Comune di Martignano, Comune di Calimera, Comune di Sternatia, Comune di Caprarica di Lecce, Comune di San Donato di Lecce e Provincia di Lecce; VISTO il certificato di assicurazione della società organizzatrice della manifestazione per la R.C. allegato all'istanza di cui sopra; www.regione.puglia.it •••••• REGIONE PUGLIA RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinata mente alla osservanza delle sottoindicate prescrizioni; AUTORIZZA La A.S.D. -

Progetto Esecutivo
AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE ARCA SUD SALENTO Via Trinchese 61/D Galleria 73100 LECCE PROGETTO ESECUTIVO ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO E.R.P. DI A.R.C.A. SUD SALENTO NELLA PROVINCIA DI LECCE Finanziamento: fondi A.R.C.A. Sud Salento C.I.G.: 7029350320 - C.U.P.: I64B17000000005 ELAB. 11 PROGETTO: Elenco Fabbricati Esclusiva Proprietà SCALE: AGG.TO: REV_00 DATA: Marzo 2017 PROT. IL RESPONSABILE DI P.O. PROGETTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO Ing. Giovanni MATTEI Ing. Giovanni MATTEI Ing. Salvatore CANDIDO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Enrico ALBANESE Geom. Carmelo MARTALO' IL DIRIGENTE DEL IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN SERVIZIO PROGETTAZIONE FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Enrico ALBANESE Geom. Raffaele TONDO ELENCO FABBRICATI DI ESCLUSIVA PROPRIETA' ARCA SUD SALENTO COMUNE TIPO IBU COD.IBU PROG INDIRIZZO ED LOCALITA' ALESSANO ED 01005 1 VIA 2 NOVEMBRE 21 ALESSANO ED 01008 1 VIA 2 NOVEMBRE 55 ALESSANO ED 01018 1 VIA TRIESTE 84 MONTESARDO ALESSANO ED 01635 1 VIA DEI CADUTI FABBR. 2 110 ALESSANO ED 01636 1 VIA TRAV.DEI CADUTI 109 ALESSANO ED 01637 1 VIA NAZIONALE 260 MONTESARDO ALESSANO ED 05050 1 VIA TRAV.DEI CADUTI 43 ALESSANO ED 05051 1 VIA PADRE BONAVENTURA 24 ALESSANO ED 05052 1 VIA NAZIONALE 264 MONTESARDO ALESSANO ED 05158 1 VIA NAZIONALE 65 MONTESARDO ALESSANO ED 05254 1 VIA PADRE BONAVENTURA SNC A ALEZIO ED 01028 1 VIA CARSO 1 ALEZIO ED 01029 1 VIA PERTINI 11 ALLISTE ED 01032 1 VIA 25 APRILE 9 ALLISTE ED 01033 1 VIA 25 APRILE 5 ALLISTE ED 01034 1 PROLUNGAMENTO VIA TRIESTE 51 ALLISTE ED 01035 1 VIA LECCE SNC FELLINE ANDRANO ED 01036 1 VIA RAFFAELLO SANZIO 40 ARADEO ED 01046 1 VIA MATTARELLA 9 ARADEO ED 01047 1 VIA DALLA CHIESA 3 ARADEO ED 01048 1 VIA DALLA CHIESA 2 ARADEO ED 01049 1 VIA LA TORRE 2 ARADEO ED 01050 1 VIA MATTARELLA 1 ARADEO ED 01051 1 VIA MATTARELLA 7 ARADEO ED 01380 1 VIA MATTARELLA 11 ARADEO ED 01381 1 VIA MATTARELLA 13 ARADEO ED 01382 1 VIA DALLA CHIESA 4 F2 ARADEO ED 01383 1 VIA DALLA CHIESA 5 F.3 ARADEO ED 05230 1 VIA G. -
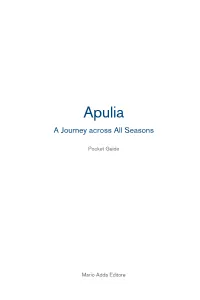
Apulia a Journey Across All Seasons
Apulia A Journey across All Seasons Pocket Guide Mario Adda Editore Regione Puglia AreA Politiche Per lA Promozione del territorio, dei sAPeri e dei tAlenti Servizio Turismo – Corso Sonnino, 177 – cap 70121 Bari Tel. +39 080.5404765 – Fax +39 080.5404721 e-mail: [email protected] www.viaggiareinpuglia.it Text: Stefania Mola Translation: Christina Jenkner Photographs: Nicola Amato and Sergio Leonardi Drawings: Saverio Romito Layout: Vincenzo Valerio ISBN 9788880829362 © Copyright 2011 Mario Adda Editore via Tanzi, 59 - Bari Tel. e fax +39 080 5539502 www.addaeditore.it [email protected] Contents A Journey across All Seasons ....................................................pag. 7 A History ............................................................................................ 9 Buried Treasures ....................................................................................... 11 Taranto’s Treasure ........................................................................ 12 Egnazia ....................................................................................... 12 The Bronzes of Brindisi ............................................................... 13 The Vases of Ruvo ....................................................................... 13 Between Legend and Reality on the Hill of Cannae ....................... 14 Ostuni – Pre-Classical Civilizations ............................................... 14 Caves and Prayers ....................................................................... -

Calimera.It Calimerese DAL 1998 TRA PROTESTE PROPOSTE E AFFANNI
Il Difensore Civico IlInserto della Kinita“Difensore 2017 Civico” Direttore Rocco Montinaro Difensore Civico Calimerese www.kinita-calimera.it Calimerese DAL 1998 TRA PROTESTE PROPOSTE E AFFANNI... IL “DIFENSORE CIVICO” COMPIE VENT’ANNI! Sul finire degli anni 90 e con l’avvento della fan- tomatica “SECONDA REPUBBLICA” anche nei comuni, si fece strada un modo sbagliato ancor più di prima, di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa locale. Questo fu favorito in maniera determinante dalla modifica della legge elettorale proporzionale ivi compresa l’elezione diretta del Sindaco novello po- destà del terzo millennio! Per cui passata la “festa elettorale” il ruolo delle forze politiche locali, finiva e finisce il giorno dopo le elezioni amministrative, in quanto la “prerogati- va amministrativa” è del Sindaco e di alcuni suoi delfini a fare a loro piacimento il cosiddetto “gioco delle tre carte”. A tutto questo si aggiunse la “legge Bassanini” che trasferì i poteri gestionali nelle mani dei capi- servizio (oggi dirigenti) comunali riservando agli amministratori eletti e non eletti facoltà di scelta e di controllo; che per poterlo esercitare bisognava conoscere struttura e ruolo dell’Ente locale, unita- mente allo Statuto e ai regolamenti dei servizi co- munali. Inoltre il nuovo sistema elettorale aveva favorito il formarsi di amministrazioni comunali dove gli amministratori eletti, non essendosi formati nella militanza della politica locale, giungevano sul pa- lazzo municipale senza la necessaria conoscenza del funzionamento della struttura amministrativa da controllare. Per dirla con una battuta per raccogliere i funghi CU LA PROLOCU DE LU GARRAPA CALIMERA FATICA ZUMPA E SE SVAGA! c’è bisogno del patentino per amministrare un Co- Nisciunu de nui ia scommessu Poi rriva puru la pittulata Dopu sta beddha prefazione mune basta essere eletto con tanti amichevoli voti. -

Historic Records and GIS Applications for Flood Risk Analysis in the Salento
Natural Hazards and Earth System Sciences, 5, 833–844, 2005 SRef-ID: 1684-9981/nhess/2005-5-833 Natural Hazards European Geosciences Union and Earth © 2005 Author(s). This work is licensed System Sciences under a Creative Commons License. Historic records and GIS applications for flood risk analysis in the Salento peninsula (southern Italy) F. Forte1, L. Pennetta1, and R. O. Strobl2 1Sezione di Geografia fisica e Geomorfologia – Dipartimento di Geologia e Geofisica, Universita` degli Studi di Bari, via E. Orabona 4, 70125 Bari, Italy 2ITC – International Institute for Geoinformation Science and Earth Observation, Hengelosestraat 99, 7514 AE Enschede, The Netherlands Received: 17 November 2004 – Revised: 13 October 2005 – Accepted: 19 October 2005 – Published: 2 November 2005 Abstract. The occurrence of calamitous meteoric events rep- ing and emergency states to the population and economic ac- resents a current problem of the Salento peninsula (Southern tivity. Italy). In fact, flash floods, generated by very intense rainfall, occur not only in autumn and winter, but at the end of sum- 1.2 Geological and geomorphological settings mer as well. These calamities are amplified by peculiar geo- logical and geomorphological characteristics of Salento and The Salento peninsula, the southeast portion of the Apulia by the pollution of sinkholes. Floodings affect often large region (southern Italy), covers 7000 km2 of area and stretches areas, especially in the impermeable lowering zones. These over 150 km between the Ionian and Adriatic seas (Fig. 1). events cause warnings and emergency states, involving peo- The peninsula includes two extreme geographical points: the ple as well as socio-economic goods. -

Comune Di Calimera
COMUNE DI CALIMERA PROVINCIA DI LECCE Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016-2018 1 2 INDICE PREMESSA ................................................................................................................................................ 5 L’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili ................................................................................. 5 Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) ................................................................... 6 I nuovi documenti di programmazione ....................................................................................................... 7 DUP 2016-2018 ......................................................................................................................................... 7 La composizione del DUP ........................................................................................................................... 7 Il nuovo ciclo di programmazione degli enti locali ...................................................................................... 8 DUP Sezione Strategica (SeS) Periodo 2016-2018 ......................................................................................... 9 LINEE PROGRAMMATICHE E POLITICHE DI MANDATO .............................................................................. 10 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .................................................................................................. 12 La legislazione europea .......................................................................................................................... -

La Minoranza Greca D'italia
Da sportello a sportello! La tutela delle lingue minoritarie nelle altre regioni italiane: lo sportello linguistico della Comunità Montana “incontra” la minoranza greca d’Italia. La Legge 482/99 tutela le minoranze linguistiche della nostra penisola. In molte altre regioni d’Italia sono presenti comunità linguistiche che formano il ricco e variegato patrimonio linguistico nazionale. Con questa rubrica, “Da sportello a sportello! La tutela delle lingue minoritarie nelle altre regioni italiane” è nostra intenzione entrare in contatto con queste realtà per avviare un proficuo scambio di idee e magari di collaborazione. In questo numero del notiziario dell’Ente abbiamo deciso di conoscere la realtà dei Greci presenti nella Bovesia in Calabria, e nella Grecia Salentina in Puglia. LA MINORANZA LINGUISTICA GRECA La minoranza linguistica greca d'Italia (così come riconosciuta dallo Stato italiano) è composta dalle due isole linguistiche della Bovesia in Calabria e della Grecìa Salentina in Puglia, che di fatto costituiscono la totalità delle aree ellenofone esistenti in Italia. Il grecanico o griko, idioma praticato in queste comunità, è un dialetto (o gruppo di dialetti) di tipo neo-greco residuato probabilmente di una più ampia e continua area linguistica ellenofona esistita anticamente nella parte costiera della Magna Grecia. I greci odierni chiamano la lingua Katoitaliótika (Greco: Κατωιταλιώτικα, "Italiano meridionale") oppure, in riferimento al solo dialetto della Bovesìa, calabrese. Il numero complessivo di coloro che ancora parlano la lingua grika in Italia è stimato intorno alle 20.000 unità. LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE DUE COMUNITA’ ELLENOFONE DELLA CALABRIA E DEL SALENTO In questa cartina si possono riconoscere le aree nelle quali è distribuita la comunità grecanica. -

L. 5.000 Via Verdi Zona Industriale CALIMERA Tel. 0832/875005
Numero unico calimerese in occasione della Festa di S. Brizio TRENTATREESIMA EDIZIONE L. 5.000 Via Verdi Zona Industriale CALIMERA Tel. 0832/875005 pag. 2 Kinita 2000 EDICOLA CARTOLERIA BRESCIA Caffé Vittoria Modellismo - Cartoleria - Giornali Libri - Video Gelati - Frullati LIBRI SCOLASTICI - BIGLIETTERIA SUD-EST Piazza del Sole, 51 - CALIMERA Tel. 0832/873129 Piazza del Sole, 15 - Tel. 0832/873391 - CALIMERA Roca Vecchia: millenni di storia lavoro, e dare risposta agli innumerevoli quesiti storici, archeolo- nuità delle attività dell’uomo in questo territorio per migliaia di gici, epigrafici che la nuova scoperta poneva. anni. È stato un lungo e difficile lavoro che, nel corso di quasi un La Grotta era la “casa” della divinità, o almeno il luogo nel ventennio, ha prodotto risultati nuovi e fondamentali per la cono- quale era possibile avvicinarla e rivolgerle richieste di aiuto, pro- scenza della storia antica delle popolazioni del Salento. tezione, promettendo in cambio di offrire animali scelti, vino, Grotta Poesia fu per migliaia di anni il cuore di un complesso sostanze costose, statue, etc. Questo si ricava dalla lettura delle sistema di strutture organizzate e variamente articolate nel tempo iscrizioni in latino e greco incise sulle pareti; quelle in messapico sulla riva del canale d’Otranto, nei luoghi che oggi indichiamo coi restano ancora in gran parte incomprensibili, pur mostrando d’es- nomi di S.Andrea, Torre dell’Orso, Roca, San Foca. L’insieme sere rivolte sempre e solo ad in unico dio, Thaotor Andirahas. I potrebbe definirsi porta-portoapprodo-meta di fittissimi legami tra Latini, eredi ultimi del culto lo invocavano come Tutor Andiraius. -

Historic Records and GIS Applications for Flood Risk Analysis in the Salento Peninsula (Southern Italy) F
Historic records and GIS applications for flood risk analysis in the Salento peninsula (southern Italy) F. Forte, L. Pennetta, R. O. Strobl To cite this version: F. Forte, L. Pennetta, R. O. Strobl. Historic records and GIS applications for flood risk analysis in the Salento peninsula (southern Italy). Natural Hazards and Earth System Sciences, Copernicus Publ. / European Geosciences Union, 2005, 5 (6), pp.833-844. hal-00301659 HAL Id: hal-00301659 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00301659 Submitted on 2 Nov 2005 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Natural Hazards and Earth System Sciences, 5, 833–844, 2005 SRef-ID: 1684-9981/nhess/2005-5-833 Natural Hazards European Geosciences Union and Earth © 2005 Author(s). This work is licensed System Sciences under a Creative Commons License. Historic records and GIS applications for flood risk analysis in the Salento peninsula (southern Italy) F. Forte1, L. Pennetta1, and R. O. Strobl2 1Sezione di Geografia fisica e Geomorfologia – Dipartimento di Geologia e Geofisica, Universita` degli Studi di Bari, via E. Orabona 4, 70125 Bari, Italy 2ITC – International Institute for Geoinformation Science and Earth Observation, Hengelosestraat 99, 7514 AE Enschede, The Netherlands Received: 17 November 2004 – Revised: 13 October 2005 – Accepted: 19 October 2005 – Published: 2 November 2005 Abstract. -

Nella Puglia Che Parla Griko
ITINERARI SALENTO Nella Puglia che parla griko Un’isola culturale nel cuore del Salento, un microcosmo che racconta millenni di storia: è la Grecìa Salentina, dove i Greci furono di casa dall’epoca micenea a quella di Bisanzio. Lasciando in eredità una lingua usata ancora oggi in nove antichi borghi TESTO DI GIANNA TESTA • FOTO DI ALFIO GAROZZO Nella foto. Il complesso dell’ex Convento degli Agostiniani di Melpignano con la Chiesa del Carmine. Fu costruito tra il 1573 e il 1662, insieme ad altre chiese e monasteri, per indirizzare verso la confessione cattolica gli abitanti della Grecìa Salentina, tradizionalmente di fede ortodossa. Ogni agosto fa da sfondo al concertone della Notte della Taranta. QUANDO: T U T TO L’A N N O DURATA: 2-3 GIORNI IL CONSIGLIO: ALTERNARE LA VISITA A CHIESE E MUSEI AL MARE DELLE VICINE SPIAGGE DI OTRANTO E TORRE DELL’ORSO inviaggio 92 inviaggio 93 l territorio – il Salento – è ben noto, eppure c’è qualcosa di strano. Le persone che s’incontrano parlano un idioma fitto e veloce che non si capisce, eccetto forse Iuna parola più familiare all’udito: kalimera (buongiorno). Ma cos’è che non torna? Semplice, siamo in Puglia ma sembra di essere in Grecia. La lingua è, appunto, una delle caratteristiche della Grecìa Salentina, dove si parla il griko, idioma neogreco tutelato da una legge del 1999 a favore delle Sopra. Il campanile della Chiesa Madre minoranze linguistiche storiche. In questa di San Brizio, a zona a sud di Lecce, infatti, si sono mantenute Calimera, sullo sfondo di Via Costantini. -

BU FABBRICATI INTER in LOCAZ Carluccio
Allegato "A" PROG. COMUNE COD.IBU INDIRIZZO LOCALITA' 1 ALESSANO 01017 VIA DA VINCI 6 2 ALESSANO 01018 VIA TRIESTE 84 MONTESARDO 3 ALESSANO 01019 VIA NAZIONALE 168 MONTESARDO 4 ALESSANO 01635 VIA DEI CADUTI FABBR. 2 110 5 ALESSANO 01636 VIA TRAV.DEI CADUTI 109 6 ALESSANO 01637 VIA NAZIONALE 260 MONTESARDO 7 ALESSANO 05050 VIA TRAV.DEI CADUTI 0 8 ALESSANO 05051 VIA PADRE BONAVENTURA 24 9 ALESSANO 05052 VIA NAZIONALE 0 MONTESARDO 10 ALESSANO 05158 VIA NAZIONALE 65 MONTESARDO 11 ALEZIO 01028 VIA CARSO 1 12 ALEZIO 01029 VIA ZONA 167 ALEZIO 13 ALLISTE 01032 VIA 25 APRILE 9 14 ALLISTE 01033 VIA 25 APRILE 0 15 ALLISTE 01034 VIA I MAGGIO TRAVERSA 0 FELLINE 16 ALLISTE 01035 VIA LECCE SNC FELLINE 17 ANDRANO 01036 VIA PROVINCIALE II TRAVERSA 0 18 ARADEO 01046 VIA MATTARELLA 9 19 ARADEO 01047 VIA DALLA CHIESA 6 20 ARADEO 01048 VIA DALLA CHIESA 2 21 ARADEO 01049 VIA LA TORRE 2 22 ARADEO 01050 VIA MATTARELLA 1 23 ARADEO 01051 VIA MATTARELLA 7 24 ARADEO 01380 VIA MATTARELLA F A 25 ARADEO 01381 VIA MATTARELLA F1 26 ARADEO 01382 VIA DALLA CHIESA 4 F2 27 ARADEO 01383 VIA DALLA CHIESA 5 F.3 28 ARADEO 05230 VIA G. CESARE SNC 29 ARADEO 05242 VIA G. CESARE 05 30 ARNESANO 05115 VIA DELLA LIBERTA' 54 31 ARNESANO 05116 VIA DELLA LIBERTTA' 42 32 BAGNOLO DEL SALENTO 05128 VIA PAPALEO 95 33 BOTRUGNO 05131 VIA DONIZETTI 0 34 CALIMERA 01079 VIA RESPIGHI 3 35 CALIMERA 01080 VIA RESPIGHI 1 36 CALIMERA 01081 VIA VIRGILIO 130 37 CALIMERA 01082 VIALE VIRGILIO 132 38 CALIMERA 01083 VIA VIRGILIO 134 39 CALIMERA 01084 VIALE VIRGILIO 136 40 CALIMERA 01085 VIALE VIRGILIO 138