00 Colophon Sommario Editori
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Inventario (1
INVENTARIO (1 - 200) 1 Scatola contenente tre fascicoli. V. segn. 1 ELETTRICE PALATINA ANNA MARIA LUISA DE’ MEDICI 1 Lettere di auguri natalizi all’elettrice palatina Anna Maria Luisa de’ Medici di: Filippo Acciaiuoli, cc.2-4; Faustina Acciaiuoli Bolognetti, cc.5-7; Isabella Acquaviva Strozzi, cc.8-10; cardinale Alessandro Albani, cc.11-13; Fi- lippo Aldrovandi Marescotti, cc.14-16; Maria Vittoria Altoviti Cor- sini, cc.17-19; Achille Angelelli, cc.20-23; Roberto Angelelli, cc.24- 26; Dorothea Angelelli Metternich, cc.27-29; Lucrezia Ansaldi Le- gnani, cc.30-32; Giovanni dell’Aquila, cc.33-35; duchessa Douariere d’Arenberg, con responsiva, cc.36-40; governatore di Grosseto Cosimo Bagnesi, cc.41-43; Andrea Barbazzi, cc.44-46; segretario della Sacra Consulta Girolamo de’ Bardi, cc.47-49; cardinale [Lodovico] Belluga, cc.50-52; Lucrezia Bentivoglio Dardinelli, cc.53-55; Maria Bergonzi Ra- nuzzi, cc.56-58; cardinale Vincenzo Bichi, cc.59-61; «re delle Due Si- Nell’inventario, il numero del pezzo è posto al centro in neretto. Alla riga successiva, in cor- cilie» Carlo VII, con responsiva, cc.62-66; vescovo di Borgo Sansepol- sivo, sono riportate la descrizione estrinseca del volume, registro o busta con il numero com- cro [Raimondo Pecchioli], cc.67-69; Camilla Borgogelli Feretti, cc.70- plessivo dei fascicoli interni e le vecchie segnature. Quando il nesso contenutistico fra i do- 72; Cosimo Bourbon del Monte, cc.73-75; baronessa de Bourscheidt, cumenti lo rendeva possibile si è dato un titolo generale - in maiuscoletto - a tutto il pezzo, con responsiva, cc.76-79; vescovo di Cagli [Gerolamo Maria Allegri], o si è trascritto, tra virgolette in maiuscoletto, il titolo originale. -

Miscellanea Medicea Ii (201-450). Inventario
STRUMENTI CLXXXVI MISCELLANEA MEDICEA MISCELLANEA MEDICEA II II ROMA 2009 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI Stemma ligneo della famiglia Medici, Archivio di 2009 Stato di Firenze STRUMENTI PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO CLXXXVI STRUMENTI CLXXXVI ISBN 978-88-7125-305-3 ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE MISCELLANEA MEDICEA MISCELLANEA MEDICEA II II (201-450) (201-450) Inventario a cura di BEATRICE BIAGIOLI GABRIELLA CIBEI VERONICA VESTRI Inventario a cura di BEATRICE BIAGIOLI, GABRIELLA CIBEI, VERONICA VESTRI Coordinamento scientifico e revisione PIERO MARCHI MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI ROMA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI 2009 2009 Nel ricordo di Anna Bellinazzi: ci mancheranno i suoi consigli e la sua amicizia Il lavoro di schedatura è stato finanziato dalla Direzione generale per gli archivi attraverso una convenzione con l’Istituto nazionale di studi sul Rinascimento. PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO STRUMENTI CLXXXVI ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE MISCELLANEA MEDICEA II (201-450) Inventario a cura di BEATRICE BIAGIOLI, GABRIELLA CIBEI, VERONICA VESTRI Coordinamento scientifico e revisione PIERO MARCHI MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI 2009 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI Servizio III - Studi e ricerca Direttore generale per gli archivi: Luciano Scala Direttore del Servizio III: Patrizia Ferrara Cura redazionale: Maria Grazia Lippolis Elaborazione schede: Beatrice Biagioli, Gabriella Cibei, Veronica Vestri (le specifiche a p. 1095) Si ringraziano: Patrizia Ferrara e Maria Grazia Lippolis della Direzione generale per gli archivi. Carla Zarrilli, direttrice dell’Archivio di Stato di Firenze. Rosalia Manno Tolu, già direttrice dell’Archivio di Stato di Firenze, per avere promosso la realizzazione di questo lavoro. -

Inventario Archivio Di Casa DEF Con Indice Per Caprotti
(1) Denominazione completa Famiglia Airoldi, conti di Lecco, Milano (1400 - 1900) Estremi cronologici 1400 - 1900 Profilo storico biografico Gli Airoldi ebbero le proprie radici nel territorio di Lecco, con rami originari di Robbiate e di Mandello. Contarono, nel XV secolo, diversi officiali ducali e nu- merosi notai, attivi nel territorio di Lecco e di Milano fra il XIV e il XVII secolo, e un frate benedettino olivetano, Domenico Airoldi da Lecco, il quale fu per ben quattro volte abate generale del suo ordine a Milano (1484, 1497, 1505 e 1511). Mercanti e banchieri di spessore, tanto da meritarsi la fiducia personale dei so- vrani asburgici di Spagna e d'Austria, tra la metà del Seicento e la metà del se- colo successivo ben quattro Airoldi occuparono la carica di Tesoriere generale dello stato e dell'esercito di Milano, unici membri di una stessa famiglia che riu- scirono a occupare così a lungo e in via praticamente ereditaria un'alta carica dello stato. Nel 1647 Marcellino, figlio di Giovanni Battista e di Drusiana Invitti, acquistò dalla Camera Regia ducale il feudo di Lecco e di Bellagio, cui appoggiò il titolo comitale con diploma di re Filippo IV di Spagna due anni più tardi. Agli inizi del XVII secolo un cadetto della famiglia, Giovanni Battista di Cesare, si trasferì in Sicilia e nel 1711 acquisì al suo cognome il titolo di marchese di Santa Colomba, cui in seguito il nipote omonimo aggiunse per matrimonio quello di duca Cruyllas. Successi ai cugini lombardi quali conti di Lecco all'e- stinzione del ramo nel 1769, gli Airoldi siciliani sono tuttora i detentori del tito- lo. -

Ludovico Maria Sinistrari's De Daemonialitate and Its
Ludovico Maria Sinistrari’s De Daemonialitate and its Transmission in Manuscript and Print MA Thesis Book and Digital Media Studies Matt Beros Leiden University s1441345 Supervisor: Prof. Adriaan van der Weel Second Reader: Dr. Susanna de Beer 21 June 2019 Word count: 18,142 Table of Contents Introducton 3 1. Isidore Liseux’s Daemonialitate Manuscript: Discovery, Reception and Authenticity 1.1 Liseux’s Discovery of the Daemonialitate Manuscript 10 1.2 The Fin de Siècle Reception of Liseux’s De la Démonialité 12 1.3 ‘Facétie Bibliographique’: Accusations of a Manuscript Forgery 18 1.4 On the Authenticity and Provenance of the Liseux Manuscript 20 2. De Delictis et Poenis Tractatus Absolutissimus: From Publication to Prohibition 2.1 A Brief Life of Ludovico Maria Sinistrari 25 2.2 The Publishing History of De Delicits et Poenis 27 2.3 The Historical Context of De Daemonialitate 33 2.4 The Censoring of De Delictis et Poenis 37 2.5 De Daemonialitate as an Unexpurgated Manuscript Draft 41 3. The Manuscript Circulation of De Daemonialitate 1699-1753 3.1 The Manuscript Filiation of De Daemonialitate 50 3.2 Ambrosiana MS 52 3.3 Muratori MS 54 3.4 Tadisi MS 55 3.5 Villarosa MS 40 62 3.6 Casanatense MS 4953 65 3.7 Angelica MS 2240 65 4. The Later Print Editions of De Daemonialitate 1879-1927 4.1 The Later Editions of Liseux 67 4.2 The Editions of Fryar, Clymer and Summers 71 Conclusion 75 Appendix Creaturarum Rationalium Corporearum: Tadisi’s Accounts of Demoniality 77 Bibliography 84 2 Introduction C’est le péché lettré, patricien et décadent par excellence; il faur plus que de l’imagination, beaucoup de lecture et un peu d’archéologie pour le commettre. -

Della Chiesa
DELLA CHIESA DI SAN T 'EUSTORGIO IN MILANO ILLUSTRAZIONE STORICO-MONUMERTALE-EPIGRAFICA DI MICHELE CAFFI MILANO DALLA TIPOGRAFIA DI GIUDITTA BONIARDI-POGLIANI Contrada dei Nobili, N.° 3993. MDCCCXU. PREFAZIONE L ’origine della basilica cbe ora si appella di sant’ Eustorgio vuoisi far risalire al principio dell’ era cristiana. Pretendesi che presso l’ antico fonte, il quale fu poi detto e di sant’Eu- storgio e di s. Barnaba, esistesse da remotissimo tempo una cappella o un altare posto forse da s. Cajo vescovo di Mi lano (eletto nell’ anno 61 di Cristo), a comodo della pietà de’ fedeli. Checché sia di tale credenza, certo è cbe il pio ar civescovo Federigo Borromeo, ligio ad essa, allorché intorno l’ anno i 6 a3 fece ristorare la chiesuola di s. Barnaba al fon te^) (posta in assai vicinanza alla basilica Eustorgiana) vi avea fatto dipingere nell’ atrio s. Cajo in atto di battezzare gran numero di gente. Ignoriamo però come in quella prima epoca fosse questa chiesa : probabilmente assai meschina ed angusta, perchè i tempi non concedevano di più. Ma assunto al vescovato mila nese nell’ anno 315 in sustituzione a Materno, Eustorgio (b) di origine gallo-greco, il quale governava prima in nome di Co- fa) Questa chiesuola era stata eretta in tempi assai rimoti, in vicinanza ad una piccola fonte presso cui dicesi che s. Barnaba, venuto a Milano a predi care il Vangelo, ponesse un altare per la celebrazione dei sacri riti. (b) L ’opinione più comune è quella che assegna V elezione di Eustorgio I all’ anno 3 i 5 , cioè dopo la morte di Materno. -

00 Colophon Sommario Editori
XII 2019-2020 00_Colophon_Sommario_Editoriale.indd 1 23/11/20 17:24 Direttori responsabili Serena Benelli, Giovanni Truglia Redazione Agostino Allegri, Serena Benelli, Giovanni Renzi, Eleonora Scianna, Giovanni Truglia e-mail: [email protected] web: http://riviste.unimi.it/index.php/concorso Crediti fotografici: Marta Barbieri: p. 62, fig. 1; Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie: p. 20, fig. 1; Mauro Magliani: pp. 9, 11, 14, 18, figg. 3-4, 6, 9; Antonio Mazzotta: p. 6, fig. 1; Milano, Archivio di Stato: p. 68, fig. 3; Milano, Castello Sforzesco, Civica Raccolta delle Stampe «Achille Bertarelli» © Comune di Milano, tutti i diritti riservati: pp. 64, 68, 70, 73, figg. 2, 4-5, 7; Milano, Castello Sforzesco, Civiche Raccolte d’Arte Antica © Comune di Milano, tutti i diritti riservati: p. 71, fig. 6; Milano, Castello Sforzesco, Civiche Raccolte Grafiche e Fotografiche, Archivio Fotografico © Comune di Milano, tutti i diritti riservati: pp. 38-39, figg. 2-3; Giovanni Renzi: pp. 44, 50-51, 56, 58-59, figg. 1-6; Dafne Riva: p. 32, fig. 1; Giovanni Romano, pp. 8, 17, figg. 2, 7-8. La redazione si dichiara a disposizione degli aventi diritto per eventuali omissioni o imprecisioni nelle citazioni delle fonti fotografiche. © 2020 Lubrina Editore Srl via Cesare Correnti, 50 - 24124 Bergamo - cell. 3470139396 e-mail: [email protected] - web: www.lubrina.it ISSN 2421-5376 ISBN 978-88-7766-737-3 Aut. del Tribunale di Milano n° 223 del 10 luglio 2015 Questa rivista è realizzata con il finanziamento dell’Università degli Studi di Milano ai sensi della legge 3 agosto 1985, n° 429. -

Dono Di Eterna Riconoscenza
(ll arlo ,£i ar t olome o ìlì omilli A R C ! V E S C G V O DIMILA NO. mall ’ antica e nobile famiglia bergamasca dei conti R OMIL LI nas ce v a BA R TOL OME O ai 44 d e l 4 9 marzo 7 6. Fra le doti caratteristiche di u n sublime n ff i gegno , a erma i l filosofo ,essere la preco i à c t ,la quale anche ad onta di poca o ne s s u na ed ucazione delle facoltà intellettuali ,non l T L ME ma m tarda a svilupparsi . n BA R O O O Ro o < s )e assecondato l ’ ingegno da retta educazione che il lustro della famiglia esigeva ,non tardò ’ a dimostrare che l inge gno s uo e d i retti insegnamenti avvalorati da efficace v olontà , favorivano le più care conseguenze . Varche r emo i l periodo di giovinezza di m onsignore ’ R OMILL I, nel quale la diligenza , l ingegno,la condotta lo resero caro ai condiscepoli che ’ in lui 5 avevano un amico ; grato ai maestri , ’ cui rendeva il migliore tributo d e ll imp ar ar e ; amato dai cons anguinei e genitori che tante Speranze in lui avevano riposte . Nei pubblici e nei privati esperimenti e gli diede lodevoli ’ prove di s è ,e l indole s ua docile , pieghe ’ vole , s u niv a a rendere più eminenti i suoi progressi . Erudito nei prim i e ne ce s s arjelementi della l ingua italiana ,che doveva parlare e scrivere i n appresso con tanto buon gusto ,egli avan zava il piede nel tempio delle belle lettere . -

Dissüberarbeitet END 10.1.19 Version Vom 26.3.18 Komprimiert
Kirchenmusik in Mailand von 1740 bis 1780 Biritualität im Kontext der ambrosianischen und römischen Liturgie Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde an der Philosophischen Fakultät der Universität Freiburg (CH) Genehmigt von der Philosophischen Fakultät auf Antrag der Herren Professoren Luca Zoppelli (1. Gutachter) und Claudio Toscani (2. Gutachter) Freiburg, den 8. März 2012 Prof. Marc-Henry Soulet, Dekan Christoph Riedo, Plaffeien (FR) Latuada, Serviliano: Descrizione di Milano ornata con molti disegni in rame delle fabriche più conspicue, che si trovano in questa metropoli, Bd. 5, Mailand 1737–38. Inhaltsverzeichnis Liturgische Bücher, bibliographische Abkürzungen und Bibliothekssigel .............................. iv Liturgische Bücher ................................................................................................................ iv Bibliographische Abkürzungen ..............................................................................................v Bibliotheken und Archive ..................................................................................................... vi Vorwort ................................................................................................................................ vii Bemerkung zur Gehalts- und Preisentwicklung in Mailand im 18. Jahrhundert ....................x Einleitung ................................................................................................................................1 I. Kapitel: ....................................................................................................................................6 -

Il Passato Riscoperto Cap 10 Notizie Storiche 1700
Il passato riscoperto CENNI SULLA STORIA DELLA CHIESA DI S. CALOCERO CAPITOLO 10 - IL 1700 VERSO LA CHIUSURA DEL MONASTERO 1700 Abate Laurentius Maria de Mediolano (Salazar) 1 Vic. Ardicinus de Mediolano Cell. For. Raphael de Mediolano Conv. Emmanuel de Mediolano Benedictus de Ferraria Carolus Felix de Aretio Obl. Joannes M. de Mediolano Joseph M. de Mediolano Già Pietro Pacino curato di Civate 2 26 febbraio 1700 3 Il commedatario del monastero di san Pietro e calocero monsignor Erba, stabilisce il trasporto della cura d’anime alla chiesa di San Vito e Modesto. Vengono inoltre stbiliti dei punti che il monastero e le parrocchiale devono rispettare in ordine al trasferimento. In primis il monastero deve dare alla chiesa di San Vito e Modesto gli utensili che si trovano nella sacrestia e che servono per la cura, nonostante siano di proprietà del monastero. Il monastero si obbliga inoltre a pagare per le spese per erigere una nicchia dove riporre il battistero nella chiesa di san Vito e Modesto, e si impegnano a pagare anche il trasporto degli utensili. Si stabilisce chi il vicario della chiesa non ha alcun potere sul monastero. La chiesa collegiata resta a disposizione dei monaci. Il monastero si obbliga inoltre a non intromettersi nelle funzioni parrocchiali e a seguire le regole degli Olivetani della diocesi di Milano, come accade nei monasteri di Nerviano e Baggio. Il documento termina così: “ Io Benedetto Erba presenta Abbate Commendatario della Abbatia de SS. Pietro e Calocero, do il mio assenso per il trasporto della cura dalla chiesa de SS. Pietro e Calocero, in quella de SS. -

Contributo a Una Bibliografia Dei Palazzi Privati Di Milano Dal Xiv Secolo All’Età Neoclassica
Edizioni presenti nella Biblioteca Centrale/ www.comune.milano.it/sbm CONTRIBUTO A UNA BIBLIOGRAFIA DEI PALAZZI PRIVATI DI MILANO DAL XIV SECOLO ALL’ETÀ NEOCLASSICA Il contributo consta di due sezioni: una bibliografia generale e una bibliografia relativa ai singoli palazzi. Si è preferito disporre la bibliografia generale in ordine alfabetico, invece che secondo il più usuale ordinamento cronologico, per facilitare la ricerca delle fonti per autore. L'ordinamento cronologico è stato invece mantenuto all'interno delle schede bibliografiche concernenti i singoli palazzi. Il riferimento geografico della ricerca è all’intera area dell’attuale comune di Milano. Per quel che concerne gli edifici all’interno della cerchia delle mura spagnole si è rispettata l’antica suddivisione amministrativa in sestieri, corrispondenti alle sei porte munite. All’interno di ognuno dei sestieri, i singoli palazzi sono riportati secondo un ordine “di prossimità”, seguendo un itinerario ideale. Per quel che riguarda invece l’area extra muraria è stata ripresa la suddivisione, dove possibile, secondo gli antichi borghi ordinati alfabeticamente. I contributi che, per l'ampiezza della trattazione o per l'importanza delle notizie riportate, costituiscono la base di riferimento per le ricerche sono riportati in extenso nelle singole schede bibliografiche dei palazzi. Le opere che invece non hanno come argomento monografico l’edificio stesso, sono citate sommariamente col cognome dell’autore principale e la data di edizione, rimandando alla bibliografia generale, dove è stata anche contrassegnata da una lettera s in grassetto la presenza del titolo nelle raccolte della Biblioteca comunale centrale. L’indicazione dei fondi archivistici, riportata nelle schede bibliografiche dei singoli palazzi, deriva da altre bibliografie e non ha pertanto alcuna pretesa di completezza. -

Massimo Carlo Giannini: Una Carriera Diplomatica Barocca: Cesare Monti Arcivescovo Di Milano E Agente Della Politica Papale (1632–1650)
Massimo Carlo Giannini: Una carriera diplomatica barocca: Cesare Monti arcivescovo di Milano e agente della politica papale (1632–1650). Schriftenreihe Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken Band 94 (2014) Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Massimo Carlo Giannini Una carriera diplomatica barocca: Cesare Monti arcivescovo di Milano e agente della politica papale (1632–1650)* 1 Introduzione 6 La „buona corrispondenza con gli 2 La carriera curiale e diplomatica arcivescovi“: i Cantoni svizzeri e i 3 Arcivescovo di Milano Grigioni 4 Agente, informatore e diplomatico 7 Conclusioni 5 Diplomatico in tempo di guerra Zusammenfassung: Der Beitrag befaßt sich mit einer wenig bekannten politischen und kirchlichen Karriere im Barockzeitalter, d. h. mit dem Werdegang Cesare Montis, der zunächst apostolischer Nuntius in Neapel und Madrid (1628–1632), dann Erzbi- schof von Mailand (1632–1650) war. Es handelt sich dabei um eine komplexe Persön- lichkeit: juristische Studien, seine Tätigkeit in wichtigen römischen Kongregationen des päpstlichen Hofes, die Zugehörigkeit zum Barberini-Kreis und die politisch-diplo- matischen Erfahrungen am Hof von Madrid schufen einen beachtlichen Karriereweg, bevor er zum Erzbischof von Mailand und Kardinal ernannt wurde. -
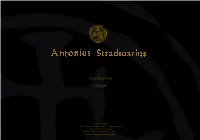
By Jost Thöne Verlag —Pdf Sample—
by Jost Thöne Verlag —pdf Sample— Jost Thöne Verlag Titiseestraße 19, 79853 Lenzkirch—Saig, Germany, Phone: +49 (0)171 64 63 597 E-Mail: [email protected] Internet: www.jost-thoene-verlag.de Book Samples DVD Samples w w w . s t r a d i v a r i b o o Volume I-VIII k s . c o m No part of this publication may be reproduced, C stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission © from the copyright owners. J All rights reserved. T V 2016 RZ4_Label_rot+schwarz_HE_x5_2016.indd 3 17.05.16 19:28 Volume I-VIII Credits Published by Jost Thöne Jost Thöne Verlag www.jost-thoene-verlag.de www.stradivaribooks.com Editor Jost Thöne All Photos Jan Röhrmann Bronze by Marijke de Vré-Verlaan 1715 ‘Lipinski’—by Michael Darnton 1698 ‘Zuber’—by Nathan Tolzmann for Kenneth Warren & Son, Ltd. Text Dr. Christian Eder Johannes Loescher Jost Thöne Layout & Design Korhammer Design GmbH Translation Anna Stuart Proofreading Ingbert Edenhofer Reproduction & Print Pinsker Druck and Medien GmbH Printing press machine Dedicated to my wife Angelika with Viorica and Titus Jost Thöne Heidelberg HD XL 106-5+L Paper Maxigloss 170 g/qm from Igepa, produced by UPM Binding Müller Buchbinderei GmbH Leipzig Edition First published in May 2016 Library edition 2000 copies De Luxe edition 100 copies ISBN 978-3-00-050178-4 Library edition copy Copyright © Jost Thöne Verlag 2016 /2000 No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission from the copyright owners.All rights reserved.