Piano Regionale Della Mobilità E Della Logistica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Msc Magnifica Riporta Le Crociere a Livorno,Il Traffico Passeggeri Nel
5 Ottobre 2021 - Savelli: “Per le crociere livelli pre- Covid nel 2023” LIVORNO – I numeri pre-Covid dei passeggeri delle crociere, torneranno presumibilmente nel 2023. A confermarlo è Matteo Savelli, presidente della Porto Livorno 2000, che gestisce servizi passeggeri nel porto labronico. “Mancano gli americani e gli inglesi, ma anche i canadesi e i sudamericani, che nel 2019 erano i principali turisti che arrivavano a Livorno”. Il crocerista che scala oggi la città è tipicamente europeo, per lo più tedesco, aggiunge. Un settore che, inutile dirlo e ripeterlo, ha subito una perdita quasi totale nel 2020 e che ancora fatica a riprendersi. “Ad Agosto abbiamo accolto due navi, Settembre si chiuderà con 11 scali e una ventina di crociere sono attese per Ottobre”, ma si sta già lavorando con gli https://www.messaggeromarittimo.it/tag/matteo-savelli/ | 5 Ottobre 2021 - 5 Ottobre 2021 - armatori per programmare il prossimo biennio. Non è andata male, continua Savelli, ai traghetti: nonostante manchino all’appello circa 700 mila passeggeri rispetto al 2019, i numeri dell’estate sono stati soddisfacenti, un turismo che ha visto coinvolti maggiormente gli italiani. Msc Magnifica riporta le crociere a Livorno https://www.messaggeromarittimo.it/tag/matteo-savelli/ | 5 Ottobre 2021 - 5 Ottobre 2021 - LIVORNO – Msc Crociere riporta le crociere a Livorno e lo fa con la programmazione di sei scali di “Msc Magnifica” da oggi 20 Ottobre fino a Dicembre prossimo, dopo il lungo arresto che il traffico crocieristico ha subito in tutto il mondo a causa della pandemia da Covid-19. Si tratta senza dubbio di una bella notizia per il porto labronico, e non solo, che lascia ben sperare per il futuro e come sottolinea Matteo Savelli, presidente di Porto di Livorno 2000, sono state adottate “tutte le misure di sicurezza di concerto con la compagnia”. -

Toremar.It Toscana Regionale Marittima S.P.A
BIGLIETTERIE DI PORTO LIVORNO PORTO S. STEFANO CAVO Asat srl Agemar Metrano srl Alessandra Struzzi Porto Mediceo piazzale Facchinetti, 7/8 via Michelangelo, 54 tel./fax 0586.896113 tel. 0564.810803 tel./Fax 0565.949871 e.mail [email protected] fax 0564.818455 e.mail [email protected] e.mail [email protected] PIOMBINO GIGLIO PORTO Dini & Miele srl ISOLA DI CAPRAIA Cavero srl Nuova stazione marittima Amadero srl tel./Fax 0564.809349 tel. 0565.31100 via Assunzione, 18 e.mail [email protected] fax 0565.229730 tel./Fax 0586.905069 e.mail [email protected] e.mail [email protected] RIO MARINA PORTOFERRAIO A3 srl Dini & Miele srl calata Voltoni, 20 calata Italia, 36 tel. 0565.962073 tel. 0565.918080 fax 0565.962568 fax 0565.914717 e.mail [email protected] e.mail [email protected] Toscana Regionale Marittima S.p.A. Marittima Regionale Toscana www.toremar.it [email protected] dell’Operatore utilizzato. dell’Operatore c e c e Per le chiamate originate da rete di altro operatore i prezzi sono forniti dal servizio clienti servizio dal forniti sono prezzi i operatore altro di rete da originate chiamate le Per e di 5,58 centesimi al minuto IVA inclusa negli altri orari e nei festivi. nei e orari altri negli inclusa IVA minuto al centesimi 5,58 di e dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:30 e sabato dalle 08:00 alle 13:00 alle 08:00 dalle sabato e 18:30 alle 08:00 dalle venerdì al lunedì dal e indipendentemente dalla distanza, è di 14,25 centesimi al minuto IVA inclusa IVA minuto al centesimi 14,25 di è distanza, dalla indipendentemente e il costo della chiamata da telefono fisso Telecom Italia, senza scatti alla risposta alla scatti senza Italia, Telecom fisso telefono da chiamata della costo il Tutti i giorni dalle 08:00 alle 20:00 alle 08:00 dalle giorni i Tutti .77.33 .11 199 CALL CENTER CALL Toscana Regionale Marittima S.p.A. -

D2.1 SUMP Baseline Report
Ref. Ares(2018)3823219 - 18/07/2018 D2.1 SUMP Baseline Report Deliverable No.: D2.1 Project Acronym: DESTINATIONS Full Title: CIVITAS DESTINATIONS Grant Agreement No.: 689031 Workpackage/Measure No.: WP2, M2.1 Workpackage/ Measure Title: WP2: Sustainable Urban Mobility Planning for residents and visitors Task 2.2: Mobility context analysis and baseline Responsible Author(s): Willem Buijs, Renske Martijnse, Teije Gorris (LuxMobility) Responsible Co-Author(s): Alexandra Ellul (TM), Ritianne Buhagiar (TM), André Freitas (HF), Claudio Mantero (HF), Carla Patrícia (SRETC), Cristina Loreto (SRETC), Antonio Artiles (Guaguas), Octavio Cantero (Municipality of Las Palmas de Gran Canaria); Francesca Pietroni (ISSINOVA), Riccardo Enei (ISSINOVA), Panayiotis Antoniades (Stratagem), Nicole Mavrovounioti (Stratagem), Thanos Vlastos, Efthimios Bakogiannis, Konstantinos Athanassopoulos, Maria Siti, Harry Kyriakidis (Sustainable Mobility Unit, National Technical University of Athens), Nikos Vovos, Vasilis Myriokefalitakis , Thomas Papadogiannis (Rethymno Municipality), Stavroula Tournaki, Eleni Farmaki (Technical University of Crete) Date: 10/07/2017 Status: Final Dissemination level: Public The views expressed in this publication are the sole responsibility of the authors and the DESTINATIONS project consortium and do not necessarily reflect the views of the European Commission. D2.1 – SUMP Baseline 07/2017 Document History Date Person Action Status Diss. Level LuxMobility, TM; Draft template to ISINNOVA and PM, WPL, 27/3/2017 Draft WP2 leader VECTOS -

Isola Di Pianosa, Trekking, Escursioni a Piedi E in Mountain Bike
Isola di Pianosa, trekking, escursioni a piedi e in mountain bike http://www.ufficioguide.it/itinerari/pianosa.htm > Home-page | INDICE ITINERARI | GORGONA | MONTECRISTO | GIANNUTRI | CAPRAIA | ELBA | richiesta info ISOLA DI PIANOSA L'isola a cura di Alberto Calamai G.A.E. di Ufficio Guide L'isola di Pianosa ed il suo mare, per lo sviluppo di un miglio marino, fanno parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano dal 1996. E' la quinta per grandezza fra le 7 isole dell'Arcipelago. Dista da Marina di Campo, al quale Comune appartiene l'Isola, circa 14 km che vengono coperti con la motonave in circa 40 minuti. Pianosa ha una superficie di 10,2 kmq e la massima altitudine è di 29 m., ha un perimetro di 26 km. L'Isola è pianeggiante e la sua formazione è costituita da rocce sedimentarie. Nella parte costiera la vegetazione è costituita prevalentemente da macchia di ginepro, lentisco, cisto. si trovano raramente lecci, mentre è presente il pino ed il cipresso, alcune strade interne sono costeggiate da filari di eucalipti. Fra gl animali si può vedere con facilità la pernice rossa, l'upupa, i fagiani e talvolta il falco pellegrino e il 1 di 5 27/05/20, 21:13 Isola di Pianosa, trekking, escursioni a piedi e in mountain bike http://www.ufficioguide.it/itinerari/pianosa.htm gheppio, lungo la costa si può notare il gabbiano corso e il cormorano. L'isola e il carcere Il carcere fu istituito come colonia penale nel 1858 e questa è stata forse la salvezza di questo patrimonio naturalistico, l'isola era adibita alle colture ed allevamento di bestiame, i detenuti erano suddivisi in vari edifici, il paese venne separato dal resto dell'isola. -

USTICA LINES Giovedì, 06 Ottobre 2016 USTICA LINES Giovedì, 06 Ottobre 2016
USTICA LINES Giovedì, 06 ottobre 2016 USTICA LINES Giovedì, 06 ottobre 2016 Trasporti marittimi 05/10/2016 Ansa Traghetti: nuovo catamarano Toremar per Isola d' Elba 1 06/10/2016 Centonove Pagina 6 Ecopass, il giallo dei fondi spariti 2 06/10/2016 Centonove Pagina 6 Villa San Giovanni dovrà restituire i fondi Vertice a Palazzo Zanca 5 Porti 06/10/2016 Gazzetta del Sud Pagina 33 Crocetta sblocca i lavori per il porto 6 5 ottobre 2016 Ansa Trasporti marittimi Traghetti: nuovo catamarano Toremar per Isola d' Elba Collegherà Piombino con Portoferraio e Cavo (ANSA) PORTOFERRAIO (LIVORNO), 5 OTT Presentato oggi a Portoferraio lo Schiopparello Jet, il nuovo catamarano di Toremar. Il nuovo mezzo veloce, capace di trasportare circa 150 persone (145 passeggeri e 5 membri d' equipaggio) sostituirà l' Acapulco jet sulle tratte tra Piombino e i porti di Portoferraio e Cavo. Il catamarano (lungo 35 metri, largo 8 mt e con un pescaggio di circa 1,2 mt), che viaggerà a una velocita di crociera di 34 nodi, è stato interessato a una revisione totale dei motori, così come dei generatori e dei propulsori. "Con questo nuovo mezzo Toremar punta ad avere una flotta sempre più all' avanguardia, che mira a soddisfare al meglio le esigenze dei clienti ha detto il presidente e ad della compagnia Matteo Savelli Toremar rappresenta oggi un punto di riferimento per i toscani, grazie a una puntualità vicina al 100% e a navi che si distinguono per la loro accoglienza e i servizi che offrono ai passeggeri".(ANSA). Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 1 6 ottobre 2016 Pagina 6 Centonove Trasporti marittimi Ecopass, il giallo dei fondi spariti Dal settembre 2015 una delibera disponeva di internalizzarela gestione del servizio. -

Estratto Rassegna Stampa Assoporti Sabato, 02 Febbraio 2019 Estratto Rassegna Stampa Assoporti Sabato, 02 Febbraio 2019
Estratto Rassegna Stampa Assoporti sabato, 02 febbraio 2019 Estratto Rassegna Stampa Assoporti sabato, 02 febbraio 2019 Prime Pagine 02/02/2019 Corriere della Sera Prima pagina del 02/02/2019 7 02/02/2019 Il Fatto Quotidiano Prima pagina del 02/02/2019 8 02/02/2019 Il Foglio Prima pagina del 02/02/2019 9 02/02/2019 Il Giornale Prima pagina del 02/02/2019 10 02/02/2019 Il Giorno Prima pagina del 02/02/2019 11 02/02/2019 Il Manifesto Prima pagina del 02/02/2019 12 02/02/2019 Il Mattino Prima pagina del 02/02/2019 13 02/02/2019 Il Messaggero Prima pagina del 02/02/2019 14 02/02/2019 Il Resto del Carlino Prima pagina del 02/02/2019 15 02/02/2019 Il Secolo XIX Prima pagina del 02/02/2019 16 02/02/2019 Il Sole 24 Ore Prima pagina del 02/02/2019 17 02/02/2019 Il Tempo Prima pagina del 02/02/2019 18 02/02/2019 Italia Oggi Prima pagina del 02/02/2019 19 02/02/2019 La Nazione Prima pagina del 02/02/2019 20 02/02/2019 La Repubblica Prima pagina del 02/02/2019 21 02/02/2019 La Stampa Prima pagina del 02/02/2019 22 02/02/2019 Milano Finanza Prima pagina del 02/02/2019 23 Primo Piano 02/02/2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 5 ANDREA TARRONI Rossi: «Scaveremo quei fondali, non ci possono fermare» 24 Trieste 01/02/2019 Ansa Porti: Trieste, il 13 febbraio inaugurazione della 'Free Zone' 25 01/02/2019 Ferpress Friuli Venezia Giulia: Rixi, sistema portuale è unicum. -

SENTITO Il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 luglio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società Moby S.p.A., pervenuta in data 16 maggio 2011; VISTA la propria delibera dell’8 giugno 2011, con la quale ha avviato l’istruttoria, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti di Moby S.p.A. e Toremar S.p.A.; VISTE le istanze di partecipazione al procedimento di BN di Navigazione S.r.l. del 16 giugno 2011, dell’Associazione Albergatori dell’Isola d’Elba del 17 giugno 2011 e di Toscana di Navigazione S.r.l. del 20 giugno 2011, accolte in data 21 giugno 2011; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI 1. Moby S.p.A. (di seguito, “Moby”) è una società a capo di un gruppo attivo, principalmente nel Mediterraneo, nel settore del trasporto marittimo di linea di passeggeri, veicoli e merci attraverso navi c.d. Ro-Pax. Moby è controllata congiuntamente dall’armatore Vincenzo Onorato, al quale è riferibile oltre il 60% del capitale sociale, e da L19 S.p.A. (32% del capitale sociale), indirettamente controllata da Clessidra SGR S.p.A., società che gestisce il fondo di investimento riservato denominato Clessidra Capital Partners1. Il fatturato complessivo realizzato da Moby e dal Gruppo Clessidra nel 2009 in Italia è stato di circa [1-2]∗ miliardi di euro. 2. To.re.mar. – Toscana Regionale Marittima S.p.A. -

Experiencing the Water Lands
TOSCANA Experiencing the water lands Livorno, Capraia Island and Collesalvetti between history, culture and tradition www.livornoexperience.com Livorno Experience Experiencing the water lands S E A R C H A N D S H A R E #livornoexperience livornoexperience.com IN PARTNERSHIP WITH S E A R C H A N D S H A R E #livornoexperience Information livornoexperience.com TOURIST INFORMATION OFFICES LIVORNO CAPRAIA ISLAND COLLESALVETTI INDICE Via Alessandro Pieroni, 18 Via Assunzione, Porto Sportello Unico per le Attività Ph. +39 0586 894236 (next to la Salata) Produttive e Turismo EXPERIENCING THE WATER LANDS PAG. 5 [email protected] Ph. +39 347 7714601 Piazza della Repubblica, 32 3 TRAVEL REASONS PAG. 8 www.turismo.li [email protected] Ph. +39 0586 980213 www.visitcapraia.it [email protected] LIVORNO PAG.10 www.comune.collesalvetti.li.it CAPRAIA ISLAND PAG. 30 COLLESALVETTI PAG. 42 EVENTS PAG. 50 HOW TO GET THERE BY CAR BY BUS Coming from Milan, you can take the A1 From Livorno Central Station, the main lines motorway, reaching Parma, and then take the leave to reach the city centre, “Lam Blu” which A15 motorway towards La Spezia and then the crosses the city centre and seafront, “Lam A12 towards Livorno, while from Rome you take Rossa” which crosses the city centre and arrives the A12 motorway, the section which connects at the hamlets of Montenero and Antignano. Rome to Civitavecchia, and then continue The urban Line 12 connects the city centre of along the Aurelia, now called E80, up to Livorno. -

Evento Pianosa
Scheda tecnica per il 14 maggio – evento Pianosa Per raggiungere l’isola di Pianosa è necessaria la prenotazione con la compagnia di navigazione Aquavision (unica autorizzata al trasporto marittimo sull’isola). NB*: Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano consente l’accesso ad un numero limitato di visitatori, è quindi opportuno effettuare la prenotazione prima possibile, mettendo in copia la nostra Sezione [email protected] A Q U A V I S I O N servizi turistici marittimi 0565 976022 & 328 7095470 [email protected] www.aquavision.it Questo l’itinerario di viaggio: partenza da: Marina di Campo 10:15 arrivo a: Isola di Pianosa 11:00 sosta di 6 ore all’Isola di Pianosa partenza da: Isola di Pianosa 17:00 arrivo a: Marina di Campo 17:45 È necessario acquistare il biglietto prenotato presso la biglietteria Aquavision in Piazza dei Marinai d’Italia (a Marina di Campo) non più tardi delle ore 9,30 Adulti ordinari A/R € 23,60 + ticket Parco € 6,00 e bambini 4-12 anni € 11,80 Residenti Arcipelago Toscano A/R € 9,40 e bambini 4-12 anni € 4,70 Programma della giornata: visita guidata del paese; visita agli Orti, inaugurazione della nuova LIMONAIA, pranzo nell’Orto a cura dei Detenuti stessi; visita della Villa Romana di Agrippa. Tempo libero. In questa occasione la Sezione Arcipelago Toscano di Italia Nostra consegnerà al nostro referente per l’isola, Claudio Cuboni, alcune piante di Rosa Rugosa destinate a selezionate aree verdi del piccolo paese. I soci che desiderano partecipare a questa donazione potranno versare € 10,00. -

Porto Azzurro Cavo, Am Strand Nach Portoferraio
136 Der Nordosten der Insel Cavo Cavo Einer der ältesten Badeorte der Insel. Von den heutigen Elba-Touristen wird Cavo allerdings ziemlich vernachlässigt, es fehlt an attraktiven Stränden, und auch sonst wirkt der Ort ziemlich verschlafen. Dabei ist Cavo in nur 15 Minuten mit dem Tragflächenboot vom Festland aus zu erreichen. Im nördlichsten Ort Elbas finden sich einige prächtige Villen der vorletzten Jahrhundertwende, die früher im Besitz der Eisenminenbetreiber waren. Mehrheit- lich sind es aber bescheidene Privathäuser, die das Bild des gleichförmig in der fla- chen Bucht angelegten Dorfes bestimmen. In Cavo gibt es einen kleinen Hafen mit langer Mole und einen mit Kiesel durch- setzten, lang gezogenen Sandstrand mit Sonnenschirm-, Liegestuhl- und Tret- bootverleih. Piombino auf dem Festland scheint von hier zum Greifen nah. Vom Hafen aus hat man auch einen schönen Blick auf die kleine, karge Isola dei Topi („Mäuseinsel“), ihren verwitterten Leuchtturm und den vorgelagerten Felsen Il Frate, den „Bruder“. An der Uferpromenade befinden sich einige Pizzerie und Bars, im Dorf selbst auch eine einfache Rosticceria. Im Hafen liegen zwar einige Yachten, aber ein schicker Seglertreff ist das abgelegene, fast langweilige Cavo sicherlich nicht. Einmal im Jahr – am zweiten Juliwochenende – trifft man sich hier zur Re- gatta mit großem Publikum. Sein historisches Highlight erfuhr Cavo 1849, als Freiheitskämpfer Garibaldi hier auf seinem Weg nach Capraia einen kurzen Zwischenstopp einlegte. Unweit des Orts liegt mitten in der Macchia das Mausoleum Tonietti, das der gleichnamige Bergwerksbetreiber im 19. Jh. als Familiengrabstätte errichten ließ. Der Spazier- gang zum Mausoleum dauert etwa 20 Minuten. Tonietti gehörte auch das Cas- tello, eine festungsartige Villa, die von der Uferpromenade aus zwischen Bäu- men zu erspähen ist. -

Depliant Stampa.Cdr
GUEST SPEAKERS BIBLIOGRAPHY GENERAL INFORMATION Taxi service to reach the meeting venue from: Portoferraio +39 0565 925112 the 4th international meeting Porto Azzurro + 39 0565 910163 Mike Herrtage - DECVDI DECVIM J. Assheuer, M. Sager: More information about the meeting is available on the web site at the following address: www.mri2007.org BY PLANE Cambridge University MRI and CT Atlas of the Dog, Blackwell MRI: Advances in Veterinary Medicine 2007 The Queen's Veterinary School Hosp. - UK MEETING VENUE ELBA AIRPORT - Elba is served by La Pila airport located 2 Science km from Marina di Campo. Once you are at the Marina di Grand Hotel Elba International Campo airport, you can use the Taxi Service to reach the Massimo Baroni - DECVN Baia della Fontanella, 57031 Capoliveri meeting venue (Tel. +39 0565 977150) Clinica Veterinaria Valdinievole MRI Principles Donald G. Mitchel Marc S. Isola d'Elba (Livorno – Italy) PISA AIRPORT - The airport Galileo Galilei of Pisa is the Tel.+39 0565 94611 (to be used only during the meeting) closest international airport to Piombino. Monsummano - Italy Cohen Saunders Web: www.elbainternational.it Please visit the following websites to obtain information about timetables and rates: May 18-20 Konrad Jurina - DECVN REGISTRATION FEES www.elbaisland-airport.it - www.pisa-airport.com ? Capoliveri, Italy Small Animal Clinic Haar - Germany Salmon A.P., Merrit Friedmann B.R., Jones Before May3rd 2007 600 € A TRANSFER will be arranged for meeting delegates from ? After May3rd 2007 and on site 650 € J.P.,Chavez-Munoz G., Merritt C.R.: Pisa airport to Piombino on May 17th. at 15:00 hrs. -
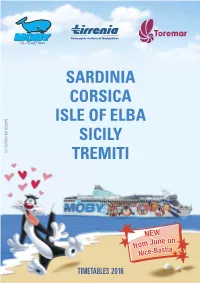
2016-Moby-Lines-Komp.Pdf
THE FRIENDLY SHIPS SARDINIA CORSICA ISLE OF ELBA 10/12/2015 SICILY EDITION ST 1 TREMITI TIMETABLES 2016 THE MOBY-FLEET MOBY AKI AND MOBY WONDER Category: Fast Cruise Ferry - Passengers: 2.200 - Vehicles: 750 FOR SARDINIA 175 meters long, 27 meters broad. Speed 29 knots. Air-conditioning, 320 cabins with private facilities, hair dryer and radio, junior suites for 4 persons, area equipped with coach seats, panoramic show lounge, 4 cafeterias, à la carte restaurant, self-service restaurant, pizzapoint, ice-cream parlor, snackbar, children’s play area, AND CORSICA pool, sundeck, sport bar, kennel for domestic pets, stabilizers. ISPS certification (International Ship and Port facility Security code). Assignment: Comfort Class and Green Star. Sides decorated with “Looney Tunes”. offers you since ever best service, and each day in each season a save crossing because you can count on the experience and a tradition of 130 years within the maritime transportation field. This certificates the Registro Navale Italiano (RINA) by the certification “Safety Manage- ment System”, an international award for quality, security and environment protection executed since 1994. In 2015, MOBY again received the MOBY TOMMY INSTALLATION OF NEW CABINS IN WINTER 2015 quality seal “No. 1 in gold”, a cer- Category: Fast Cruise Ferry - Passengers: 2.200 - Vehicles: 1.000 or 2.000 tification that in Italy is a confir- linear meters mation of guarantee about quality 212 meters long, 25 meters broad. Speed 30 knots. Cabins with private facilities, coach seats, à la carte restaurant, self-service restaurant, for the consumer and about success for the pizzapoint, ice-cream parlor, cafeteria, sport bar, admiral pub, children’s world with video games enterprise.