Mercante Del Trecento
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Saggio D'una Bibliografia Storica Della Lunigiana Per Giovanni
B N C F PfiSS 229 9 * Vl- W9l Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google GIOTANNI SFORZA SAGGIO D’UNA BIBLIOGRAFIA STORICA DELLA LUNiaiANA -J t H ! !' ‘I TOMO PRIMO MODENA TIP. CAR/O VINCBNZI Digitized by Gpogle Digitized by Google SAGGIO D' UNA BIBLIOGRAFIA STORICA DELLA L U N I G I A N A «iovai<ì:«i sforza TOM. I. Part. 1. STATUTI EDITI E INEDITI. Pali. n. OPERE MANOSCRITTE. MODENA TIPOGRAFIA DI CABLO VINCE^IZI ì 87A. Digilìzed by Google C»tr«tlo d*i Voi. VI « VII degli Atti t Memorie delle Aft. />«fu(azioti» di Storio Patria per le Prorinde modenesi e parmensi. Digitized by Google 4^ AD ALESSANDRO MAGNI GRIFFI AMOKOSO RACCOQLITOKK DI PATRIE MEMORIE QUESTA BIBLIOGRAFIA STORICA DELLA LOSIUIANA A TESTIMONIANZA IV AMICIZIA E DI ANIMO RICONOSCESTE INTITOLA GIOVANNI SFORZA I UIVONO UDCCCI.XXII. Digitized by Google DIgitized by Google 0 Lunigiana, fertile, Vasto tirreno lido, Monti, OTO pone ratinila Fra nevi e marmi il nido! Quante memorie destano Nei generosi petti, 1 vostri eterni aspetti, I vostri antichi di. G. FERRani. on ho perdonalo nè a tempo, nè a raiichc, nè a spese per rendere eoinpiula, quanto per me si poteva, questa DibliograHa ; nella quale ho descritto lutti gli Statuti, e tutte le opere cosi edite come inedite, che in cinque anni di pazienti ricerche mi sono venute alle mani, c clic giovano a illustrare, più o meno largamente, la storia politica, legislativa, eccle- siastica, scientifica, artistica, letteraria c commerciale della Lunigiana. Dall'antica città di Luni prende essa il suo nome; ed è una hreve striscia di terra, tra la Toscana e la Liguria, bagnata in parte dal Jdediterraneo e in parte cinta dagli Appennini. -

Scrittura Al Feminile in Lavorazione
Alessandra F. Celi Simonetta Simonetti Memorie nascoste Carte di donne nel territorio apuano (secc. XVI- XX) Dec. Di Medaglia d’ Oro al V.M. 2 Per una storia di genere nel territorio di Massa Carrara 3 4 Presentazione Enrica Briganti Pres. Commissione provinciale Pari Opportunità La realizzazione di una pubblicazione sulla “Scrittura e memoria delle donne” è stata fortemente voluta dalla nuova Commissione provinciale Pari Opportunità, non solo condividendo in questo un percorso iniziato dalla precedente Commissione, ma ritenendo necessario operare una scelta di valorizzazione delle donne del nostro territorio, figure chiave di mediazione politica, sociale e culturale. Affinità elettive quindi hanno guidato la voglia di abbracciare un indirizzo che potesse tutelare la memoria delle donne le cui carte e testimonianze scritte rischiavano di essere frammentate, abbandonate e disperse, in un oblio di valori. Una sorta di cura di genere volta alla salvaguardia di quella rivoluzione silenziosa che le donne, attraverso il rapporto con la scrittura, hanno saputo mettere in campo nel contesto di una storia affascinante e ricca di sé. Riannodare i fili di scritture femminili ha inteso cogliere la trasformazione dell’identità femminile, la capacità creativa di provocare e riflettere, nel costante negoziare con il contesto sociale e culturale del proprio femminile impegno. Lavorare sulla memoria, nella ricerca appassionata dell’essenza della donna nel passato, assume una straordinaria attualità quando attraverso la ricerca si vuol capire e conoscere e poi capire ancora quel «senso proprio dell’esistenza» per dirla con le parole di Carla Lonzi. Mettere a valore l’essenza della donna con una attenzione continua alle forme in cui ha saputo e saprà esprimersi sarà una strada di studio, un indirizzo di ricerca di luoghi comuni dove riscoprire valori collettivi oggi smarriti e depotenziati. -

Pontremoli (S
Dizionario Geografico, Fisico e Storico della Toscana (E. Repetti) http://193.205.4.99/repetti/ Pontremoli (S. Maria) - Vescovati della Toscana (Pontremoli) - Apua ID: 3387 N. scheda: 42040 Volume: 1; 4; 5; 6S Pagina: 102; 543 - 562; 705; 198 - 199 ______________________________________Riferimenti: 25940, 46190 Toponimo IGM: Pontremoli Comune: PONTREMOLI Provincia: MS Quadrante IGM: 084-2 Coordinate (long., lat.) Gauss Boaga: 1570315, 4914474 WGS 1984: 9.88351, 44.38171 ______________________________________ UTM (32N): 570378, 4914649 Denominazione: Pontremoli (S. Maria) - Vescovati della Toscana (Pontremoli) - Apua Popolo: S. Maria Assunta a Pontremoli Piviere: (SS. Ippolito e Cassiano a Saliceto) S. Maria Assunta a Pontremoli Comunità: Pontremoli Giurisdizione: Pontremoli Diocesi: (Luni - Sarzana) Pontremoli Compartimento: Pisa Stato: Granducato di Toscana ______________________________________ PONTREMOLI (Pons Tremulus e Pontremulus ) in Val di Magra. Città nobile, già borgo cospicuo con sovrastante castello e chiesa collegiata, che fu nella Diocesi di Luni-Sarzana, ora cattedrale e residenza di un vescovo suffraganeo del Metropolitano di Pisa, capoluogo di Comunità, con tribunale di Prima istanza ed un commissario regio, nel Compartimento di Pisa. È situata sulla confluenza del torrente Verde, che alla metà del paese si vuota e perde il suo nome nel fiume Magra, il quale bagna la città di Pontremoli dalla parte di grecale, mentre il Verde percorre le sue mura nell-opposto lato. - Passa per Pontremoli l-antica strada Francesca o Romèa , che Clodia e di Monte Bardone fu pure appellata, la quale attraversa il giogo dell'Appennino al varco della Cisa. Trovasi Pontremoli fra il grado 27° 33' di longitudine e 44° 24' di latitudine, circa 28 miglia a settentrione di Sarzana, 26 a maestale di Fivizzano, passando per la via rotabile, 34 a settentrine-maestro di Massa di Carrara, 58 nella stessa direzione da Pisa e 48 a ostro-libeccio di Parma. -

Pagine Fliscane
Giovanni Ferrero Pagine fliscane Isabella Fieschi figlia di Scipione Documenti di archivio Storia locale nuova serie n° 12 Desidero ringraziare l’amico Riccardo Dellepiane per la segnalazione dei documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Genova (Finanza 8) utilizzati per questa breve nota storica. Un ringraziamento particolare alla prof.ssa Graziana Grosso Paglieri, al prof. Mario Traxino ed a Sandro Sbarbaro. Proprietà grafica e letteraria © Giovanni Ferrero 2006 La versione elettronica di “Pagine Fliscane - Isabella Fieschi figlia di Scipione” è stata curata, nell'anno 2006, da Mario Senoglosso La presente copia di “Pagine Fliscane - Isabella Fieschi figlia di Scipione” è stata scaricata dal sito www.valdaveto.net Come tutte le storie anche quella della famiglia Fieschi è formata da un fitto intreccio di vicende più o meno rilevanti. Ma anche i fatti apparentemente meno importanti hanno contribuito altresì a fornire quella visione d’insieme che è poi la traccia lasciata nel tempo da questa nobile famiglia genovese. L’idea di avviare questa nuova collana denominata 'Pagine Fliscane', nasce proprio dalla volontà di raccogliere queste piccole vicende quotidiane che spesso non vengono pubblicate. Crediamo invece che ogni singola vicenda, ogni storia del quotidiano, ogni spaccato di vita, meriti di essere raccolto in piccole pubblicazioni che col tempo possano formare una grande collana. Solo per caso il primo numero riguarda Montoggio e una vicenda che si è svolta nella fortezza che i Fieschi possedevano in questo paese. Sergio Rossi, presidente del Centro Culturale Peppo Dachà di Montoggio Pagine Fliscane - Isabella Fieschi figlia di Scipione Isabella figlia del Conte Scipione Fieschi L’opportunità di poter consultare la documentazione raccolta nella filza Finanza 8 conservata presso l’Archivio di Stato di Genova ci permette di poter accertare la breve presenza nel Castello di Montoggio della “puella” Isabella. -

Serie I, Vol. 1(1863), CLIV, 458 P.Modena, C. Vincenzi
Serie I, vol. 1(1863), CLIV, 458 p.Modena, C. Vincenzi CELESTINO CAVEDONI Dichiarazione di un Bassorilievo Mitriaco ....................................................................................... 1 CESARE CAMPORI Amalia d’Este e il marchese di Villeneuf ......................................................................................... 5 AMADIO RONCHINI Vita della contessa Barbara Sanseverini........................................................................................... 25 ANTONIO CAPPELLI Due lettere inedite di Lodovico Ariosto ........................................................................................... 103 CELSTINO CAVEDONI Dichiarazione di un’antica Iscrizione greca...................................................................................... 105 GIUSEPPE CAMPORI Notizie inedite di Raffaello da Urbino.............................................................................................. 111 AMADIO RONCHINI Notizie biografiche intorno a Iacopo Marmitta parmigiano.............................................................. 149 CARLO BORGHI Memoria su gli Archivi municipale e notarile di Modena ................................................................ 157 CELESTINO CAVEDONI Appendice alla dichiarazione dell’Iscrizione greca suddetta ............................................................ 166 AMADIO RONCHINI La Steccata di Parma........................................................................................................................ 169 CESARE CAMPORI Cenni -

Notizie Sulla Manifattura Dei Cappelli in Massa Di Lunigiana
NOTIZIE SULLA MANIFATTURA DEI CAPPELLI IN MASSA DI LUNIGIANA (SECC. XYII-XIX) Alberico I Cybo-Malaspina, il principe illuminato e virtuoso, cultore delle lettere ed amante delle arti, che, in settanta anni di governo, meritandosi il titolo di Grande, con savie leggi portò a rapidi progressi gli Stati di Massa e Carrara, lasciatigli dalla madre mar chesa Ricciarda Malaspina, non solo protesse e favorì letterati ed artisti, ma dedicò pure assidue cure ai commerci e alle industrie, dando grande impulso a quelle già esistenti e introducendone di nuove, le quali resero prospero e ricco in quei tempi il popolo di Lunigiana. Nel 1561 chiamò da Firenze Matteo Inghirami con alcuni ope rai tedeschi « per rintracciare le miniere del rame, la cui escava - zione nelle montagne massesi era stata praticata, 11011 senza suc cesso, tra la fine del secolo XIII e il principio del secolo XIV », e fece rinnovare poi il tentativo nel 1582 da messer Stopano da Bre scia, e nel 1606 dal « minerista » portoghese Matteo Campos Ra- bello, cui fu concesso per sette anni il privilegio « di cavare egli solo tutte le miniere di Massa e di Carrara » (*). Dette incremento all’industria della lavorazione del ferro che « si cavava dai monti dell’Antona, e gli uomini della Spezia veni vano spesso a Massa per farvi acquisto di ferro buono mercantile ». Introdusse l’arte della seta e con lettere patenti del 20 agosto 1578 ne concesse la privativa, per dodici anni, a Giovanni di Iacopo Magnani in base ai «Capitoli» approvati i! 7 luglio dello stesso anno, per i quali, nel termine di bei mesi « il conduttore » doveva cominciare il lavoro con « uno hedifitio di filatori, e poi continui con quello et di più, segondo che si vederanno riuscire le persone in detto esercitio », essendo intenzione del Principe « che questa arte s'ingrossi » nello Stato. -

C.Stefanelli Catalogo Bibliografico Seconda Parte Archivio Di Stato Lecce
C.Stefanelli Catalogo bibliografico seconda parte Archivio di Stato Lecce collocaz. intestazione descrizione in scheda principale fasc. e pp. note tracciato B 4087 RUSCONI, Antropologia e teologia in L'EUROPA DEL p. 9-19 CARLO cristiana del pellegrinaggio / PELLEGRINAGGIO / L. Arcella… Carlo Rusconi [et al.]. - Rimini: il Cerchio, c 1998. B 4087 ARCELLA, Le reliquie e i confini in L'EUROPA DEL p 21-41 1. RELIQUIE LUCIANO dell'Occidente / Luciano PELLEGRINAGGIO / L. Arcella… Arcella [et al.]. - Rimini: il Cerchio, c 1998. B 4087 CARDINI, Il pellegrinaggio e l'Europa / in L'EUROPA DEL p. 43-63 FRANCO Franco Cardini PELLEGRINAGGIO / L. Arcella… [et al.]. - Rimini: il Cerchio, c 1998. B 4087 CAUCCI von Tradizioni e radici culturali del in L'EUROPA DEL p 65-83 1. SANTUARIO DI SAUCKEN, cammino di Santiago / Paolo PELLEGRINAGGIO / L. Arcella… SANTIAGO DE PAOLO Caucci von Saucken [et al.]. - Rimini: il Cerchio, c 1998. COMPOSTELA *SANTIAGO DE COMPOSTELA v. SANTUARIO DI SANTIAGO DE COMPOSTELA B 4087 GIORGETTI, Il monaco, il povero e il in L'EUROPA DEL p. 85-94 1. OSPITALITA' - ALBERICO pellegrino / Alberico Giorgetti PELLEGRINAGGIO / L. Arcella… Pellegrinaggi [et al.]. - Rimini: il Cerchio, c 1998. B 4087 BENVENUTI, Donne sulla strada: il in L'EUROPA DEL p. 95-113 1. DONNE - Pellegrinaggi ANNA pellegrinaggio femminile nel PELLEGRINAGGIO / L. Arcella… medioevo / Anna Benvenuti [et al.]. - Rimini: il Cerchio, c 1998. C.Stefanelli Catalogo bibliografico seconda parte Archivio di Stato Lecce collocaz. intestazione descrizione in scheda principale fasc. e pp. note tracciato B 4087 DELLA SETA, Esperienze e problematiche in L'EUROPA DEL p. -

Società Ligure Di Storia Patria - Biblioteca Digitale - 2011
ILI. RELAZIONI DkLLK DEPUTAZIONI, SOCIETÀ STORICHE ED ALTRI ISTITUTI Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2011 . ; . Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2011 / — 2 2 1 — i. AQUILA. Società Storica Abruzzese S ignori , Nel Congresso Storico di Firenze ebbi 1’ onore di rassegnarvi come erasi formata la Società Storica Abruzzese, e come intendesse ella di continuare nella sua opera. Ora è mio debito darvi conto del modo come le è stato consentito di mantenere il suo impegno. E se allora mi si porse occasione di rammentare l’ intervento alla sua inaugurazione del comm. Paolo Boselli, in quei giorni supremo moderatore degli studi in Italia, ora non posso non esprimere il com piacimento del sodalizio, per averne egli, qual Presidente onorario, accettato meco l’incarico della rappresentanza in questo onorando Consesso, di cui, per delegazione dei convenuti, tien m eritam ente la direzione. La nostra Società dunque nel trascorso triennio non si è dipar tita dal tracciato sentiero, quanto all’ apportar modestamente qualche illustrazione sui punti controversi ed oscuri della storia abruzzese. Unica sua pubblicazione ordinaria è rimasto il Bollettino semestrale, del quale ò avuto il gradito incarico di presentare in om aggio a questo Congresso, i tre volumi dati in luce, dopo quello ram m en tato di Firenze. In esso, negli svariati articoli e documenti inseriti, si son toccati, sebben rapidamente, i tempi preistorici ed i romani: si è poi men fugacemente discorso dei mezzi tempi, massime di quelli più vicini all’ evo moderno, e di questo in fine più estesa mente; non trascurando quanto à riguardo con la dominazione spa- gnuola, la quale, quantunque cagione di decadenza nelle soggette provincie italiane, pur non manca di destare interesse per le con- Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2011 — 2 2 2 — seguenze sociali che se ne sono fino ai nostri giorni sperimentate. -
Donne E Castelli Di Lunlgiana. La Moglie Di Gian Luigi Fieschi
DONNE E CASTELLI DI LUNLGIANA. LA MOGLIE DI GIAN LUIGI FIESCHI La congiura del 1547, che ha nome dal Fieschi, fu la con- seguenza di tante ragioni, in cui le cause politiche, intrecciate con quelle particolari e domestiche, s’unirono e combinarono per sconvolgere Genova. La casa dei D’Oria, eminente per opera di Andrea, già grande ammiraglio del Cristianissimo poi di Carlo Y Imperatore, stava iper superare ormai l’emula dei Fieschi,. che non jpotea porre in oblio come, pochi anni innanzi, in Vio lata, da Gian Luigi il vecchio era stato accolto e superbamente ospitato re Luigi XII di Francia. E recente era il ricordo del papa Paolo III, che, reduce dal convegno di Nizza, aveva avuto accoglienze nell'avito ipalazzo fieschino. Ma ormai gli splendori del palazzo doriano di Fasso'lo erano onorati della presenza di Cesare, e quindi fra le due casate l’antagonismo vivo. Pure le cause occasionali e concomitanti la fanno essere in rispondenza colla politica delle Corti di Madrid e di Parigi e con il contrasto tra Francia e Spagna per il predominio, che agitò l’Europa e più particolarmente l’Italia per tutta la prima metà del secolo XVI I/ambizione di Gian Luigi, che avrebbe voluto primeggiare nella Repubblica, urtava si con l'alterigia dei D'Oria, venuti su di recente, appetto ai Fieschi, e pur così fieri della conquistata grandezza. Non furono estranei all’odio verso Giannettino gli incita menti di Maria Grosso Della Rovere al figliuolo, che vedeva nell’emulo D’Oria l’ostacolo alle sue mire ambiziose. E v’entraron per mezzo rancori per mal conclusi o per man cati matrimoni e parentadi. -

ARALDICA E GENEALOGIA
GALLERIA GILIBERT DI GILIBERT MASSIMO & C. S.A.S STAMPE E LIBRI ANTICHI Galleria Subalpina 17 -Torino Tel: 011/5619225 www.gilibert.it [email protected] ARALDICA e GENEALOGIA 43360. Almanach de Gotha. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique. 1893. Cent - trentième année. Gotha, Justus Perthes, 1893. In-24°, pp. XXIV, 1267, tela editoriale rossa con titolo, bordura e corona con ramoscelli vegetali in oro. 4 ritratti incisi f.t., di cui uno all'antiporta: la Regina Carlotta del Württemberg, il Re Guglielmo del Württemberg, il Gran Duca di Hesse Ernst Ludwig, il Kedivé d'Egitto Abbas II Hilmi. Etichetta del tempo della libreria Dumolard di Milano. Ottimo stato. Annata del 1893 dell'"Almanacco di Gotha", celeberrimo annuario genealogico, diplomatico e statistico che apparve per la prima volta nel 1763. Ognuno di tali almanacchi costituisce un'autentica miniera di informazioni sulle famiglie nobili, la diplomazia e l'amministrazione dei principali stati europei e dei loro possedimenti extraeuropei. Thomas Von Fritsch, Die gothaischen Taschenbücher, Hofkalender und Almanache, Limburg, 1968, p. 136. € 25,00 43361. Almanach de Gotha. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique. 1898. Cent trente - cinquième année. Gotha, Justus Perthes, 1898. In-24°, pp. XXIV, 1389, (3), legatura t. tela editoriale rossa con titolo, bordura e corona con ramoscelli vegetali in oro. 4 ritratti incisi f.t., di cui uno all'antiporta: la Regina Vittoria, la Regina Wilhelmina dei Paesi Bassi, il Presidente degli Stati Uniti Mc Kinley, il conte Friedrich Solms-Laubach. Ottimo stato. Etichetta del tempo della libreria Fratelli Bocca di Milano. Annata del 1898 dell'"Almanacco di Gotha", celeberrimo annuario genealogico, diplomatico e statistico che apparve per la prima volta nel 1763. -
Wikipedia Wikipedia 2011
Italian War of 1542 –1546 Wikipedia 2011 General Articles about the War Articles on the various Sieges and Battles of the War Biographies of the Italian Warlords, John Dudley and Barbarossa Wikipedia Article on French-Ottoman Alliance William, Duke of Jülich-Cleves-Berg (engraving by Heinrich Aldegrever , c. 1540). William allied himself with Francis I, marrying Jeanne d'Albret , but was defeated by Charles V. Portrait of Claude d'Annebault (school of Jean Clouet , c. 1535). Despite having no experience in naval warfare, d'Annebault commanded the French invasion fleet during the expedition against England. Portrait of Alfonso d'Avalos, Marchese del Vasto, in Armor with a Page (oil on canvas by Titian , c. 1533). D'Avalos was defeated by the French at the Battle of Ceresole , but won a later victory at the Battle of Serravalle . Thomas Howard, 3rd Duke of Norfolk (oil on wood by Hans Holbein , 1539). Sent to France by Henry VIII, Norfolk commanded the English troops during the unsuccessful Siege of Montreuil . Battles and sieges in northern France and the Low Countries during the war Coats of arms of Kingdom of France, of the famous Florentine family of the Strozzi . and Gonzaga Ottoman depiction of the Siege of Nice (Matrakçı Nasuh , 16th century) File:French fleet with Barbarossa at the Siege of Nice 1543.jpg The French fleet attacks the Isle of Wight (unknown artist, 16th century) File:The French fleet attacks Bembridge.jpg Ratification of the Treaty of Ardres by Henry VIII (1546) Henry of France by François Clouet . The Duke of Alba by Anthonis Mor . -
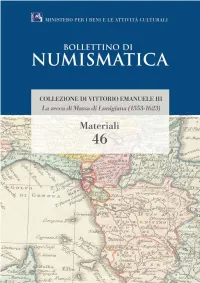
Materiali N. 46-2016
MUSEO NAZIONALE ROMANO Medagliere LA COLLEZIONE DI VITTORIO EMANUELE III collana a cura di SILVANA BALBI DE CARO GABRIELLA ANGELI BUFALINI Ministero............................................................................................................................... per i beni e le attività..................................................... culturali BOLLETTINO DI NUMISMATICA MATERIALI Numero 46 – Ottobre 2016 ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO LA COLLEZIONE DI VITTORIO EMANUELE III LA ZECCA DI MASSA DI LUNIGIANA Alberico I Cybo Malaspina, marchese (1553-1568) e principe di Massa (1568-1623) di Gianluigi Esposito Sommario Introduzione . p . 5 Alberico I Cybo Malaspina (1553-1623) . » 6 Le imprese . » 7 I nominali . » 12 Zecchieri e ubicazione della Zecca . » 17 Note . » 19 CATALOGO . » 23 Abbreviazioni bibliografiche . » 196 Indici . » 199 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI BOLLETTINO DI NUMISMATICA c/o Museo Nazionale Romano - Medagliere Palazzo Massimo alle Terme Piazza dei Cinquecento, 67 – 00185 Roma www.numismaticadellostato.it Direttore DANIELA PORRO Capo redattore e coordinatore di redazione GABRIELLA ANGELI BUFALINI Redazione SIMONE BOCCARDI, FABIANA LANNA [email protected] Responsabile settore grafico STEFANO FERRANTE Comitato scientifico Ermanno A. Arslan, Renata Cantilena, Emanuela Ercolani Cocchi, Salvatore Garraffo, Giovanni Gorini, Andrea Saccocci, Aldo Siciliano Roma 2019 Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III Bollettino di Numismatica, Materiali 46 (2016) Gianluigi Esposito LA ZECCA DI MASSA DI LUNIGIANA Alberico I Cybo Malaspina, marchese (1553-1568) e principe di Massa (1568-1623) di Gianluigi Esposito Introduzione La zecca di Massa di Lunigiana fu attiva, sia pure con alcuni periodi di chiusura, dal 1559/1560 al 1667 e, per soli progetti, nella prima metà del Settecento; le monete del 1792 a nome della duchessa Maria Beatrice d’Este Cybo Malaspina furono invece battute nella zecca di Milano .