Piano Intervento Azione C2 Coornata[1]
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
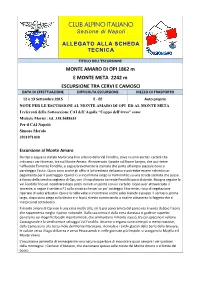
Scheda Escursioni Monte Amaro E Monte Meta
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Napoli ALLEGATO ALLA SCHEDA TECNICA TITOLO DELL’ESCURSIONE MONTE AMARO DI OPI 1862 m E MONTE META 2242 m ESCURSIONE TRA CERVI E CAMOSCI DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO 12 e 13 Settembre 2015 E - EE Auto proprie NOTE PER LE ESCURSIONI AL MONTE AMARO DI OPI ED AL MONTE META I referenti della Sottosezione CAI dell’Aquila “Coppo dell’Orso” sono: Michele Morisi : tel. 338.5688653 Per il CAI Napoli: Simone Merola 3931971038 Escursione al Monte Amaro Da Opi si segue la statale Marsicana fino al bivio della Val Fondillo, dove vi sono anche i cartelli che indicano i vari itinerari, tra cui Monte Amaro. Attraversato il ponte sul fiume Sangro, che qui riceve l’affluente Torrente Fondillo, si segue brevemente la sterrata che porta all’ampio piazzale dove si parcheggia l’auto. Qui ci sono anche gli uffici e la foresteria del parco e potrebbe essere richiesto un pagamento per il parcheggio. Quindi ci si incammina lungo la Val Fondillo su una strada sterrata che passa a fianco della vecchia segheria di Opi, con il limpidissimo torrente Fondillo poco distante. Bisogna seguire la val Fondillo fino ad incontrare dopo pochi minuti un ponte con un cartello. Dopo aver attraversato il torrente, si segue il sentiero F1 sulla sinistra che per un po’ costeggia il torrente, ricco di vegetazione ripariale di salici arbustivi. Qua e là nella valle si incontrano anche salici bianchi e pioppi. Il sentiero, prima largo, dopo poco piega sulla destra e si fa più stretto cominciando a risalire attraverso la faggeta che si inerpica nel sottobosco. -

Valle Fiorita Le Forme
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Campobasso Data 27.05.2012 Escursione “LE FORME – PASSO DEI MONACI – ALTOPIANO DEL BISCURRI - CAMPITELLI DI ALFEDENA- LE FORME” Interregionale CAI: Campania, Lazio, Molise Referente Franco PASSARELLA – Sezione di Campobasso – 3396419067 Accompagnatori Franco Passarella, Anna Scocchera, Tonino D’Alessandro regione Molise Referenti Regione Annamaria Martorano (3389498441), Lucio Polverino (3383169561) Campania Difficoltà e tipo di EE escursione Collaborazioni GR CAI MOLISE, GR CAI CAMPANIA, GR CAI LAZIO Località e quota di partenza : “Le Forme” (Valle Fiorita) - 1400 m. Dislivello complessivo : 600 m. circa positivo (in salita) – 600 m. circa negativo (in discesa) Quota massima raggiunta : 1967 m. Durata escursione (tempo escluso 6 ore circa, soste escluse. soste) : Percorso ad anello di circa 11,5 km. Dal pianoro Le forme a Passo dei Sviluppo chilometrico e Monaci 4,5 km circa. Da Passo dei Monaci al Pianoro Campitelli di Alfedena circa 5,5 km. Da Campitelli alle Forme circa 1,5 km. caratteristiche del percorso: Carrarecce, sentieri, tratto di sentiero morenico, non presenti tratti esposti, segnaletica abbastanza evidente. Descrizione dell’itinerario e motivi d’interesse: Per arrivare con l’automobile alla località “Le Forme”, meglio conosciuta come Valle Fiorita, occorre salire con 16 tornanti e per 11 km dal comune di Pizzone (750 s.l.m.). I pulmann 54 posti salgono, ma c’è il rischio di trovare qualche grande masso che potrebbe restringere la carreggiata. Dal piazzale, dove termina la strada asfaltata in località Le Forme (1400 s.l.m.) , si lasciano le auto e inizia l’escursione. Si entra a ovest nella faggeta e si percorre il sentiero indicato dal segnavia M1. -

Anello Del Monte Cavallo E Monte Forcellone Gruppo Delle MAINARDE - Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio E Molise
Club Alpino Italiano Sezione di Ascoli Piceno Via Serafino Cellini www.caiascoli.it - Ciclo “Cinque uscite cinque cime” Anello del Monte Cavallo e Monte Forcellone Gruppo delle MAINARDE - Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise- DATA ESCURSIONE: 16-17 ottobre 2010 ORA PARTENZA: ore 16.00 del 16 ottobre 2010 con auto propria RITROVO: Via Recanati (di fronte mercato coperto piazza Immacolata) IMPEGNO LUNGHEZZA COMPLESSIVA 12 km. circa FISICO: DISLIVELLO COMPLESSIVO 900 m.circa DIFFICOLTA’ EE ( brevi tratti esposti) TECNICA: DURATA: 5-6 h circa (soste escluse) ACCOMPAGNATORI: Carpani Valeria, Galanti Katia & D’Uva Enrico Premessa L’ escursione del 17 ottobre sara' effettuata in uno degli scenari naturali più suggestivi e selvaggi del Parco tra Lazio e Molise, nel Gruppo delle Mainarde, la catena più a sud dei Monti del Parco d´Abruzzo. Il percorso per raggiungere dapprima il Monte Cavallo (2000 m.), e quindi il Monte Forcellone, si snoderà principalmente tra ampie valli e suggestive faggete, pianori carsici di origine glaciale e boschi dove vivono orsi bruni marsicani e lupi appenninici oltre agli ormai diffusissimi cervi e camosci. L’escursione vera e propria sarà effettuata di domenica con partenza alle ore 08.15 dal piazzale antistante il Rifugio di Prato di Mezzo. Coloro che vorranno aderire all’iniziativa partendo la domenica mattina dovranno specificarlo al momento dell’adesione. Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 45158 oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it Club Alpino Italiano Sezione di Ascoli Piceno Via Serafino Cellini www.caiascoli.it - VISTA SUL MONTE CAVALLO Descrizione itinerario stradale per coloro che intendessero partecipare alla sola escursione del 17-10-2010 Ascoli-Picinisco km 220 circa. -

CATENA DELLE MAINARDE Parco Nazionale Abruzzo Lazio E Molise
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Bari via Volpe 6 70100 BARI 080.5559602 www.caibari.it 11 – 12 APRILE 2015 Passo dei Monaci (m. 1967) CATENA DELLE MAINARDE Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise Organizzatori: Giuseppe Labellarte: tel. 349 2112852 – Paolo Tempesta: tel. 3288399229 Partenza da Bari: sabato 11 aprile ore 15,00 c/o il supermercato Famila di V.le della Resistenza Grado difficoltà: EAI (escursionisti in ambiente innevato) Possibilità di pernottamento: CASTEL DI SANGRO - Hotel “Il Lavatoio” Tel. 338 3690024 ************************************************************************************** AVVICINAMENTO STRADALE: • (giorno 11) - A14 uscita Castel di Sangro – SS652 fino a Castel di Sangro (Bari - Castel di Sangro = Km 313 ca – tempo: h 3,47) • (giorno 12) - Partenza: Castel di Sangro – girare a sinistra: SS17 in direzione di NAPOLI - girare a destra: SS652 in direzione Venafro - girare a destra: ss158 in direzione di: Alfedena – Pizzone ( Castel di Sangro – Pizzone = Km 28 – tempo: 30 min). Da Pizzone (724 m s.l.m.) si raggiunge, attraverso una serie di tornanti, l’altopiano Le Forme nella Vallefiorita (1400 m) da cui si gode lo spettacolare scenario della catena delle Mainarde ricoperta da foresta selvaggia, a tratti impenetrabile. Parcheggio auto e ritrovo con soci di altre sezioni: ore 9,00. PERCORSO ESCURSIONISTICO: Gruppo Montuoso: APCEN088 Monti della Meta Numerazione: Tappa 17 Difficoltà: EAI Descrizione itinerario: Valle Fiorita - Pianoro Le Forme – Acquedotto Le Forme e Rifugio- Faggeta - Valle Pagana- Passo dei Monaci Quota partenza: Valle Fiorita (Pizzone) 1400 mslm Quota arrivo: Passo dei Monaci 1967 mslm Dislivello: in salita: mt 567 Tempo di percorrenza (ore 6,30): 3.30 andata e 3.00 ritorno Descrizione del percorso Salendo dal centro abitato di Pizzone (quota mt 750) con le automobili sull'asfaltata per circa 12 Km con 16 tornanti si arriva nel Pianoro delle Forme (mt 1400), meglio conosciuto come "Valle Fiorita". -

Guida Turistica Della Provincia Di L'aquila
parchi in provincia di laquila Parchi in Provincia di LAquila parchi in provincia di laquila La provincia dellAquila compren- sante laziale con il parco naturale de nel suo territorio ben tre parchi dei Monti Simbruini, rappresen- nazionali: lo storico parco dAbruz- tando così il terreno ideale per le- zo, i recenti parchi del Gran Sas- scursionista desideroso di cono- so-Monti della Laga e della Maiel- scere ambienti incontaminati e di la, oltre al parco regionale Siren- rara bellezza. te-Velino: confina inoltre sul ver- 180 parchi in provincia di laquila PARCO NAZIONALE nale dAbruzzo conserva è ricco di DABRUZZO molte altre specie. Basta ricordare che qui vivono 40 mammiferi di- Lalta valle del fiume Sangro al con- versi, 250 specie duccelli, 30 spe- fine meridionale, dove lAbruzzo in- cie di rettili e anfibi oltre a 1200 contra il Molise e il Lazio, ospita il specie di piante superiori. parco Nazionale dAbruzzo, il se- Queste ultime formano le grandi fo- condo dei Parchi Italiani per anzia- reste che coprono 24.000 ettari di nità, essendo stato istituito nel territorio. È il faggio che domina il 1923; è quello che ha contribuito panorama, con esemplari che rag- più di tutti a diffondere nuova sen- giungono dimensioni ragguardevo- sibilità nei confronti della protezio- li, come nel bosco della difesa, a ne ambientale, dopo essere stato Pescasseroli. Nei pressi di Barrea seriamente in pericolo nei decenni troviamo la betulla e oltre il limite scorsi. Lidrografia del territorio ha della faggeta il pino mugo, che ri- disegnato unarea ideale, con alte copre le balze più alte della camo- vette che fanno da cornice perfetta sciara, presente solo qui e sulla alla valle del fiume Sangro, che Maiella. -

Il Lago Di Castel S. Vincenzo E L’Antica Terra Vulturnense
IL LAGO DI CASTEL S. VINCENZO E L’ANTICA TERRA VULTURNENSE Le Guide di IL LAGO DI CASTEL S. VINCENZO E L’ANTICA TERRA VULTURNENSE LE MAINARDE - IL FIUME VOLTURNO SAN VINCENZO AL VOLTURNO - I PAESI LE TRADIZIONI - LE NOTIZIE UTILI Le Guide di altri ITINERARI IL LAGO DI CASTEL SAN VINCENZO E L’ANTICA TERRA VULTURNENSE Foto e cura del volume Tobia PAOLONE Testi Tobia PAOLONE, Ida DI IANNI, Natalino PAONE, Federico MARAZZI, Michele RADDI, Domenico D’AGOSTINO, Luigi VISCIONE. Direzione Editoriale Ida DI IANNI Progetto grafico e impaginazione Tobia PAOLONE Traduzioni Angela PITASSI Marinella DI IANNI translation.com Referenze fotografiche Tobia Paolone, Archivio Volturnia Edizioni Missione Archeologica San Vincenzo al Volturno Natalino Paone Soprintendenza B.A.A.S. del Molise Autorizzazione su Concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Prot. n. 7795 dell’8/10/2007 Realizzazione editoriale Volturnia Edizioni Piazza Santa Maria, 5 86072 Cerro al Volturno (IS) Tel. & Fax 0865 953593 www.volturniaedizioni.com [email protected] In collaborazione con Associazione Amici di San Vincenzo al Volturno onlus Regione Molise Assessorato al Turismo Soprintendenza Beni Archeologici del Molise Tutti i diritti sono riservati, vietata la riproduzione anche parziale di testi, foto e disegni senza il permesso scritto dell’editore. Finito di stampare nel mese di settembre 2009 Copyright © 2009 Volturnia Edizioni Alta Valle del Volturno - 5 S O M M A R I O IL TERRITORIO 8 Il Lago di Castel San Vincenzo 12 Le Mainarde 16 Il Parco Nazionale -

Parco Nazionale D'abruzzo, Lazio E Molise
A COCULLO AA A A A PARCO NAZIONALE AA D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE ORTA A AA A GP AO A A SR479 A AA A GP LEC A AAGO SP17 SS83 7 Lago di Scanno 21 A Rosa Pinnola A Gioia 22 Vecchio F. Giovenco Lecce Monte Vecchia A marvelous Fontecchia Monte Rifugio Argatone Del Diavolo Rifugio di AVAA 16 Terraegna display of nature Rifugio La Navetta Cicerana Selva 12 Coppo 24 Moricento del Morto Fiume Sangro Piano Aremogna Monte Monte 17 Marcolano Rifugio di Prato Rosso Pratello Monte Passo Godi Val Cervara Godi 14 Monte Toppe del 5 Tesoro della Corte Ferroio SS83 di Scanno SR479 Rifugio Lago Prati d’Angro Serra Rocca Pantaniello A Chiarano Monte Monte Marsicano Mattone Monte 4 Cornacchia Monte Monte VILLETTA Greco La Rocca 11 OPI 25 BAA 9 Coppo 20 Val Fondillo del Principe Lago di Barrea Monte T. Fondillo 19 Serrone 23 BAA T. Scerto Monte 15 Fiume Sangro 10 SR509 Amaro Rifugio della Liscia 8 Vallone Lacerno 18 A A Rifugio Cacciagrande Acqua Camosciara A Monte Valle Iancino SR666 Sfranatara AA PESCOSOLIDO Tranquillo Monte Val di Rose AA SS83 Capraro Rifugio Forca Resuni A A A GP Lago Vivo Monte Petroso Lago Montagna A ATO Spaccata Pianoro VA OMINO Campitelli 26 AVITO Rocca Monte Altiera Meta Rifugio GP SR509 del Falco Pianoro Valle di Canneto di Valle MOLISE 13 Le Forme SS158 6 SS627 A Lago di Grottacampanaro A A O SETATI Prati Monte A di Mezzo PIZZONE 4 2 0 4 a Mare Lago di Castel Fiume Melfa San Vincenzo Scala 1:200.000 Monte Cavallo ROCCHETTA PICINISCO AVO A OLTURNO A OLTURNO Monte A Marrone A Area of te ar Lago Main mountain peaks Museums /other places of interest A A Selva SS627 Buffer Zone Mountain refuge or shelter Bear Enclosure AACINISCO Region boundaries UNESC sites Chamois Enclosure VATONDA A otorays Walking route Deer Enclosure Main roads GP Scenic route Lynx Enclosure Municipalities within the Park Park headquarters Wolf Enclosure Other municipalities Visitor Centre of the Park PARK FACTS VISITORS CENTERS AND OTHER POINTS OF INTEREST Name Abruzzo, Lazio and Molise National Park Park Library - Via Rovereto, 2 PESCASSEROLI (AQ) - Tel. -

14 Luglio 2019 Escursione: L'anello Di Monte Meta Referente
Sottosezione di Montaquila – Valle del Volturno Data: 14 Luglio 2019 Escursione: L’anello di Monte Meta Referente D’Alessio Roberto: tel.: 339 6102491; e-mail: [email protected] Difficoltà: Percorso ad anello, con difficoltà tecniche , EE dipendenti dalla natura dei luoghi e dall’escursione altimetrica Non richiesta attrezzatura tecnica ma una sufficiente capacità di orientamento e allenamento alla camminata. DATI DEL PERCORSO Località e quota di partenza: Piazzale di Valle Fiorita –1398 mt s.l.m. Località e quota di Piazzale di Valle Fiorita – 1398 mt s.l.m. arrivo: Dislivello assoluto: 844 mt in salita; - lo stesso in discesa Dislivello complessivo: 844 mt in salita; 1.000 mt in discesa Quota massima raggiunta: 2242 mt (M. Meta) Distanza: 12,5 km ca. Durata escursione: 6 ore, soste escluse Motivi d’interesse: Una escursione bellissima, interessante e ricca di sorprese che dal Pianoro Le Forme, anche conosciuto come Valle Fiorita, porta alla sommità del monte Meta, a 2242 metri di altezza. La montagna è la terza cima del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e si trova al confine tra le tre regioni che condividono questo importante parco. L’escursione parte dal Piazzale di Valle Fiorita a quota 1398 mt s.l.m., in un’area ricca di biodiversità e che si pregia della presenza di numerose specie faunistiche: dall’orso marsicano al camoscio appenninico, dal cervo al lupo e all’aquila reale. Ai piedi dei Monti della Meta e della Catena delle Mainarde si trova il Rifugio del Falco e da questo punto strategico partono i sentieri M1 – M6 – M10 – L1 – L4 – K2 – K3 del Parco. -

Passo Monaci (M. 1967) Dal Pianoro Le Forme - Valle Fiorita Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio E Molise
Club Alpino Italiano ______________________________________________________________________________________ SEZIONE DI NAPOLI DATA : 29 giugno 2014 PASSO MONACI (M. 1967) DAL PIANORO LE FORME - VALLE FIORITA PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE Quota di partenza: m. 1400. Quota massima: m. 1967. Dislivello in salita: m. 567. Dislivello in discesa: m. 567. Sviluppo del percorso: Percorso ad anello di circa 11,5 km. Dal pianoro Le Forme a Passo dei Monaci 4,5 km circa. Da Passo dei Monaci al Pianoro Campitelli di Alfedena circa 5,5 km. Da Campitelli alle Forme circa 1,5 km. Caratteristiche del percorso: Carrarecce, sentieri, tratto di sentiero morenico, non presenti tratti esposti, segnaletica abbastanza evidente. Durata: ore 6 soste escluse. Difficoltà: E Equipaggiamento: scarponi, bastoncini, giacca a vento o mantella, guanti, berretto da sole e di lana, borraccia, occhiali da sole, telo termico, crema solare, kit pronto soccorso per uso personale e scheda con farmaci per eventuali allergie. Indumenti di ricambio (scarpe, calze, maglietta, etc.). Si consiglia un abbigliamento traspirante a strati (a cipolla). Attrezzatura: binocolo, macchina fotografica, lampada frontale. Colazione: al sacco. Acqua: da portare (almeno 2 litri in quanto lungo il percorso non vi è possibilità di approvvigionamento). Mezzi di trasporto: auto proprie. Appuntamento: contattare i direttori di escursione. Rientro previsto a Napoli: ore 20,00. Carta dell’escursione: Parco d’Abruzzo – Carta dei Sentieri – 1:50.000. Direttori: Claudio Solimene (3480536215) – Eugenio Pascucci (3476743074). Descrizione dell’itinerario e motivi d’interesse: Per arrivare con l’automobile alla località “Le Forme”, meglio conosciuta come Valle Fiorita, occorre salire con 16 tornanti e per 11 km dal comune di Pizzone (750 s.l.m.). -

ATTENZIONE AREA REGOLAMENTATA Lazio E Molise
arco ’AbruzzoNAZIONALE ATTENZIONE AREA REGOLAMENTATA Lazio e Molise DISCIPLINA DEL FLUSSO TURISTICO NELLE AREE DI PRESENZA DEL CAMOSCIO APPENNINICO di Val di Rose e Valle Jannanghera DAL 28 LUGLIO AL 2 SETTEMBRE 2018 Il Camoscio appenninico costituisce insieme all’Orso bruno marsicano ed il Lupo, la peculiarità faunistica più preziosa del Parco e dell’intero Appennino. La popolazione di camosci che vive nell’area Val di Rose - Valle Jannanghera insieme all’elevata biodiversità e presenza di specie sia di flora che di fauna presenti, meritano la massima tutela e attenzione da parte dell’Ente Parco. Pertanto, nell’interesse della conservazione dell’area e delle specie che in questa vivono, l’Ente Parco ha disposto una regolamentazione del flusso turistico. REGOLAMENTAZIONE PER L’ACCESSO 1. L’ACCESSO ALL’AREA DI VAL DI ROSE E VALLE JANNANGHERA AVVERRÀ ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO I SENTIERI I1 E K6;. 2. L’ACCESSO AI PREDETTI ITINERARI POTRÀ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE IN GRUPPI PREFISSATI CON L’ACCOMPAGNAMENTO DI UNA GUIDA. L’ESCURSIONE PARTIRA’ NEI GIORNI DI: MARTEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’, SABATO E TUTTI I FESTIVI DA CIVITELLA ALFEDENA 3. L’INGRESSO E’ CONSENTITO AD UN NUMERO MINIMO DI 5 PERSONE E UN NUMERO MASSIMO DI 50 PERSONE AL GIORNO NEI GIORNI FERIALI E AD UN NUMERO MINIMO DI 5 PERSONE E UN NUMERO MASSIMO DI 80 PERSONE NEI GIORNI FESTIVI; 4. NEL CASO DI PUBBLICO PROVENIENTE DA ACCESSI NON CONTROLLATI (O5), E’ CONSENTITA SOLTANTO LA DISCESA LUNGO LA VALLE JANNANGHERA. SONO IN OGNI CASO VIETATE DIVAGAZIONI FUORI DAI TRACCIATI DEI SENTIERI; 5. LE ESCURSIONI SONO ASSICURATE ATTRAVERSO GUIDE AUTORIZZATE DAL PARCO, MESSE A DISPOSIZIONE DALLA ARCTOS GUIDE; 6. -

CLUB ALPINO ITALIANO Sezioni Di Tivoli E Monterotondo
CLUB ALPINO ITALIANO Sezioni di Tivoli e Monterotondo SCHEDA TECNICA TITOLO DELL’ESCURSIONE MONTE META 2242 m e MONTE AMARO DI OPI 1862 m ESCURSIONI TRA CERVI E CAMOSCI DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA’ ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO 12 e 13 Settembre 2015 E - EE Auto proprie ESCURSIONI ORGANIZZATE IN COLLABORAZIONE TRA LESEZIONI CAI DI TIVOLI, MONTEROTONDO E LA SOTTOSEZIONE CAI DELL’AQUILA “COPPO DELL’ORSO” PROGRAMMA Sabato 12 settembre: ore 07:00 partenza dalla sede CAI Monterotondo. Ore 7:40 appuntamento con i Soci Sezione CAI di Tivoli presso il Bar PIT STOP al n° della SP 51A Maremmana Inferiore (vicino Elettrauto), dotato di parcheggio interno; Ore 9:30 arrivo a Barrea nella zona di inizio escursione (Valico di Barrea 1141 m) Ore 10:00 inizio escursione: difficoltà:E fino al Lago Vivo; dislivello in salita e in discesa: 650 m. Tempo di salita ore 2:00; tempo di discesa ore 1:30; dal Lago Vivo sarà possibile effettuare ulteriori percorsi (variabili tra cui anche Monte Meta) alla ricerca dei Cervi. tempo totale comprese le varianti e le soste: ore 10,00. Oltre il Lago Vivo la difficoltà escursionistica è di tipo EE. Ore 20:00 Trasferimento in auto all’albergo “Ai quattro camosci” in località Civitella Alfedena (nei pressi del Lago di Barrea). Ore 20:20 Sistemazione e relax; Ore 21:00 Cena. Domenica 13 sett.: Ore 07:00 colazione e ritiro pranzo al sacco presso l’Albergo; trasferimento in auto in Val Fondillo Ore 7:30 arrivo ingresso Val Fondillo ed escursione al Monte Amaro (1862 m) – Difficoltà:E, dislivello in salita e in discesa: 778 m. -

Alba Sul Monte Meta Referente La Porta Carmelo Tel.; 3403380962; E-Mail: [email protected] Difficoltà E (Notturna) Collaborazioni
Data 31 maggio - 01 giugno 2014 Escursione Alba sul Monte Meta Referente La Porta Carmelo tel.; 3403380962; e-mail: [email protected] Difficoltà E (notturna) Collaborazioni DATI DEL PERCORSO Località e quota di partenza: Valle Fiorita (Pizzone) m. 1395 Località e quota di arrivo: Monte Meta m. 2242 Dislivello complessivo: m. 970 in salita, lo stesso in discesa Dislivello assoluto: m. 847 Quota massima raggiunta: m. 2242 (M. Meta) Distanza: 13 km Durata escursione: 6h (soste escluse) Motivi d’interesse: Il Monte Meta (2242 m s.l.m.) è una delle maggiori cime dell'Appennino abruzzese compresa all'interno del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. È situato sul confine tra Lazio, Abruzzo e Molise: tra i comuni di Alfedena (AQ), Picinisco (FR) e Pizzone (IS), ai suoi piedi si trova il Passo dei Monaci (1981 m s.l.m.). Conosciuto più spesso con la denominazione al femminile la Meta, dà il nome ad una catena montuosa detta Monti della Meta che dal Valico di Forca d'Acero procede verso la Valle di Comino meridionale e digrada nelle valli del Liri e del Volturno prendendo il nome di Mainarde nelle cime più basse e più meridionali in cui la presenza dell'uomo per il clima meno rigido era stanziale (abitazioni e coltivi in quota) e non stagionale e pastorale come per i Monti della Meta. Di questi luoghi è interessante l'aspetto floristico e vegetazionale di tipiche specie delle vallate appenniniche di alta quota, per quanto riguarda la fauna è facilmente possibile incontrare i Camosci d'Abruzzo, con un po' di fortuna l'Orso bruno marsicano e vedere il volteggiare dell'Aquila reale.