Maffei Clara
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
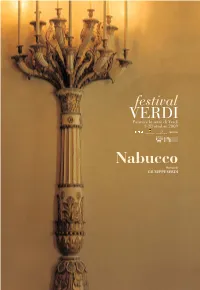
Libretto Nabucco.Indd
Nabucco Musica di GIUSEPPE VERDI major partner main sponsor media partner Il Festival Verdi è realizzato anche grazie al sostegno e la collaborazione di Soci fondatori Consiglio di Amministrazione Presidente Sindaco di Parma Pietro Vignali Membri del Consiglio di Amministrazione Vincenzo Bernazzoli Paolo Cavalieri Alberto Chiesi Francesco Luisi Maurizio Marchetti Carlo Salvatori Sovrintendente Mauro Meli Direttore Musicale Yuri Temirkanov Segretario generale Gianfranco Carra Presidente del Collegio dei Revisori Giuseppe Ferrazza Revisori Nicola Bianchi Andrea Frattini Nabucco Dramma lirico in quattro parti su libretto di Temistocle Solera dal dramma Nabuchodonosor di Auguste Anicet-Bourgeois e Francis Cornu e dal ballo Nabucodonosor di Antonio Cortesi Musica di GIUSEPPE V ERDI Mesopotamia, Tavoletta con scrittura cuneiforme La trama dell’opera Parte prima - Gerusalemme All’interno del tempio di Gerusalemme, i Leviti e il popolo lamen- tano la triste sorte degli Ebrei, sconfitti dal re di Babilonia Nabucco, alle porte della città. Il gran pontefice Zaccaria rincuora la sua gente. In mano ebrea è tenuta come ostaggio la figlia di Nabucco, Fenena, la cui custodia Zaccaria affida a Ismaele, nipote del re di Gerusalemme. Questi, tuttavia, promette alla giovane di restituirle la libertà, perché un giorno a Babilonia egli stesso, prigioniero, era stato liberato da Fe- nena. I due innamorati stanno organizzando la fuga, quando giunge nel tempio Abigaille, supposta figlia di Nabucco, a comando di una schiera di Babilonesi. Anch’essa è innamorata di Ismaele e minaccia Fenena di riferire al padre che ella ha tentato di fuggire con uno stra- niero; infine si dichiara disposta a tacere a patto che Ismaele rinunci alla giovane. -

EJ Full Draft**
Reading at the Opera: Music and Literary Culture in Early Nineteenth-Century Italy By Edward Lee Jacobson A dissertation submitted in partial satisfacation of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Music in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Mary Ann Smart, Chair Professor James Q. Davies Professor Ian Duncan Professor Nicholas Mathew Summer 2020 Abstract Reading at the Opera: Music and Literary Culture in Early Nineteenth-Century Italy by Edward Lee Jacobson Doctor of Philosophy in Music University of California, Berkeley Professor Mary Ann Smart, Chair This dissertation emerged out of an archival study of Italian opera libretti published between 1800 and 1835. Many of these libretti, in contrast to their eighteenth- century counterparts, contain lengthy historical introductions, extended scenic descriptions, anthropological footnotes, and even bibliographies, all of which suggest that many operas depended on the absorption of a printed text to inflect or supplement the spectacle onstage. This dissertation thus explores how literature— and, specifically, the act of reading—shaped the composition and early reception of works by Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, and their contemporaries. Rather than offering a straightforward comparative study between literary and musical texts, the various chapters track the often elusive ways that literature and music commingle in the consumption of opera by exploring a series of modes through which Italians engaged with their national past. In doing so, the dissertation follows recent, anthropologically inspired studies that have focused on spectatorship, embodiment, and attention. But while these chapters attempt to reconstruct the perceptive filters that educated classes would have brought to the opera, they also reject the historicist fantasy that spectator experience can ever be recovered, arguing instead that great rewards can be found in a sympathetic hearing of music as it appears to us today. -

Verdi-Handbuch
Verdi-Handbuch Bearbeitet von Anselm Gerhard, Uwe Schweikert 2., überarbeitete und erweiterte Auflage; 25 Notenbeispiele 2013. Buch. xlii, 757 S. Hardcover ISBN 978 3 476 02377 3 Format (B x L): 17 x 24,4 cm Gewicht: 1443 g Weitere Fachgebiete > Musik, Darstellende Künste, Film > Musikwissenschaft Allgemein > Einzelne Komponisten und Musiker Zu Inhaltsverzeichnis schnell und portofrei erhältlich bei Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte. Verdi Handbuch Verdi.indb I 07.05.13 15:36 2 Verdi-Bilder von Anselm Gerhard Giuseppe Verdi ist allgegenwärtig. Bis in die Fern- Verdis Selbststilisierung sehwerbung hinein begegnen seine Melodien. Seine Opern gehören neben denen Mozarts und Eine der erstaunlichsten Erkenntnisse der Verdi- noch vor den Musikdramen Richard Wagners zu Forschung der letzten Jahrzehnte war die Feststel- den meistgespielten nördlich und südlich der Al- lung, mit welcher Kaltblütigkeit Verdi ein sorgfäl- pen, innerhalb wie außerhalb Europas. Sein Kon- tig retuschiertes Bild seiner Person in Umlauf ge- terfei ist beileibe nicht nur den Italien-Touristen bracht hatte und wie wenig Wert er dabei auf präsent, die sich noch an die zwischen 1962 und Wahrheit legte. Julian Buddens Feststellung, dass 1981 ausgegebenen Tausend-Lire-Note erinnern. »Verdi im fortgeschrittenen Leben dazu neigte, Ebenso allgegenwärtig sind die Bilder, die sich das zu vergessen, was er nicht erinnern wollte« Musikfreunde, Opernfans, Theatermacher, Mu- (Budden 1973, Bd. -

Portrait of Italian Jewish Life (1800S – 1930S) Edited by Tullia Catalan, Cristiana Facchini Issue N
Portrait of Italian Jewish Life (1800s – 1930s) edited by Tullia Catalan, Cristiana Facchini Issue n. 8, November 2015 QUEST N. 8 - FOCUS QUEST. Issues in Contemporary Jewish History Journal of Fondazione CDEC Editors Michele Sarfatti (Fondazione CDEC, managing editor), Elissa Bemporad (Queens College of the City University of New York), Tullia Catalan (Università di Trieste), Cristiana Facchini (Università Alma Mater, Bologna; Max Weber Kolleg, Erfurt), Marcella Simoni (Università Ca’ Foscari, Venezia), Guri Schwarz (Università di Pisa), Ulrich Wyrwa (Zentrum für Antisemitismusforschung, Berlin). Editorial Assistant Laura Brazzo (Fondazione CDEC) Book Review Editor Dario Miccoli (Università Cà Foscari, Venezia) Editorial Advisory Board Ruth Ben Ghiat (New York University), Paolo Luca Bernardini (Università dell’Insubria), Dominique Bourel (Université de la Sorbonne, Paris), Michael Brenner (Ludwig-Maximilians Universität München), Enzo Campelli (Università La Sapienza di Roma), Francesco Cassata (Università di Genova), David Cesarani z.l. (Royal Holloway College, London), Roberto Della Rocca (DEC, Roma), Lois Dubin (Smith College, Northampton), Jacques Ehrenfreund (Université de Lausanne), Katherine E. Fleming (New York University), Anna Foa (Università La Sapienza di Roma), François Guesnet (University College London), Alessandro Guetta (INALCO, Paris), Stefano Jesurum (Corriere della Sera, Milano), András Kovács (Central European University, Budapest), Fabio Levi (Università degli Studi di Torino), Simon Levis Sullam (Università Ca’ -

Social Studies: the Life and Times of Giuseppe Verdi
Social Studies: The Life and Times of Giuseppe Verdi Students Will Read for information Complete timelines Choose an event to study in-depth Present their findings to the class Copies for Each Student “The Composer” Social Studies Activity Worksheet Copies for the Teacher “The Composer” Social Studies Activity Worksheet SAMPLE Social Studies Activity Worksheet Parts I & II Getting Ready Arrange for time in the library and/or prepare internet access for research, guided practice, or group work if needed. Gather pens, pencils, and additional writing paper as needed for your group. Introduction Depending on your grade level and the ability of your students, you may choose to conduct this lesson or portions of this lesson as a whole class, small group, or partner activity. Remind students to ask for clarification of any unknown words or concepts. Tell students that they will be reading about the composer of La Traviata, Giuseppe Verdi, and studying an abbreviated a timeline of his life. Guided/Independent Practice Part I Instruct your students to read, “The Composer.” Then, provide your students with the “Social Studies Activity Worksheet.” Read the directions and explain to students that by studying events that happened during the composer’s lifetime, one can gain a broader picture and more understanding of the times in which he lived. Allow students time to complete the worksheet. Student answers will vary based on the events they choose to complete the timeline. Part II Instruct students to choose one event within the timeline to study further. Have them present their findings about that event to the class. -

TONGIORGI «Senza Miserie Di Partiti»: Appunti Sul Mito Risorgimentale Del Salotto Maffei » 17
Acta et Studia 17 Direzione Simona Negruzzo (Università degli Studi di Bologna) Marco Sirtori (Università degli Studi di Bergamo) Comitato scientifico Vittoria Calabrò (Università degli Studi di Messina) Edwige Comoy Fusaro (Université Nice Sophia Antipolis, France) David Gentilcore (University of Leicester, UK) Stefano Magni (Aix-Marseille Université, France) Victor Mallia-Milanes (L-Università ta’ Malta - University of Malta) Philippe Nelidoff (Université Toulouse 1 Capitole, France) Gloria Pastorino (Fairleigh Dickinson University, New Jersey) Olivia Santovetti (University of Leeds, UK) L’OTTOCENTO DI CLARA MAFFEI A cura di Cristina Cappelletti Presentazione di Remo Morzenti Pellegrini Introduzione di Matilde Dillon Wanke Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere dell’Università degli Studi di Bergamo CD: Donne ‘compositrici’ dell’Ottocento 1. Maria Szymanowska (1789-1831), Notturno in Si bemolle 2-4. Francesca Nava D’Adda (1794-1877), Sonata in La minore 1. Grave – Allegro – Agitato 2. Andante quasi largo 3. Allegro fugato 5. Fanny Hensel Mendelssohn (1805-1847), Melodia op. 5 n. 1 6. Clara Wieck Schumann (1819-1896), Romanza op. 21 n. 3 7. Cécile Chaminade (1857-1944), Serenata op. 29 Pianoforte: Nadia Fanzaga Questo volume è stato sottoposto a double-blind peer review In copertina: FRANCESCO HAYEZ, Ritratto di Clara Maffei, Riva del Garda, Museo Civico (1845 circa). ISBN 978-88-205-1109-8 Copyright © 2017 MONDUZZI EDITORIALE S.r.l. CISALPINO. Istituto Editoriale Universitario VIA B. EUSTACHI, 12 – 20129 MILANO Tel. 02/20404031 [email protected] Finito di stampare nel mese di dicembre 2017 da Global Print, Gorgonzola (MI) Indice REMO MORZENTI PELLEGRINI Presentazione p. -

Parola Scenica: Towards Realism in Italian Opera Etdhendrik Johannes Paulus Du Plessis
Parola Scenica: Towards Realism in Italian Opera ETDHendrik Johannes Paulus du Plessis A thesis submitted to the Faculty of Arts, University of the Witwatersrand, Johannesburg, in fulfilment of the requirements for the degree of PhD by Thesis Abstract This thesis attempts to describe the emergence of a realistic writing style in nine- teenth-century Italian opera of which Giuseppe Verdi was the primary architect. Frequently reinforced by a realistic musico-linguistic device that Verdi would call parola scenica, the object of this realism is a musical syntax in which nei- ther the dramatic intent of the text nor the purely musical intent overwhelms the other. For Verdi the dramatically effective depiction of a ‘slice of a particular life’—a realist theatrical notion—is more important than the mere mimetic description of the words in musical terms—a romantic theatrical notion in line with opera seria. Besides studying the device of parola scenica in Verdi’s work, I also attempt to cast light on its impact on the output of his peers and successors. Likewise, this study investigates how the device, by definition texted, impacts on the orchestra as a means of realist narrative. My work is directed at explaining how these changes in mood of thought were instrumental in effecting the gradual replacement of the bel canto singing style typical of the opera seria of Rossini, Donizetti, and Bellini, by the school of thought of verismo, as exemplified by Verdi’s experiments. Besides the work of Verdi and the early nineteenth-cen- tury Italian operatic Romanticists, I touch also briefly on the œuvres of Puccini, ETDGiordano and the other veristi. -

F. Albano, Cinquant'anni Di Padri Della Patria 1848-1900
Università degli Studi di Cagliari DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA Ciclo XXVIII CINQUANT’ANNI DI PADRI DELLA PATRIA 1848-1900 Settore scientifico disciplinare di afferenza M-STO/04 Presentata da: Federica Albano Coordinatore Dottorato Chiar.mo Prof.re G. Murgia Tutor Chiar. mo Prof.re. U. Levra, Chiar.ma Prof.ssa L. Pisano Esame finale anno accademico 2014 – 2015 Indice Introduzione pag. IV Parte 1 I conflitti della gloria 1848-1861 1.1 Il 1849 di Mazzini, Garibaldi, Vittorio Emanuele pag. 16 1.2. Chi fa un primo errore è costretto a continuare. Alti e bassi tra il 1850 e il 1855 pag. 34 1.3. Il consenso a Cavour, la crisi dell’immagine di Mazzini, la conversione di Garibaldi. 1856-1858 pag. 44 1.4. Il 1859 pag. 62 1.5 Cavour nell’angolo, Garibaldi il vincitore sconfitto: il 1860 pag. 75 Parte 2 I padri della patria nel primo ventennio dopo l’Unità 1861- 1876 2.1 La storia sarà la storia dell’uomo grande che abbiamo perduto. La morte del Tessitore pag. 90 2.2 La costruzione di un re italiano. Il mito di Vittorio Emanuele negli ingressi trionfali e nelle celebrazioni pubbliche pag. 105 2.3. 1862. L’ultimo tentativo governativo di gestione della figura di Garibaldi: i fatti di Aspromonte pag. 122 2.4 Associazionismo repubblicano, funerali e feste civili. Il Mazzini pubblico e il Mazzini politico pag. 138 2.5 I conflitti della memoria. Il caso dei Comizi dei Veterani delle patrie battaglie di Torino e di Milano pag. 151 II 3 La triade paradossale o la paradossale triade? Il Risorgimento nazional-popolare dell’età crispina 3.1 Il monarca rivoluzionario pag. -

Verdi at 200: Recent Scholarship on the Composer and His Works Linda B
University of Richmond UR Scholarship Repository University Libraries Faculty and Staff ubP lications University Libraries 2013 Verdi at 200: Recent Scholarship on the Composer and His Works Linda B. Fairtile University of Richmond, [email protected] Follow this and additional works at: http://scholarship.richmond.edu/university-libraries- publications Part of the Musicology Commons Recommended Citation Fairtile, Linda. "Verdi at 200: Recent Scholarship on the Composer and His Works ." Notes 70,no. 1 (2013): 9-36. This Article is brought to you for free and open access by the University Libraries at UR Scholarship Repository. It has been accepted for inclusion in University Libraries Faculty and Staff ubP lications by an authorized administrator of UR Scholarship Repository. For more information, please contact [email protected]. VERDI AT 200: RECENT SCHOLARSHIP ON THE COMPOSER AND HIS WORKS By Linda B. Fairtile छ In December 2012 the Italian media were ablaze with outrage as the Teatro alla Scala inaugurated its new season with a performance of Lohengrin. Opening La Scala with a Wagner opera is nothing new: in 1898 Arturo Toscanini chose Die Meistersinger to begin his tenure as music direc- tor there. In the recent case, however, the timing struck many as a deliber- ate slight. Although both Verdi and Wagner were born in 1813, on the eve of their shared bicentennial Italy’s most prestigious opera house selected the German for the honor of an opening night. Certainly, politics played a part in the Italian press’s reaction. With the struggling economy forced to look northward for support, any whiff of German advantage was bound to rankle. -

Clavijo Bianchi Desafiando Al Olvido
Índice Prólogo: Escritoras inéditas: las razones de la sinrazón MERCEDES ARRIAGA FLÓREZ 11 I. DE LA ANTIGÜEDAD AL SIGLO XIX La penna pungente di Matilde Serao: Il ventre di Napoli GIULIA FASANO . 31 Orsola Cortesi Biancolelli, mediadora teatral entre España e Italia IRINA FREIXEIRO AYO 47 Un pre-testo per testare la presenza femminile tra scena e libretti a stampa: l’edizione genovese di Artemisia , dramma musicale del Seicento MONICA GALLETTI 61 La ficcionalización de personajes históricos en la literatura italiana: el caso de Veronica Franco PABLO GARCÍA VALDÉS 75 La correspondencia femenina en el Resurgimiento italiano: temáticas y objetivos comunes ESTELA GONZÁLEZ DE SANDE 89 Las mujeres en la Italia del siglo XVIII: el largo camino hacia la conquista de sus derechos MERCEDES GONZÁLEZ DE SANDE 101 Verso un catalogo definitivo della produzione di Dorigista (Isabella Dosi Grati): edizioni e manoscritti JAVIER GUTIÉRREZ CAROU 115 La passione fuori catalogo della finzione di Matilde Serao MARIA LAURA IASCI 127 7 Rosa Califronia and her Breve Difesa dei diritti delle donne (1794): A phantom writer and the discourse on women in 17th and 18th centuries MARIA -K ONSTANTINA LEONTSINI 137 La seconda Sulpicia: sensuale e pudica RAFFAELA LO BRUTTO 151 II. ESCRITORAS CONTEMPORÁNEAS II.1. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX Carolina Rispoli, una voce meridionale dimenticata ANGELO AZZILONNA 169 Leyendo cartas con gafas de género ANTONELLA CAGNOLATI 181 Otras locuras femeninas: la de Gemma Ferruggia TERESA GIL GARCÍA 197 Las solarianas MARÍA BELÉN HERNÁNDEZ -

The Songs of Luigi Gordigiani (1806-1860), "Lo Schuberto Italiano" Thomas M
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2007 The Songs of Luigi Gordigiani (1806-1860), "Lo Schuberto Italiano" Thomas M. Cimarusti Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MUSIC THE SONGS OF LUIGI GORDIGIANI (1806-1860), “LO SCHUBERTO ITALIANO” By THOMAS M. CIMARUSTI A Dissertation submitted to the College of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Degree Awarded: Summer Semester, 2007 Copyright © 2007 Thomas M. Cimarusti All Rights Reserved The members of the Committee approve the dissertation of Thomas M. Cimarusti defended on 28 June 2007. Douglass Seaton Professor Directing Dissertation Valerie Trujillo Outside Committee Member Charles E. Brewer Committee Member Jeffery Kite -Powell Committee Member William Leparulo Committee Member Approved: Seth Beckman, Chair, College of Music Don Gibson, Dean, College of Music The Office of Graduate Studies has verified and approved the above named committee members. ii To my parents iii ACKNOWLEDGMENTS The completion of this dissertation involved the help of many individuals. I am most grateful to my advisor Dr. Douglass Seaton, whose encouragement, patience, and inspiration have been invaluable. I am profoundly indebted to him. My deepest thanks to my committee members Drs. Charles Brewer, Jeffery Kite-Powell, and William Leparulo for their comments and suggestions regarding initial drafts. My sincere appreciation to Dr. Valerie Trujillo who, due to unforseen circumstances, stepped in to serve on the committee just prior to my defense. I am also thankful for Italian scholar Dr. -

Verdi a Milano Le Musiche Della Patria
VERDI A MILANO LE MUSICHE DELLA PATRIA Aggiornamento a cura della Città metropolitana di Milano Luglio 2017 Aggiornamento a cura della Città metropolitana di Milano Luglio 2017 VERDI A MILANO LE MUSICHE DELLA PATRIA A cura di Marco Valle Dicembre 2013 Promosso e realizzato dalla Provincia di Milano - Dicembre 2013 Progetto multimediale curato da: in collaborazione con il Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi Settore comunicazione, Servizio Scopro e Medialogo Gruppo di lavoro: Mario Zerbini, Lara Lagonegro, A cura di: Marco Valle Renato Minotti, Ornella Bongiorni Si ringrazia: Casa di Riposo per Musicisti Fondazione Verdi, Crediti fotografici: Archivio Getty Images - Ufficio grafico, Fondazione Cineteca Italiana, Bibilioteca del Conservatorio Archivio Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Mara Bianchi, Giuseppe Verdi, Biblioteca Isimbardi Ornella Bongiorni, Vito Chamia, Diego Rinaldi (Casa di Riposo per Musicisti, Fondazione Giuseppe Verdi), Mario Zerbini Progetto grafico: Barbara Forti Copertina, elaborazioni grafiche e illustrazioni: Luca Squizzato Ufficio grafico, Settore comunicazione La Provincia di Milano si rende disponibile al riconoscimento di eventuali diritti. INDICE LA MILANO DEL GIOVANE VERDI 11 Milano, il laboratorio della modernità 14 La Scala: un mito 19 Verdi dopo la bocciatura 15 Verdi e il suo misterioso taccuino 16 Vocabolario del melodramma 20 La Scala nel primo ottocento 22 Antonio Barezzi il mecenate 23 RITORNO A MILANO 27 Speranze e dolori 33 Dalla disperazione al successo 37 La patria della grande musica 31 Bartolomeo Merelli 35 La Galleria De Cristoforis 38 VA’, PENSIERO, IL CANTO DI UN POPOLO 43 Gli “anni di galera” 51 L’incendio del 1848 54 Giuseppina, il grande amore 47 Verdi e le cinque giornate del 1848: “le stupende barricate” 52 Da Mazzini a Cavour 56 IL MITO 59 Il ritorno a Milano.