Quaderni Di Archivio Bergamasco
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

ATLANTE DEGLI UCCELLI DI BERGAMO a Cura Di Enrico Cairo E Roberto Facoetti
ATLANTE DEGLI UCCELLI DI BERGAMO a cura di Enrico Cairo e Roberto Facoetti Specie nidificanti e specie svernanti (2001-2004) disegni di Simone Ciocca Mario Guerra Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi” Volume 23 (2004) Bergamo 2006 edizioni junior © 2006 Comune di Bergamo Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi” di Bergamo Volume 23 (2004) Registrazione presso il Tribunale di Bergamo al n. 19 (16 settembre 1999) Direttore Responsabile Dott. Marco Valle ISSN 0393-8700 © 2006 Sull’edizione: Edizioni Junior srl Viale dell’Industria, 24052 Azzano S. Paolo (BG) Tel. 035/534123 - Fax 035/534143 e-mail: [email protected] www.edizionijunior.it ISBN 88-8434-292-9 Tutti i diritti riservati Prima edizione: dicembre 2006 Edizioni: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2010 2009 2008 2007 2006 Questo volume è stato stampato presso Tecnoprint, Romano di Lombardia (BG) Stampato in Italia - Printed in Italy Sommario PRESENTAZIONE .................................................................................................... 5 INTRODUZIONE ...................................................................................................... 7 L’ATLANTE ORNITOLOGICO ................................................................................ 9 Valore e significato...................................................................................................... 9 L’ecosistema urbano .................................................................................................... 10 Metodologia e criteri di -
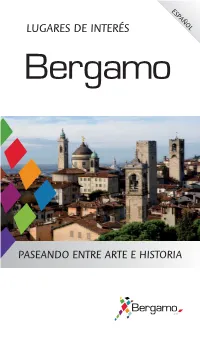
Lugares De Interés
ESP AÑOL LUGARES DE INTERÉS PASEANDO ENTRE ARTE E HISTORIA ENTRE LAS DOS CIUDADES E CASTA N I VIA G O T N VIA T AN E E PI Monastero di Valmarina T VALVERDE IN A AL P A . VI A I A IN VI VIA P M A R V RA CONCA FIORITA T I A. A A I G E BARNAB A N I M I A A V R VIA T P I A TU G A I I OR R A. V . I C F OLI V Parco dei Colli di Bergamo ON IA IA BAION RE SS A V A VIA FA Parco del Castello SCE I NC D I NZ O n viaje entre las dos ciudades, una en la colina I di S. Vigilio T C A T I Z I A E Z V P L IA N E I CO I O PIAZZALE STA D P EL H Lazzaretto NT I N . D O IN E G O A T OLIMPIADI L TE IA B T Castello di EL E Campo IA V . y la otra en la llanura, diferentes pero unidas, T S V A O R A I San Vigilio AMI RO C LINO Utili AN IA O V AB V D LE C TOV I N Z A A AL C AN F SS IA RO G. M E V AR L LE V A IA O LARGO I VI V I C A A T ’ M E T T IA Stadio DELLO N A VIA N. no solo por la historia sino también por un C A E SAN VIGILIO A H A . -

Paleoecological Archives Unraveling the Early Land-Use History at the Emergence of the Bronze Age Settlement of Bergamo (Italian Alps)
Review of Palaeobotany and Palynology 276 (2020) 104205 Contents lists available at ScienceDirect Review of Palaeobotany and Palynology journal homepage: www.elsevier.com/locate/revpalbo Paleoecological archives unraveling the early land-use history at the emergence of the Bronze Age settlement of Bergamo (Italian Alps) Cesare Ravazzi a,⁎, Roberta Pini a, Mattia De Amicis b, Lorenzo Castellano c, Roberto Comolli b, Davide Abu El Khair b, Giulia Furlanetto b, Diego Marsetti d,RenataPeregoa a Research Group on Vegetation, Climate and Human Stratigraphy, Lab. of Palynology and Palaeoecology, CNR-IGAG, Piazza della Scienza 1, 20126 Milano,Italy b Dept. of Environmental and Earth Sciences, University of Milano-Bicocca, Piazza della Scienza 1, 20126 Milano, Italy c New York University, Institute for the Study of the Ancient World, East 84th Street, New York, USA d ECOGEO srl, via Fratelli Calvi 2, 24122 Bergamo, Italy article info abstract Article history: The hilltop town of Bergamo, at the southern fringe of the Italian Alps, represents a typical example of the stepped Received 12 February 2020 emergence of a prehistoric settlement developing into a proto-historic urban center in the Iron Age. We present Accepted 28 February 2020 here unprecedented multidisciplinary evidence based on several near-site stratigraphies, supported by a robust Available online 02 March 2020 radiocarbon chronology and by a continuous fine-resolution sedimentary and paleoecological record from a pond used for livestock watering, which was intercepted by drilling underneath the modern Catholic Cathedral. The Keywords: obtained chronostratigraphy documents the development of arable and fallow land including cereals, legumes Vegetation history Cultural landscape and livestock husbandry starting as early as 3355 yrs. -

The History of Napoleon Buonaparte
THE HISTORY OF NAPOLEON BUONAPARTE JOHN GIBSON LOCKHART CHAPTER I BIRTH AND PARENTAGE OF NAPOLEON BUONAPARTE—HIS EDUCATION AT BRIENNE AND AT PARIS—HIS CHARACTER AT THIS PERIOD—HIS POLITICAL PREDILECTIONS—HE ENTERS THE ARMY AS SECOND LIEUTENANT OF ARTILLERY—HIS FIRST MILITARY SERVICE IN CORSICA IN 1793. Napoleon Buonaparte was born at Ajaccio on the 15th of August, 1769. The family had been of some distinction, during the middle ages, in Italy; whence his branch of it removed to Corsica, in the troubled times of the Guelphs and Gibellines. They were always considered as belonging to the gentry of the island. Charles, the father of Napoleon, an advocate of considerable reputation, married his mother, Letitia Ramolini, a young woman eminent for beauty and for strength of mind, during the civil war— when the Corsicans, under Paoli, were struggling to avoid the domination of the French. The advocate had espoused the popular side in that contest, and his lovely and high-spirited wife used to attend him through the toils and dangers of his mountain campaigns. Upon the termination of the war, he would have exiled himself along with Paoli; but his relations dissuaded him from this step, and he was afterwards reconciled to the conquering party, and protected and patronised by the French governor of Corsica, the Count de Marbœuff. It is said that Letitia had attended mass on the morning of the 15th of August; and, being seized suddenly on her return, gave birth to the future hero of his age, on a temporary couch covered with tapestry, representing the heroes of the Iliad. -

Proposta Di Rapporto Ambientale
Via Valmarina, 25 24123 Bergamo tel. 035/4530401 P.E.C. : [email protected] PROPOSTA DI RAPPORTO AMBIENTALE Progettisti: Raffaella Gambino Federico Valfrè di Bonzo NQA Nuova Qualità Ambientale Srl Federica Thomasset Stefano Assone Gruppo di Lavoro Valutazione Ambientale Strategica: Elisa Carturan – Dottore Forestale Daniele Piazza – Dottore Agronomo Valentina Carrara – Pianificatore territoriale Niccolò Mapelli – Dottore Agronomo jr. Maggio 2018 Soggetto Proponente VAS : Parco Regionale dei Colli di Bergamo Autorità Competente VAS: Ing. Francesca Caironi – Servizio Urbanistico Autorità Procedente VAS: Rag. Manuela Corti – Direttore del Parco dei Colli di Bergamo in collaborazione con: P.a. Pasqualino Bergamelli, responsabile area tutela dell’ambiente e del verde Arch. Pierluigi Rottini, responsabile del servizio urbanistico Per le versioni successive alla prima: Versione Data Modifiche 2 INDICE 1. PREMESSA ..................................................................................................................... 5 2. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ............................................................. 6 2.1 Il contesto normativo ............................................................................................................................................... 7 3. L’ITER METODOLOGICO E PROCEDURALE ................................................................... 9 3.1 Le fasi del processo di VAS della Variante generale al PTC del Parco dei Colli e al PTC del Parco Naturale dei Colli -

GENIO CIVILE XX Secolo Inventario Sommario (1874-2002)
ARCHIVIO DI STATO DI BERGAMO GENIO CIVILE XX secolo inventario sommario (1874-2002) Il servizio del Genio Civile trova le sue origini agli inizi del XIX secolo, durante il periodo della dominazione franco-napoleonica e si caratterizza come risposta tecnica a esigenze territoriali di progettazione e gestione delle opere pubbliche: acque, strade, ponti, edifici e proprietà erariali in genere. Con il passare del tempo, subisce trasformazioni delle competenze e variazioni nell’ordinamento, pur restando fedele alla missione originaria. Successivamente all’Unità d’Italia, il servizio del Genio Civile è posto alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici; di norma ha sede in ogni capoluogo di provincia, con competenze sul territorio provinciale. Il regio decreto 2 marzo 1931 n. 287 stabilisce, tra le altre cose, che in ogni sede provinciale ordinaria siano presenti otto sezioni : servizio generale, derivazioni d'acqua e linee elettriche, opere idrauliche, bonifiche, opere stradali, opere marittime, opere edilizie, opere e servizi speciali dipendenti da pubbliche calamità. Nel 1945, per la realizzazione dei programmi eccezionali di opere pubbliche dovuti alle necessità della ricostruzione post bellica, vengono istituiti i Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche; a essi viene demandata la gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori e dei servizi di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Tale decentramento viene sancito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1534 del 30 giugno 1955. Occorre ricordare l'attività del Genio Civile quale corpo tecnico dello stato, con mansioni di consulenza e controllo: gli uffici provvedono alla revisione dei progetti di opere riguardanti gli enti locali, collaudi di lavori eseguiti con mutui e sussidi dello stato, istruttorie tecniche per concessioni di derivazioni di acque pubbliche, sorveglianza di polizia fluviale, espropriazioni di pubblica utilità e consulenza alle prefetture. -

CHAPTER ONE: a HISTORICAL BACKGROUND the Venetian State
On the Knowledge of Persia in the Republic of Venice 7 CHAPTER ONE: A HISTORICAL BACKGROUND The Venetian state developed first as an overseas colonial empire and only later became a continental power, maintaining a strong vocation for international trade virtually until the last days of the Serenissima. Trade and shipping were openly acknowledged as the pillars of Venice’s might and wealth, and trade included Persia as well as lands which were connected to Persia, to a various degree and extent, by a number of historical, political, economic, cultural and linguistic ties. The Venetian merchants residing in Persia at any given time must have been always less numerous than those living in Byzantine Constantinople, the Ottoman Empire, or the Black Sea basin and the Crimea at the heyday of Venetian power, but their presence was not a negligible one. Thus, it is not surprising that a steady flow of information on Persia arrived to Venice, and that much of this information was produced or at least conveyed by traders. At an iconographic level, the inhabitants of Persia and of the lands surrounding it were (and still are) represented in the very political, ceremonial and symbolic heart of Venice, the Palazzo Ducale (which was the seat of the nominal head of the State, the Doge, as well as that of many government bodies, including those which were the expression of the paramount role of Venetian nobility and through which the nobility actually ruled the Republic, namely, the Maggior Consi- glio and the Senato) and the adjacent Basilica di S. Marco (which was the private chapel of the Doge). -

Reticolo Idrico
RETICOLO IDRICO CRITERI DI INDIVIDUAZIONE D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 In collaborazione con Giugno 2016 Revisione n. 1 - Dicembre 2016 Comune di Bergamo CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE, CONSORTILE E MINORE GRUPPO DI LAVORO rif. Accordo di Collaborazione n. I 41198 P.G., n. 138 Reg. Settore del 13/06/2003 ing. Diego Finazzi Comune di Bergamo arch. Nicola Cimmino Comune di Bergamo dr. Giovanni Giupponi Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca sig. Riccardo Marengoni Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca ing. Giovanni Filippini EST s.r.l. (incaricata da C.B.M.P.B.) ing. Francesca Bertuletti EST s.r.l. (incaricata da C.B.M.P.B.) ing. Giovanni Sonzogni EST s.r.l. (incaricata da C.B.M.P.B.) ing. Alberto Fara EST s.r.l. (incaricata da C.B.M.P.B.) xcod.216102di314_3002 erbmeciD 6102 Comune di Bergamo CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE, CONSORTILE E MINORE INDICE 0. PREMESSE ............................................................................................................ 1 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO E DEFINIZIONI ................................................. 2 2. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ........................ 4 3. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE .......................................................................... 9 4. RETICOLO IDRICO MINORE ............................................................................... 10 5. RETICOLO DI COMPETENZA CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA .................................................................................................... -

Sommario Parte Prima
SOMMARIO PARTE PRIMA 1 – PREMESSA pagina 3 1 - 1 – LINEE GENERALI pagina 3 1 - 2 – MOTIVAZIONI pagina 4 1 - 3 – BENEFICIARI pagina 5 1 - 4 – VANTAGGI ECONOMICI pagina 5 1 - 5 – RIFERIMENTI NORMATIVI pagina 5 1 - 6 – OBBLIGO DI PROGETTO E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ pagina 6 PARTE SECONDA 2 - RILIEVO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI pagina 6 2 - 1 - QUADRI ELETTRICI pagina 7 2 - 2 - TIPOLOGIE CORPI ILLUMINANTI pagina 10 2 - 3 - LAMPADE pagina 10 2 - 4 - CONSISTENZA ATTUALE IMPIANTO pagina 11 2 - 5 – CONSISTENZA IMPIANTO DA ADEGUARE pagina 29 2 - 6 – SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA pagina 43 2 - 7 – CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI FATTO pagina 43 PARTE TERZA 3 - STESURA DEL PIANO pagina 43 3 - 1 – INDIVIDUAZIONE AREE OMOGENEE pagina 44 3 - 2 – STRADE A TRAFFICO MOTORIZZATO pagina 44 3 - 3 – CLASSIFICAZIONE DELLE VIE DEL COMUNE DI SORISOLE IN FUNZIONE DEL TIPO DEL TRAFFICO SECONDO LA UNI 10.439 - 2001 pagina 47 3 - 4- INTERVENTO DI ADEGUAMENTO pagina 50 3 – 5 SCELTA DELLE LAMPADE pagina 50 3 – 6 VANTAGGI ECONOMICI pagina 52 1 PARTE QUARTA 4 – SCELTE TECNICHE E PROGETTUALI pagina 52 4.1 – CRITERI GENERALI ED AGGIUNTIVI pagina 52 4.2 – GRADI DI PROTEZIONE E CLASSI D’ISOLAMENTO pagina 54 4.3 – GEOMETRIA E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI pagina 54 4.3.1 – LAMPADE pagina 54 4.3.2 – SOSTEGNI pagina 55 4.4 – CORPI ILLUMINANTI 4.4.1 - SCELTA DEL CORPO ILLUMINANTE pagina 57 4.5 - Scelte per la protezione degli impianti pagina 57 4.6 - Posa delle linee elettriche 4.6.1 - LINEE IN CAVO pagina 58 4.6.2 – Derivazioni pagina 59 4.6.3 – QUADRI ELETTRICI E REGOLATORI DI FLUSSO pagina 59 PARTE QUINTA 5 - STIMA DI MASSIMA DEI COSTI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DELLA L.R. -

Lo Specchio Della Città
Lo specchio della Città Il ritratto tra ʼ800 e ʼ 900 attraverso le collezioni nascoste dell’Accademia Carrara Lo specchio della Città Il ritratto tra ʼ800 e ʼ 900 attraverso le collezioni nascoste dell’Accademia Carrara Bergamo, 4 – 31 ottobre 2019 Palazzo Storico Credito Bergamasco Curatori Angelo Piazzoli Paolo Plebani Registrar Paola Silvia Ubiali Organizzazione Sara Carboni Cristina Romeo Lo specchio della Città Il ritratto tra ʼ800 e ʼ900 attraverso le collezioni nascoste dell’Accademia Carrara Progetto grafico Drive Promotion Design Art Director Giancarlo Valtolina Si ringraziano Indicazioni cromatiche VERDE BLU ROSSO C100 M40 Y100 C100 M80Y20 K40 C40M100 Y100 PANTONE 349 PANTONE 281 PANTONE 187 R39 G105 B59 R32 G45 B80 R123 G45 B41 L’Accademia della meraviglia Angelo Piazzoli* Una storica prossimità Da sempre Fondazione Creberg è attenta e sensibile alla creazione e alla cura dei luoghi della memoria, i musei. Lo è geneticamente; venne infatti istituita dal Credito Bergamasco in occasione di un intervento di restauro, che ha generato la sede della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, poi donata alla città per celebrare il centenario della Banca fondatrice. In seguito, la Fondazione ha ampliato le sue attività ai campi dell’arte e della cultura, della salvaguardia del patrimonio storico/artistico, della ricerca medica e scientifica, della solidarietà, con gli attuali quattrocento interventi annui in tali ambiti. In tale logica, essa si è naturalmente innestata nello storico rapporto di prossimità all’Accademia Carra- ra da parte del Credito Bergamasco (ora Banco BPM), caratterizzato nel tempo da importanti interventi nella Pinacoteca, della quale la GAMeC stessa è parte; si pensi, ad esempio, ai numerosi restauri di Sale espositive e di opere realizzati a partire dagli anni Cinquanta del Novecento ovvero alla catalogazione e digitalizzazione di circa 1.800 dipinti della raccolta, tutti fotografati e, per larga parte, disponibili alla con- sultazione online. -

SG0 Allegato 4
P G T COMUNE DI BERGAMO R G A E M AREA POLITICHE DEL TERRITORIO B O P iano di DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA Governo del UFFICIO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO C E I L T L erritorio T I M T A ' D E I COORDINAMENTO UFFICIO PGT ARCH. GIORGIO CAVAGNIS TEAM DI PROGETTAZIONE ARCH. GIORGIO CAVAGNIS ARCH. GIANLUCA DELLA MEA ARCH. MARINA ZAMBIANCHI RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. ARCH. BRUNO GABRIELLI CONSULENZA ARCHITETTONICA PROF. ARCH. AURELIO GALFETTI UFFICIO PGT ARCH. SILVIA PERGAMI ARCH. ALESSANDRO SANTORO DOTT. SERGIO APPIANI DOTT. ANDREA CALDIROLI DOTT. RAFFAELE PICARIELLO DOTT. LARA ZANGA con DOTT. SILVIA CIVIDINI CONSULENZA ASPETTI AMBIENTALI E PAESISTICI E VAS ARCH. MARGHERITA FIORINA CONSULENZA ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI DOTT. GEOL. RENATO CALDARELLI DOTT. GEOL. MASSIMO ELITROPI CONSULENZA ASPETTI LEGALI AVV. FORTUNATO PAGANO AVV. PAOLO BONOMI SIT (SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE) Modificato e approvato con atto di rettifica non comportante variante (art 13 c.14bis della L.R. 12/05 e s.m.i.): - ARPGT00 (Del. C.C. n. 6 Reg./60-2010 Prop. Del. in data 24/01/2011) - ARPGT01 (Del. C.C. n. 146 Reg./46-2011 Prop. Del. in data 19/07/2011) AGGIORNATO AL 21.09.2011 - ARPGT02 (Del. C.C. n. 99 Reg./25-2011 Prop. Del. in data 30/05/2011) Pubblicato su Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 38 in data 21/09/2011. STUDIDISETTORE STUDIO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO (ai sensi della D.G.R. 8/7374 del 28 maggio 2008) INTEGRAZIONI E SG0 APPROFONDIMENTI allegato 4 Elaborazioni cartografiche: Ufficio PGT studio associato Via Giorgio e Guido Paglia, n° 21 – 24122 BERGAMO – e-mail: [email protected] Tel. -

Quartiere ENTI/ASSOCIAZIONI Boccaleone Parrocchia SS. Pietro E
Quartiere ENTI/ASSOCIAZIONI Boccaleone Parrocchia SS. Pietro e Paolo Boccaleone AD Oratorio Boccaleone Basket Boccaleone ASD Calcio Oratorio Boccaleone Boccaleone Centro Giovanile Boccaleone Pallavolo Boccaleone ASD ARCI-UISP di Boccaleone/Campagnola/Carnovali/Malpensata Boccaleone Retroedicola videoludica Boccaleone Coop. soc. Alchimia Borgo Palazzo Airone ASD e di promozione sociale Borgo Palazzo ASD Ananda Borgo Palazzo Parrocchia Sant'Anna Borgo Palazzo Parrocchia Sant'Anna (scuola dell'infanzia) Campagnola AD Oratorio Boccaleone Basket Campagnola ASD Virescit Campagnola Parrocchia S.Giovanni Battista Campagnola Coop. soc. Alchimia Celadina ASD ARCI-UISP di Boccaleone/Campagnola/Carnovali/Malpensata Celadina Climberg ASD Celadina Consorzio sociale R.I.B.E.S. s.c. Celadina CSI comitato territoriale di Bergamo Celadina L'Impronta società cooperativa sociale Celadina Parrocchia San Pio X Centro ASD Ananda Centro Associazione per la GAMEC di Bergamo - ONLUS Centro CSC Anymore Centro Associazione Fabbrica dei sogni - ONLUS Centro Fondazione Accademia Carrara Centro Fondazione Luigi Clerici Centro Fondazione Opera S. Alessandro Centro Il Teatro Prova società cooperativa sociale Centro Parrocchia S.Alessandro in Colonna Provincia di Bergamo della Congregazione delle Suore Centro Sacramentine di Bergamo Centro UISP Comitato territoriale di Bergamo APS Centro Il Pugno Aperto s.c. Città Alta e Colli Airone ASD e di promozione sociale Città Alta e Colli APS Maite Città Alta e Colli Associazione Il Ramo Maestro Città Alta e Colli Parrocchia S.Alessandro in Cattedrale Città Alta e Colli Ass. Rosa Agrestis Colognola ASD Ananda Colognola Parrocchia S.Sisto Papa e Martire Conca Fiorita ASD Spooky Sport Conca Fiorita ASD Ananda Conca Fiorita Cooperativa d'impresa sociale RUAH s.c.s.