SG0 Allegato 4
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

⇒ Patto Con La Persona ⇒ Patto Con L'ambiente ⇒ Patto Con Le Istituzioni
COMUNE DI SORISOLE ⇒ Patto con la persona ⇒ Patto con l’ambiente ⇒ Patto con le istituzioni Programma elettorale 2008 - 2013 Candidato Sindaco: Stefano Gamba Il programma elettorale di Progetto Comune si compone di tre PATTI che stabiliscono la via che vogliamo intraprendere per raggiungere il risultato di migliorare la qualità della vita sociale di ogni abitante di Sorisole. I tre Patti sono: Patto con la persona , Patto con il territorio , Patto con le istituzioni . IL PATTO CON LA PERSONA In questi anni di lavoro sul territorio abbiamo guardato questo paese negli occhi. Abbiamo ascoltato le persone, i gruppi e le associazioni, con loro abbiamo pensato a una Sorisole nuova . Con loro lavoreremo per realizzarla. Ciò che ci sta a cuore è accompagnare la crescita e lo sviluppo della persona all’interno della comunità, non considerandola per categorie o “età”, ma prestandole attenzione nella sua interezza di singolo e nelle sue relazioni con gli altri . Il Comune è una realtà che deve stare vicina ai cittadini , perché è fatta da loro e per loro. Per questo pensiamo che ascolto, accoglienza e comunicazione siano la prima cosa da fare perché i cittadini di Sorisole si sentano come a casa loro quando entrano nel palazzo comunale. Solo ascoltando si possono cogliere i bisogni delle persone e si può lavorare per potenziare i servizi e le strutture esistenti (o crearne di nuove…) per rispondere in maniera più efficace ed efficiente ai bisogni delle persone. FAMIGLIA Sosteniamo le famiglie nel loro lavoro di cura per i piccoli, gli anziani e -

PARCO DEI COLLI DI BERGAMO Ente Di Diritto Pubblico
PARCO DEI COLLI DI BERGAMO Ente di Diritto Pubblico Relazione illustrativa del Consiglio di Gestione sulla gestione da allegare al rendiconto per l’anno 2012 ai sensi del comma 6 dell’art.151 del D.Lgs.267/2000 Come è noto il comma 6, dell’art.151 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, prevede che al rendiconto sia allegata una relazione illustrativa del Consiglio di Gestione, che deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art.231 del medesimo D.Lgs.267/2000, essendo una manifestazione di volontà di un Organo Collegiale. La presente per illustrare lo stato di attuazione del programma del Consiglio di Gestione nel corso del 2012, nonché dei risultati della gestione con riferimento agli obiettivi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. Il grado di realizzazione del programma del Consiglio di Gestione, come individuato dagli strumenti di programmazione, dalla relazione previsionale e programmatica approvata con delibera n. 5 del 8.6.2012 e dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), è stato approvato dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 39 del 9.7.2012 Per quanto concerne i diversi Settori di attività dell’Ente si riassume di seguito il risultato di gestione per ciascuno dei programmi rispetto alle previsioni del P.E.G. ed in rapporto ai programmi e progetti formulati in sede previsionale e programmatica e degli altri strumenti programmatori. Vengono altresì illustrate le valutazioni sui risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia dei servizi, nonché delle motivazioni di eventuali scostamenti tra gli obiettivi programmatici e i risultati. Premessa In data 4 agosto 2011 è stata approvata la legge regionale n. -

ATLANTE DEGLI UCCELLI DI BERGAMO a Cura Di Enrico Cairo E Roberto Facoetti
ATLANTE DEGLI UCCELLI DI BERGAMO a cura di Enrico Cairo e Roberto Facoetti Specie nidificanti e specie svernanti (2001-2004) disegni di Simone Ciocca Mario Guerra Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi” Volume 23 (2004) Bergamo 2006 edizioni junior © 2006 Comune di Bergamo Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi” di Bergamo Volume 23 (2004) Registrazione presso il Tribunale di Bergamo al n. 19 (16 settembre 1999) Direttore Responsabile Dott. Marco Valle ISSN 0393-8700 © 2006 Sull’edizione: Edizioni Junior srl Viale dell’Industria, 24052 Azzano S. Paolo (BG) Tel. 035/534123 - Fax 035/534143 e-mail: [email protected] www.edizionijunior.it ISBN 88-8434-292-9 Tutti i diritti riservati Prima edizione: dicembre 2006 Edizioni: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2010 2009 2008 2007 2006 Questo volume è stato stampato presso Tecnoprint, Romano di Lombardia (BG) Stampato in Italia - Printed in Italy Sommario PRESENTAZIONE .................................................................................................... 5 INTRODUZIONE ...................................................................................................... 7 L’ATLANTE ORNITOLOGICO ................................................................................ 9 Valore e significato...................................................................................................... 9 L’ecosistema urbano .................................................................................................... 10 Metodologia e criteri di -
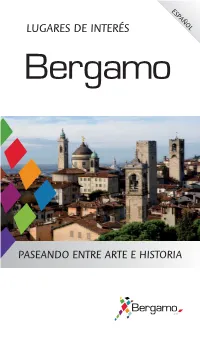
Lugares De Interés
ESP AÑOL LUGARES DE INTERÉS PASEANDO ENTRE ARTE E HISTORIA ENTRE LAS DOS CIUDADES E CASTA N I VIA G O T N VIA T AN E E PI Monastero di Valmarina T VALVERDE IN A AL P A . VI A I A IN VI VIA P M A R V RA CONCA FIORITA T I A. A A I G E BARNAB A N I M I A A V R VIA T P I A TU G A I I OR R A. V . I C F OLI V Parco dei Colli di Bergamo ON IA IA BAION RE SS A V A VIA FA Parco del Castello SCE I NC D I NZ O n viaje entre las dos ciudades, una en la colina I di S. Vigilio T C A T I Z I A E Z V P L IA N E I CO I O PIAZZALE STA D P EL H Lazzaretto NT I N . D O IN E G O A T OLIMPIADI L TE IA B T Castello di EL E Campo IA V . y la otra en la llanura, diferentes pero unidas, T S V A O R A I San Vigilio AMI RO C LINO Utili AN IA O V AB V D LE C TOV I N Z A A AL C AN F SS IA RO G. M E V AR L LE V A IA O LARGO I VI V I C A A T ’ M E T T IA Stadio DELLO N A VIA N. no solo por la historia sino también por un C A E SAN VIGILIO A H A . -

Relazione “Studio Paesistico”
INDICE 1 PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO ............................................................... 4 1.1 Struttura dello studio paesistico ..................................................................................... 5 1.2 Dati di base e metodologia di lavoro............................................................................... 6 2 INTRODUZIONE ................................................................................................................... 6 2.1 Il concetto di paesaggio ................................................................................................... 6 2.1.1 Le componenti del paesaggio ........................................................................................ 7 2.1.2 La tutela del paesaggio .................................................................................................. 8 3 IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.................................................... 11 3.1 Premessa ......................................................................................................................... 11 3.2 La pianificazione regionale ............................................................................................ 11 3.3 La pianificazione provinciale ......................................................................................... 13 3.3.1 Caratteri generali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)....... 13 3.3.2 La pianificazione ambientale e paesistica del P.T.C.P................................................ -

Sp0 Relazione
P G T COMUNE DI BERGAMO R G A E M AREA POLITICHE DEL TERRITORIO B O P iano di DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA UFFICIO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO Governo del C E I L T L T I erritorio M T A ' D E I COORDINAMENTO UFFICIO PGT ARCH. GIORGIO CAVAGNIS TEAM DI PROGETTAZIONE ARCH. GIORGIO CAVAGNIS ARCH. GIANLUCA DELLA MEA ARCH. MARINA ZAMBIANCHI RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. ARCH. BRUNO GABRIELLI CONSULENZA ARCHITETTONICA PROF. ARCH. AURELIO GALFETTI UFFICIO PGT ARCH. SILVIA PERGAMI ARCH. ALESSANDRO SANTORO DOTT. SERGIO APPIANI DOTT. ANDREA CALDIROLI DOTT. RAFFAELE PICARIELLO DOTT. LARA ZANGA con DOTT. SILVIA CIVIDINI CONSULENZA ASPETTI AMBIENTALI E PAESISTICI E VAS ARCH. MARGHERITA FIORINA CONSULENZA ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI DOTT. GEOL. RENATO CALDARELLI DOTT. GEOL. MASSIMO ELITROPI CONSULENZA ASPETTI LEGALI AVV. FORTUNATO PAGANO AVV. PAOLO BONOMI SIT (SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE) Modificato e approvato con atto di rettifica non comportante variante (art 13 c.14bis della L.R. 12/05 e s.m.i.): - ARPGT00 (Del. C.C. n. 6 Reg./60-2010 Prop. Del. in data 24/01/2011) - ARPGT01 (Del. C.C. n. 146 Reg./46-2011 Prop. Del. in data 19/07/2011) - ARPGT02 (Del. C.C. n. 99 Reg./25-2011 Prop. Del. in data 30/05/2011) AGGIORNATO AL 21.09.2011 Pubblicato su Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 38 in data 21/09/2011. S T U D I D I S E T T O R E S T U D I O P A E S I S T I C O D I D E T T A G L I O ( a i s e n s i d e l l ' a r t . -

Paleoecological Archives Unraveling the Early Land-Use History at the Emergence of the Bronze Age Settlement of Bergamo (Italian Alps)
Review of Palaeobotany and Palynology 276 (2020) 104205 Contents lists available at ScienceDirect Review of Palaeobotany and Palynology journal homepage: www.elsevier.com/locate/revpalbo Paleoecological archives unraveling the early land-use history at the emergence of the Bronze Age settlement of Bergamo (Italian Alps) Cesare Ravazzi a,⁎, Roberta Pini a, Mattia De Amicis b, Lorenzo Castellano c, Roberto Comolli b, Davide Abu El Khair b, Giulia Furlanetto b, Diego Marsetti d,RenataPeregoa a Research Group on Vegetation, Climate and Human Stratigraphy, Lab. of Palynology and Palaeoecology, CNR-IGAG, Piazza della Scienza 1, 20126 Milano,Italy b Dept. of Environmental and Earth Sciences, University of Milano-Bicocca, Piazza della Scienza 1, 20126 Milano, Italy c New York University, Institute for the Study of the Ancient World, East 84th Street, New York, USA d ECOGEO srl, via Fratelli Calvi 2, 24122 Bergamo, Italy article info abstract Article history: The hilltop town of Bergamo, at the southern fringe of the Italian Alps, represents a typical example of the stepped Received 12 February 2020 emergence of a prehistoric settlement developing into a proto-historic urban center in the Iron Age. We present Accepted 28 February 2020 here unprecedented multidisciplinary evidence based on several near-site stratigraphies, supported by a robust Available online 02 March 2020 radiocarbon chronology and by a continuous fine-resolution sedimentary and paleoecological record from a pond used for livestock watering, which was intercepted by drilling underneath the modern Catholic Cathedral. The Keywords: obtained chronostratigraphy documents the development of arable and fallow land including cereals, legumes Vegetation history Cultural landscape and livestock husbandry starting as early as 3355 yrs. -

Variante Ptc - 2018 Parco Dei Colli Di Bergamo
VARIANTE PTC - 2018 PARCO DEI COLLI DI BERGAMO NORME DI ATTUAZIONE ALLEGATO 1 – INDIRIZZI PER AMBITI DI PAESAGGIO maggio 2018 Arch. F. Thomasset, R. Gambino, NQA Nuova Qualità ambientale, dott. S. Assone, dott. F. Valfrè di Bonzo Variante al PTC del Parco dei Colli di Bergamo Norme di attuazione maggio 2018 ELENCO AMBITI: 1. Valli montane del Giongo, Badereni e Olera 2. Versante di Ranica e Torre Boldone 3. Versante di Valtesse e Monte Rosso 4. Versante di Ponteranica 5. Crinale di Sorisole e Azzonica 6. Valle del Rigos e del Rino 7. Collina di Bruntino e Monte Bastia 8. Valle del Petos 9. Piana di Valbrembo 10. Versante di Monte dei Gobbi 11 Valle d'Astino 12. Città Alta 13. Valmarina individuazione cartografica degli ambiti di paesaggio 2 Variante al PTC del Parco dei Colli di Bergamo Norme di attuazione maggio 2018 Legenda delle schede grafiche relative agli ambiti di paesaggio (redatte ortofoto Agea 2012 in scala 1:10000 e riprodotte fuori scala) 3 Variante al PTC del Parco dei Colli di Bergamo Norme di attuazione maggio 2018 1. VALLI MONTANE DEL GIONGO, BADERENI E OLERA OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESISTICA DA RAGGIUNGERE conservare (CO) - ripristinare (RE) - qualificare (Q) - potenziare (P) Paesaggio naturale di prioritario di interesse ecologico ed escursionistico, costituente ambito portante della rete ecologica, da orientare ad una gestione prettamente naturalistica, con il mantenimento delle aree aperte e il recupero delle malghe a fini naturalistici e pastorali, e con l’introduzione di ulteriori destinazioni a supporto dell'escursionismo -

The History of Napoleon Buonaparte
THE HISTORY OF NAPOLEON BUONAPARTE JOHN GIBSON LOCKHART CHAPTER I BIRTH AND PARENTAGE OF NAPOLEON BUONAPARTE—HIS EDUCATION AT BRIENNE AND AT PARIS—HIS CHARACTER AT THIS PERIOD—HIS POLITICAL PREDILECTIONS—HE ENTERS THE ARMY AS SECOND LIEUTENANT OF ARTILLERY—HIS FIRST MILITARY SERVICE IN CORSICA IN 1793. Napoleon Buonaparte was born at Ajaccio on the 15th of August, 1769. The family had been of some distinction, during the middle ages, in Italy; whence his branch of it removed to Corsica, in the troubled times of the Guelphs and Gibellines. They were always considered as belonging to the gentry of the island. Charles, the father of Napoleon, an advocate of considerable reputation, married his mother, Letitia Ramolini, a young woman eminent for beauty and for strength of mind, during the civil war— when the Corsicans, under Paoli, were struggling to avoid the domination of the French. The advocate had espoused the popular side in that contest, and his lovely and high-spirited wife used to attend him through the toils and dangers of his mountain campaigns. Upon the termination of the war, he would have exiled himself along with Paoli; but his relations dissuaded him from this step, and he was afterwards reconciled to the conquering party, and protected and patronised by the French governor of Corsica, the Count de Marbœuff. It is said that Letitia had attended mass on the morning of the 15th of August; and, being seized suddenly on her return, gave birth to the future hero of his age, on a temporary couch covered with tapestry, representing the heroes of the Iliad. -

Quaderni Di Archivio Bergamasco
SAGGI IL LAVORO DI RIORDINO E INVENTARIAZIONE DELLA SEZIONE MODERNA DELL’ARCHIVIO DELLA MISERICORDIA MAGGIORE DI BERGAMO Il 4 dicembre 2015 Archivio Bergamasco con la collaborazione e il sostegno della Fondazione MÎA ha organizzato nella Sala Locatelli della Domus Magna di via Arena in Bergamo Alta la giornata di studi avente per tema: Alla scoperta degli archivi della beneficenza a Bergamo tra Otto e Novecento. Le “nuove” carte della MÎA e della Congregazione di Carità. L’occasione dell’incontro è stata offerta dal recente lavoro di riordino e di inventariazione e successivo deposito in Archivio di Stato di Bergamo delle carte (registri e faldoni) della Sezione moder- na dell’archivio della Misericordia Maggiore. Queste carte, che sino al 2014 erano conservate presso la sede della MÎA in via Malj Tabajani 4, prima di essere depositate in Archivio di Stato ed essere così disponibili alla pubblica consultazione, per iniziativa della Fondazione sono state inventariate da Gianluca Perondi, Patrizia Talpo, Giulia Todeschini. I tre archivisti sono intervenuti come relatori nell’incontro del 4 dicembre 2015. Gianluca Perondi ha offerto un panorama aggiornato sulla attuale articolazione dell’immenso archivio della Misericordia Maggiore, che si compone di più sezioni, di serie conservate in luoghi diversi, di parti inventariate e di parti ancora in attesa di riordino e inventariazione. Giulia Todeschini e Patrizia Talpo hanno illustrato con alcuni casi esem- plari, tratti dalla documentazione d’archivio recentemente inventariata, le molte e varie possibilità di ricerca che le carte della MÎA, ora dispo- nibili, offrono al progresso della storiografia bergamasca. Nelle pagine che seguono si presentano le relazioni dei tre archivisti precedute da un profilo storico-istituzionale della Misericordia Maggiore, a cura di Giulio Orazio Bravi e Cesare Giampietro Fenili, membri del Comitato di redazione di questa rivista. -

Proposta Di Rapporto Ambientale
Via Valmarina, 25 24123 Bergamo tel. 035/4530401 P.E.C. : [email protected] PROPOSTA DI RAPPORTO AMBIENTALE Progettisti: Raffaella Gambino Federico Valfrè di Bonzo NQA Nuova Qualità Ambientale Srl Federica Thomasset Stefano Assone Gruppo di Lavoro Valutazione Ambientale Strategica: Elisa Carturan – Dottore Forestale Daniele Piazza – Dottore Agronomo Valentina Carrara – Pianificatore territoriale Niccolò Mapelli – Dottore Agronomo jr. Maggio 2018 Soggetto Proponente VAS : Parco Regionale dei Colli di Bergamo Autorità Competente VAS: Ing. Francesca Caironi – Servizio Urbanistico Autorità Procedente VAS: Rag. Manuela Corti – Direttore del Parco dei Colli di Bergamo in collaborazione con: P.a. Pasqualino Bergamelli, responsabile area tutela dell’ambiente e del verde Arch. Pierluigi Rottini, responsabile del servizio urbanistico Per le versioni successive alla prima: Versione Data Modifiche 2 INDICE 1. PREMESSA ..................................................................................................................... 5 2. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ............................................................. 6 2.1 Il contesto normativo ............................................................................................................................................... 7 3. L’ITER METODOLOGICO E PROCEDURALE ................................................................... 9 3.1 Le fasi del processo di VAS della Variante generale al PTC del Parco dei Colli e al PTC del Parco Naturale dei Colli -

GENIO CIVILE XX Secolo Inventario Sommario (1874-2002)
ARCHIVIO DI STATO DI BERGAMO GENIO CIVILE XX secolo inventario sommario (1874-2002) Il servizio del Genio Civile trova le sue origini agli inizi del XIX secolo, durante il periodo della dominazione franco-napoleonica e si caratterizza come risposta tecnica a esigenze territoriali di progettazione e gestione delle opere pubbliche: acque, strade, ponti, edifici e proprietà erariali in genere. Con il passare del tempo, subisce trasformazioni delle competenze e variazioni nell’ordinamento, pur restando fedele alla missione originaria. Successivamente all’Unità d’Italia, il servizio del Genio Civile è posto alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici; di norma ha sede in ogni capoluogo di provincia, con competenze sul territorio provinciale. Il regio decreto 2 marzo 1931 n. 287 stabilisce, tra le altre cose, che in ogni sede provinciale ordinaria siano presenti otto sezioni : servizio generale, derivazioni d'acqua e linee elettriche, opere idrauliche, bonifiche, opere stradali, opere marittime, opere edilizie, opere e servizi speciali dipendenti da pubbliche calamità. Nel 1945, per la realizzazione dei programmi eccezionali di opere pubbliche dovuti alle necessità della ricostruzione post bellica, vengono istituiti i Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche; a essi viene demandata la gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori e dei servizi di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Tale decentramento viene sancito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1534 del 30 giugno 1955. Occorre ricordare l'attività del Genio Civile quale corpo tecnico dello stato, con mansioni di consulenza e controllo: gli uffici provvedono alla revisione dei progetti di opere riguardanti gli enti locali, collaudi di lavori eseguiti con mutui e sussidi dello stato, istruttorie tecniche per concessioni di derivazioni di acque pubbliche, sorveglianza di polizia fluviale, espropriazioni di pubblica utilità e consulenza alle prefetture.