Relazione Sullo Stato Dell'ambiente
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
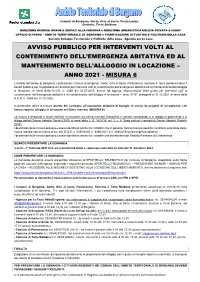
AVVISO Misura 6
Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA e DIREZIONE URBANISTICA EDLIZIA PRIVATA E SUEAP UFFICIO DI PIANO – AMBITO TERRITORIAALE DI BERGAMO e PIANIFICAZIONE ATTUATIVA E POLITICHE DELLA CASA Servizio Sviluppo Territoriale e Politiche della Casa - Agenzia per la casa AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE – ANNO 2021 - MISURA 6 L’Ambito territoriale di Bergamo, costituito dai Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone,indice il bando pubblico per l’erogazione di contributi per interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa ed al mantenimento dell’alloggio in locazione, ai sensi della D.G.R. n. 2065 del 31.07.2019, avente ad oggetto “Approvazione linee guida per interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione – anno 2019”, prorogata al 31.12.2021 ai sensi della D.G.R. n. 3664 del 13.10.2020. In particolare attiva la misura Starter kit: sostegno all’autonomia abitativa di famiglie in uscita da progetti di accoglienza, che hanno reperito alloggio in locazione sul libero mercato (MISURA 6). La misura è destinata a nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (SAS) ai sensi della L. R. 16/2016, art. 1, c. 6. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (SAP). I destinatari delle misure possono essere identificati anche tra i cittadini che in passato hanno ricevuto specifici contributi sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alle D.G.R. -

Abano Terme Acerra Aci Castello Acqualagna Acquanegra
Abano Terme Alzano Scrivia Azzano San Paolo Belvedere Marittimo Acerra Amelia Azzate Benevento Aci Castello Anagni Bagnaria Benna Acqualagna Ancarano Bagnatica Bentivoglio Acquanegra Cremonese Ancona Bagno A Ripoli Berchidda Adro Andezeno Bagnoli Di Sopra Beregazzo Con Figliaro Affi Angiari Bagnolo Cremasco Bereguardo Afragola Anguillara Veneta Bagnolo Di Po Bergamo Agliana Annicco Bairo Bernareggio Agliano Annone Di Brianza Baone Bertinoro Agliè Antrodoco Baranzate Besana in Brianza Agna Anzola D’Ossola Barasso Besenello Agordo Aosta Barbarano Vicentino Besnate Agrate Brianza Appiano Gentile Barberino Di Mugello Besozzo Agugliano Appiano sulla strada del vino Barberino Val D’Elsa Biassono Agugliaro Aprilia Barbiano Biella Aicurzio Arce Barchi Bientina Ala Arcene Bardello Bigarello Alano Di Piave Arco Bareggio Binago Alba Arconate Bariano Bioglio Alba Adriatica Arcore Barlassina Boara Pisani Albairate Arcugnano Barone Canavese Bolgare Albano Laziale Ardara Barzago Bollate Albaredo Arnaboldi Ardea Barzanò Bollengo Albaredo D’Adige Arese Basaluzzo Bologna Albavilla Arezzo Baselga Di Pinè Bolsena Albese Con Cassano Argelato Basiano Boltiere Albettone Ariccia Basiliano Bolzano Albiano Arluno Bassano Bresciano Bolzano Vicentino Albiate Arquà Petrarca Bassano Del Grappa Bomporto Albignasego Arquà Polesine Bassano In Teverina Bonate Sotto Albino Arre Bastida Pancarana Bonemerse Albiolo Arsago Seprio Bastiglia Bonorva Albisola Superiore Artegna Battaglia Terme Borghetto S. Spirito Albuzzano Arzachena Battuda Borgo San Dalmazzo Aldeno Arzano Baveno -

ATLANTE DEGLI UCCELLI DI BERGAMO a Cura Di Enrico Cairo E Roberto Facoetti
ATLANTE DEGLI UCCELLI DI BERGAMO a cura di Enrico Cairo e Roberto Facoetti Specie nidificanti e specie svernanti (2001-2004) disegni di Simone Ciocca Mario Guerra Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi” Volume 23 (2004) Bergamo 2006 edizioni junior © 2006 Comune di Bergamo Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi” di Bergamo Volume 23 (2004) Registrazione presso il Tribunale di Bergamo al n. 19 (16 settembre 1999) Direttore Responsabile Dott. Marco Valle ISSN 0393-8700 © 2006 Sull’edizione: Edizioni Junior srl Viale dell’Industria, 24052 Azzano S. Paolo (BG) Tel. 035/534123 - Fax 035/534143 e-mail: [email protected] www.edizionijunior.it ISBN 88-8434-292-9 Tutti i diritti riservati Prima edizione: dicembre 2006 Edizioni: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2010 2009 2008 2007 2006 Questo volume è stato stampato presso Tecnoprint, Romano di Lombardia (BG) Stampato in Italia - Printed in Italy Sommario PRESENTAZIONE .................................................................................................... 5 INTRODUZIONE ...................................................................................................... 7 L’ATLANTE ORNITOLOGICO ................................................................................ 9 Valore e significato...................................................................................................... 9 L’ecosistema urbano .................................................................................................... 10 Metodologia e criteri di -

889 SP 470 Villa Alme ASSOLARI
REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA DI BERGAMO Rep. Prov. n. 889 CONTRATTO D'APPALTO S.P. EX S.S. N. 470 DIR “DELLA VALLE BREMBANA”. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DAL KM. 1+000 AL KM. 5+200 NEI COMUNI DI ALMÉ, PALADINA, VALBREMBO E MOZZO (BG). AFFIDAMENTO IN DATA 04.05.2015. CODICE CUP: E37H15001220003. CODICE CIG: 6247554CA5. Importo: € 39.104,10.= L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di agosto, in Bergamo, nel Palazzo della Provincia, in Via Torquato Tasso n. 8 A V A N T I a me Dott. BENEDETTO PASSARELLO, Segretario Generale della Provincia, Ufficiale Rogante ai sensi dell’art. 97 – comma 4 – lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono personalmente comparsi i Signori: 1) Dott. Ing. ANTONIO ZANNI nato il 4 settembre 1954 a Gazzaniga (BG) e domiciliato per la carica presso la Provincia di Bergamo, DIRIGENTE del Settore “Edilizia e Patrimonio, Pianificazione territoriale, Urbanistica e Trasporti” che interviene a questo atto nella sua veste di Dirigente con conferimento temporaneo di incarico dirigenziale del Settore “Viabilità” (Decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n. 11 in data 04.02.2015) ed agisce esclusivamente in nome e per conto della PROVINCIA DI BERGAMO (C.F. n. 80004870160) indirizzo pec [email protected] che rappresenta, in forza dell'articolo 51 dello Statuto Provinciale - da una parte; 2) Sig. MARCO MAZZOLENI nato il 14 ottobre 1966 a Bergamo e residente in Valbrembo (BG), Via Briolo n. 1, che interviene a questo atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Impresa “ASSOLARI LUIGI & C. -
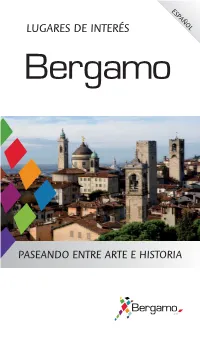
Lugares De Interés
ESP AÑOL LUGARES DE INTERÉS PASEANDO ENTRE ARTE E HISTORIA ENTRE LAS DOS CIUDADES E CASTA N I VIA G O T N VIA T AN E E PI Monastero di Valmarina T VALVERDE IN A AL P A . VI A I A IN VI VIA P M A R V RA CONCA FIORITA T I A. A A I G E BARNAB A N I M I A A V R VIA T P I A TU G A I I OR R A. V . I C F OLI V Parco dei Colli di Bergamo ON IA IA BAION RE SS A V A VIA FA Parco del Castello SCE I NC D I NZ O n viaje entre las dos ciudades, una en la colina I di S. Vigilio T C A T I Z I A E Z V P L IA N E I CO I O PIAZZALE STA D P EL H Lazzaretto NT I N . D O IN E G O A T OLIMPIADI L TE IA B T Castello di EL E Campo IA V . y la otra en la llanura, diferentes pero unidas, T S V A O R A I San Vigilio AMI RO C LINO Utili AN IA O V AB V D LE C TOV I N Z A A AL C AN F SS IA RO G. M E V AR L LE V A IA O LARGO I VI V I C A A T ’ M E T T IA Stadio DELLO N A VIA N. no solo por la historia sino también por un C A E SAN VIGILIO A H A . -

Fungolandia 2010
2010 www.fungolandia.it DA VENERDI 3 A DOMENICA 12 SETTEMBRE 2010 Programma della Sagra VENERDI 3 SETTEMBRE Ore 20,30 - Inaugurazione di Fungolandia a Piazza Brembana, centro paese (in caso di maltempo l’inaugurazione si terrà presso il Cinema di Piazza Brembana). Ore 21,00 – “Musica in… Piazza” – concerto sotto le stelle in centro paese (in caso di maltempo c/o cinema) SABATO 4 SETTEMBRE Dalle ore 10,00 – Festa di Fine Estate a Piazza Brembana: vendita e assaggi di prodotti tipici e mercatino di artigianato locale – e alle ore 19,00 Tavolata Rustica nel centro di Piazza Brembana. Dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 - Mostra fotografica sulla biodiversità “Sguardi nel bosco” delle Foreste di Lombardia – organizzata in collaborazione con ERSAF Lombardia - presso l’Ufficio Turistico di Piazzatorre. Dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30 Mostra fotografica “Arte in Natura: La montagna ci parla” con le opere del concorso fotografico di Fungolandia 2010, presso la Sala Polivalente di Piazzolo, P.zza Avis-Aido Dalle ore 14,00 alle ore 18,30 – Mostra micologica “Funghi della Valle Brembana” presso l’Info-Point di Fungolandia a Olmo al Brembo, organizzata dall’Associazione Micologica Bresadola di Agrate Brianza. Ore 8,00 – Escursione micologica “Alla scoperta dei funghi della Valle Brembana” nei boschi di Piazzatorre con i micologi dell’AMB di Agrate Brianza – ritrovo presso l’Info-Point di Fungolandia a Olmo al Brembo – raccomandiamo abbigliamento e calzature adeguate per un’escursione nel bosco. Ore 10,00 – Visita “Il gusto della vita, il senso della morte” – Visita alle danze macabre di Santa Brigida (Santuario dell’Addolorata), Averara (Ossario), Cassiglio; ritrovo alle ore 9,45 presso l’info-point di Fungolandia a Olmo al Brembo oppure alle ore 10,00 presso il Santuario dell’Addolorata a Santa Brigida; il percorso da un luogo all’altro verrà effettuato in auto. -

Parco Dei Colli Di Bergamo
M A R C O P A R A M A T T I A R C H I T E T T O v. fustina, 18, 24010 Ponteranica, tel. 035/577306; Albo arch. BG N° 1074 C.F. PRM MRC 61A16 A470G - P.I. 02209280169 Ubicazione: Comune di: Mozzo (Prov. di Bergamo) Committente: Parco dei Colli di Bergamo Oggetto: PERCORSO CICLOPEDONALE Madonna della Castagna – Mozzo LOTTO n.° 3: via Pascolo dei Tedeschi – via Castello P R O G E T T O D E F I N I T I V O Agosto 2015 RELAZIONE GENERALE e RELAZIONE TECNICA TIPOLOGIA DELLE OPERE TEMPI DI REALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA Relazione Tecnica Pro-Def 2015 3° lotto p 1/8 M A R C O P A R A M A T T I A R C H I T E T T O v. fustina, 18, 24010 Ponteranica, tel. 035/577306; Albo arch. BG N° 1074 C.F. PRM MRC 61A16 A470G - P.I. 02209280169 RELAZIONE GENERALE e RELAZIONE TECNICA PREMESSA Tramite questa opera si persegue l’intento di costituire un anello ciclopedonale che perimetri alla sua base il rilievo dei Colli di Bergamo. Dallo Stadio comunale sino alla Madonna della Castagna il tracciato ciclopedonale si snoda ininterrotto; connettendo Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Almè e Paladina, il progetto in argomento costituisce un ulteriore prolungamento dell’anello su menzionato che aggregherà al percorso anche il comune di Valbrembo e infine di Mozzo. Il tracciato ciclopedonale in oggetto ha come obiettivo parallelo quello offrire un asse di collegamento delle reti ciclopedonale interne ai comuni di Mozzo e di Valbrembo, con la rete più vasta che il Parco dei Colli sta attivando a cavallo dei colli di Bergamo; in prospettiva ne deriverà un sistema viabilistico ciclabile continuo, senza interferenze con viabilità ordinaria che salda la città di Bergamo al Brembo e ai primi rilievi orobici. -

Osservazione N. 83
VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E AL PIANO DEL PARCO NATURALE DEI COLLI DI BERGAMO OSSERVAZIONE N. 83 RIGERIMENTI GENERALI RICHIEDENTE: ing. Pierguido Piazzini Albani IN QUALITA’ DI: PER CONTO DI: PROTOCOLLO: 0523 DATA: 19.02.2019 SINTESI DELL’OSSERVAZIONE Con riferimento all’azzonamento della zona C e in relazione all’art. 15 comma 8 lettera c) è richiesta la possibilità di realizzare parcheggi privati e autorimesse interrate non solo al servizio agricolo. E’ richiesta la possibilità di realizzazione di piscine nelle zone C agricole di protezione. LOCALIZZAZIONE E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE / PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE La richiesta è accoglibile per ciò che riguarda autorimesse interrate e parcheggi privati; e parzialmente accoglibile per ciò che riguarda la realizzazione di piccoli bacini d’acqua. MODIFICHE DA APPORTARE TAVOLA: / NORME DI ATTUAZIONE - l’art. 15 comma 8 lett. c) viene modificato come segue: 8. Nella zona C sono comunque vietati tutti gli interventi e le attività che possono alterare sensibilmente la morfologia e la stabilità dei suoli, la conservazione o la riproducibilità delle risorse, la riconoscibilità e la leggibilità del paesaggio. In particolare è esclusa […] Sede Amministrativa : Via Valmarina 25 – 24123 Bergamo Tel. 035.4530400– Fax 035.577530 Sede legale: c/o Provincia di Bergamo – Via T. Tasso 8 – 24121 Bergamo e mai:l seg re te [email protected] - PEC: [email protected] Enti interessati: Almè – Bergamo – Mozzo – Paladina – Ponteranica - Ranica – Sorisole –Torre Boldone – Valbrembo – Villa d’Almè e Provincia di Bergamo c. la realizzazione di parcheggi privati, autorimesse che non siano al servizio delle attività fatto salvo due posti auto per unità immobiliare per gli usi abitativi esistenti alla data di adozione del piano purchè non modifichino la morfologia dei luoghi, non comportino la realizzazione nuovi e significativi percorsi impermeabilizzati, non comportino alterazione del paesaggio o di componenti di valore storico-culturale. -

Paleoecological Archives Unraveling the Early Land-Use History at the Emergence of the Bronze Age Settlement of Bergamo (Italian Alps)
Review of Palaeobotany and Palynology 276 (2020) 104205 Contents lists available at ScienceDirect Review of Palaeobotany and Palynology journal homepage: www.elsevier.com/locate/revpalbo Paleoecological archives unraveling the early land-use history at the emergence of the Bronze Age settlement of Bergamo (Italian Alps) Cesare Ravazzi a,⁎, Roberta Pini a, Mattia De Amicis b, Lorenzo Castellano c, Roberto Comolli b, Davide Abu El Khair b, Giulia Furlanetto b, Diego Marsetti d,RenataPeregoa a Research Group on Vegetation, Climate and Human Stratigraphy, Lab. of Palynology and Palaeoecology, CNR-IGAG, Piazza della Scienza 1, 20126 Milano,Italy b Dept. of Environmental and Earth Sciences, University of Milano-Bicocca, Piazza della Scienza 1, 20126 Milano, Italy c New York University, Institute for the Study of the Ancient World, East 84th Street, New York, USA d ECOGEO srl, via Fratelli Calvi 2, 24122 Bergamo, Italy article info abstract Article history: The hilltop town of Bergamo, at the southern fringe of the Italian Alps, represents a typical example of the stepped Received 12 February 2020 emergence of a prehistoric settlement developing into a proto-historic urban center in the Iron Age. We present Accepted 28 February 2020 here unprecedented multidisciplinary evidence based on several near-site stratigraphies, supported by a robust Available online 02 March 2020 radiocarbon chronology and by a continuous fine-resolution sedimentary and paleoecological record from a pond used for livestock watering, which was intercepted by drilling underneath the modern Catholic Cathedral. The Keywords: obtained chronostratigraphy documents the development of arable and fallow land including cereals, legumes Vegetation history Cultural landscape and livestock husbandry starting as early as 3355 yrs. -

Paladina-Sedrina I Costi Alle Stelle: 400 Milioni Di Euro
L’ECO DI BERGAMO 28 DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 Ad ottobre ripresi i lavori Provincia per la variante di Zogno Dopo 5 anni di stop e una nuova impresa, lo [email protected] scorso ottobre sono ripresi i lavori per la va- www.ecodibergamo.it/cronaca/section/ riante di Zogno: termineranno entro fine 2021. Il progetto della Paladina-Sedrina Paladina-Sedrina Il tracciato del terzo lotto L’attuale proposta di variante SVINCOLO DI BOTTA Tracciato esistente Sedrina I costi alle stelle: (cantiere di allargamento) Villa d’Almè 400 milioni di euro Sorisole Almenno Infrastrutture. Il 12 febbraio presentazione ai sindaci San Salvatore Il conto è ulteriormente salito rispetto alle previsioni Almenno Almè SVINCOLO Ma l’opera è tra quelle destinate a passare sotto l’Anas San Bartolomeo DI SORISOLE/ALMÈ DINO NIKPALJ ne serviranno almeno 400, zione, l’Iva, le compensazio- Una volta c’erano 90 probabilmente 420. ni, le soprese, eccetera… To- milioni sul piatto. Ora proba- Questa pare la cifra piom- tale, 420 milioni. Fermo re- bilmente non ci sono più, co- bata fragorosamente (in ogni stando che nel frattempo i Paladina me ha rilevato venerdì sera il senso) sul tavolo di Via Tasso costi di cantiere sarebbero sindaco di San Pellegrino nelle scorse settimane e che, comunque saliti a quota 285. SVINCOLO DI VALBREMBO Terme, Vittorio Milesi, nel- euro più, euro meno, potreb- Di loro. l’affollato incontro per la li- be essere presentata agli am- nea T2 del tram, uscendo per ministratori della valle tra Ma i soldi sono da trovare Valbrembo un attimo dai binari (ma una decina di giorni. -

PROVINCIA DI BERGAMO Via T
Numero 461 Reg. Ordinanze Registrato in data 09/12/2020 UNITA' SVILUPPO INFRASTRUTTURALE STRATEGICO DELLA VIABILITA' Riqualificazione della rete viaria OGGETTO S.P. N.9: MEZZOLDO - CONFINE VALTELLINESE CHIUSURA AL TRANSITO NEL COMUNE DI MEZZOLDO. DAL 09/12/2020 p_bg.p_bg.REGISTRO UFFICIALE.U.0066659.09-12-2020.h.14:27 PROVINCIA DI BERGAMO Via T. Tasso, 8 – 24121 Bergamo Ordinanza 461 - 09/12/2020 Pag. 2/3 ORDINANZA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO Visto il decreto presidenziale numero 67 del 30/04/2020 di conferimento delle funzioni dirigenziali al Dott. Ing. Massimiliano Rizzi dal 01/05/2020 sino al termine del mandato; Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs 30.04.92 n. 285 e successive modifiche; Viste le copiose nevicate dei giorni scorsi che hanno determinato un rischio forte rischio valanghe; Visto che per garantire la sicurezza del transito stradale è stato necessario chiudere la SP 9 nel tratto in oggetto dal giorno 04/12/2020; Visto il parere favorevole dell’U.O. n. 1 del Servizio Riqualificazione rete viaria di questa Unità; ORDINA La chiusura al transito della SP n°9 dalla progr.va km 53+900 (Loc.Madonna delle Nevi) alla progr.va 59+400 (Loc.Cà San Marco) nel comune di Mezzoldo dal giorno 09/12/2020. La presente ordinanza viene inviata per opportuna competenza e conoscenza ai seguenti destinatari: Stazione Carabinieri di PIAZZA BREMBANA Stazione Carabinieri Forestale di PIAZZA BREMBANA Sindaco di MEZZOLDO - AVERARA Comunità Montana Valle Brembana di PIAZZA BREMBANA Impresa: CALCESTRUZZI MAGNATI SRL – PONTERANICA Impresa: REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL – OLMO AL BREMBO Autoservizi: SAB – LOCATELLI – ZANI Al Presidente della Provincia di Bergamo SEDE Ufficio Territoriale del Governo BERGAMO Poste Italiane CDM BERGAMO Ufficio Provinciale M.C.T.C. -

In Forma Unica Per L’Intervento Di Riqualifi Cazione Ed Provvisoria – Riqualifi Cazione Ed Ampliamento – LLPP Ampliamento Del Fabbricato Spogliatoi – LLPP 2014
inPPonteranicao formanteranica notizie dall’amministrazione comunale numero 3 . anno 7 . dicembre 2015 I PPIEDIIEDI PPERER TTERRAERRA LLOO SSGUARDOGUARDO IINN AALTOLTO VVERSOERSO IILL FUTURO.FUTURO. È qquestauesta llaa ddirezioneirezione ddaa mmantenere.antenere. Riceve il martedì dalle 19 alle 21 e su appuntamento Alberto Nevola il venerdì dalle 6.30 alle 8 e dalle 10 alle 12. Sindaco [email protected] Insieme a molti abbiamo iniziato il nostro percorso insieme a molti di più lo stiamo percorrendo. LAVORARE IN SINERGIA CON IL TERRITORIO PORTA RISULTATI Cari concittadini, l’anno è al termine e noi momenti di condivisione e di sostegno delle fragilità, volgiamo indietro lo sguardo per vedere quanto affi nché il diritto allo studio sia pieno ed eff ettivo è stato fatto e quanto rimane ancora da fare per tutti. per raggiungere gli obiettivi che ci siamo Analogamente il dialogo con Sorisole, prefi ssati ad inizio mandato. i nostri vicini di casa, ha portato alla Sebbene la situazione economica messa a punto di un sistema di dei comuni continui ad essere controllo del territorio. A partire caratterizzata da grande precarietà dai primi mesi del nuovo anno, e incertezza, che rendono diffi cile potremo conoscere in tempo una programmazione di medio- reale se veicoli rubati o segnalati lungo termine, ritengo sia stato si introducono all’interno dei due fatto molto per ricercare il massimo comuni, rendendo così più effi cienti grado di sinergie a livello locale e e tempestivi gli interventi delle forze sovracomunale e costruire quelle dell’ordine. reti che consentono di massimizzare le Sempre a livello sovracomunale stiamo risorse a disposizione del territorio.