DOMINICUSDOMINICUS SOMMARIO N.3 MAG/LUG 2014 Fra Enrico Arata 97 Editoriale EDITORIALE Op
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
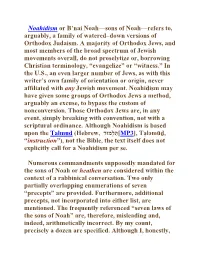
Noahidism Or B'nai Noah—Sons of Noah—Refers To, Arguably, a Family
Noahidism or B’nai Noah—sons of Noah—refers to, arguably, a family of watered–down versions of Orthodox Judaism. A majority of Orthodox Jews, and most members of the broad spectrum of Jewish movements overall, do not proselytize or, borrowing Christian terminology, “evangelize” or “witness.” In the U.S., an even larger number of Jews, as with this writer’s own family of orientation or origin, never affiliated with any Jewish movement. Noahidism may have given some groups of Orthodox Jews a method, arguably an excuse, to bypass the custom of nonconversion. Those Orthodox Jews are, in any event, simply breaking with convention, not with a scriptural ordinance. Although Noahidism is based ,MP3], Tạləmūḏ]תַּלְמּוד ,upon the Talmud (Hebrew “instruction”), not the Bible, the text itself does not explicitly call for a Noahidism per se. Numerous commandments supposedly mandated for the sons of Noah or heathen are considered within the context of a rabbinical conversation. Two only partially overlapping enumerations of seven “precepts” are provided. Furthermore, additional precepts, not incorporated into either list, are mentioned. The frequently referenced “seven laws of the sons of Noah” are, therefore, misleading and, indeed, arithmetically incorrect. By my count, precisely a dozen are specified. Although I, honestly, fail to understand why individuals would self–identify with a faith which labels them as “heathen,” that is their business, not mine. The translations will follow a series of quotations pertinent to this monotheistic and ,MP3], tạləmūḏiy]תַּלְמּודִ י ,talmudic (Hebrew “instructive”) new religious movement (NRM). Indeed, the first passage quoted below was excerpted from the translated source text for Noahidism: Our Rabbis taught: [Any man that curseth his God, shall bear his sin. -
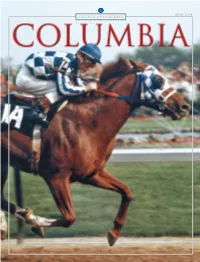
Knights of Columbus
APR 18 E COVERS FINAL.qxp_Layout 1 3/15/18 2:16 PM Page 1 APRIL 2018 KNIGHTSOFCOLUMBUS April Columbia Ad ENGLISH.qxp_Layout 1 3/14/18 3:02 PM Page 1 Keeping Our Promise Find an agent at kofc.org or 1-800-345-5632 LIFE INSURANCE • DISABILITY INCOME INSURANCE • LONG-TERM CARE INSURANCE • RETIREMENT ANNUITIES World’s Most Ethical Companies® and Ethisphere® names and marks are registered trademarks of Ethisphere LLC. APRIL 18 E 3_15 FINAL 2.qxp_Mar E 12 3/15/18 12:02 PM Page 1 KNIGHTSOFCOLUMBUS a P r i l 2 0 1 8 ♦ V o l u m E 9 8 ♦ N u m b E r 4 COLUMBIA FEATURES 8 Secretariat and the Knight Who Raced Him to Victory An interview with Ron Turcotte, the Hall of Fame jockey who rode the fastest steed of all time. BY ALTON J. PELOWSKI 14 Game On! The father of gold medal winner Amanda Pelkey reflects on watching his daughter’s dream come true. BY JOHN PELKEY, WITH COLUMBIA STAFF 16 The Last Martyr of Mexico The heroic witness of St. Pedro Maldonado, a member of the Knights, inspired the restoration of religious freedom to his state. BY JUAN GUAJARDO 20 ‘Love Is the Only Way’ An interview with actor Jim Caviezel about his role in the new film Paul, Apostle of Christ. BY COLUMBIA STAFF 22 Knighthood and the ‘New Man’ A rosary that belonged to St. Pedro de Jesús Maldonado Lucero, a Catholic men are called to be faithful servants, priest and Knight of Columbus who was martyred in 1937, is pic- protecting their families and building up the Church. -

Dominican History Newsletter 5 (1996)
INSTITUTUM HISTORICUM ORDINIS FRATRUM PRAEDICATORUM DOMINICAN HISTORY NEWSLETTER BULLETIN D'HISTOIRE DOMINICAINE BOLLETTINO DI STORIA DOMENICANA V 1996 ROMAE 1996 ABBREVIATURAE Ad perspicuitatem bibliographiarum servandam abbreviaturas quam maxime vitandas censuit redactor. His tamen uti quae sequuntur visum est, ne eadem saepius piene citata paginam inutiliter gravent: AFP Archivum Fratrum Praedicatorum AGOP Archivum Generale OP (Convento di S.Sabina, Piazza P. d'Il liria 1, 00153 Roma, Italia) ASOP Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum BG Bibliographia generalis in hoc volumine edita Comp. Compendia dissertationum in hoc volumine edita CP R.Coulon & A.Papillon OP, Scriptores Ordinis Praedicatorum 1701-1750 (Roma & Paris in pluribus fasciculis 1909-1934, denuo in duobus voluminibus apud Bibl. SJ, heverlee 1961 ). DHN Dominican History Newsletter Diss. Tabula dissertationum in hoc volumine edita Documents Documents pour servir à l'Histoire de l'Ordre de Saint-Domi nique en France KP Thomas Kaeppeli OP - Emilio Panella OP, Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi (S.Sabina, Roma 1970-94) MOPH Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica Not. Var. Notitiae variae in hoc volumine editae QE J.Quétif & J.Échard OP, Scriptores Ordinis Praedicatorum (Paris 1719-1721) 2 voli. QF Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikaner ordens (in Deutschland) RP Repertorium peritorum (1996) in hoc volumine editum In omnibus bibliographiis scripta recentius edita (1988-1993) asterisco ('') notantur. 2 Voi. V, 1996 PRAEFATIO REDACTORIS Pro hoc fasciculo redigendo, quia multa alia inserenda erant, totam seriem unius tantum periodici scrutatus sum, Escritos del Vedat. Ut promisi autem Repertorium Peritorum integrum renovavi, inde excludens paucos qui nobiscum communicationem non iam tenent; bibliographiae tamen et cetera quae iam in fasciculis praeteritis nuntiata sunt hic non iterum eduntur. -

Crkva U Svijetu Časopis Za Vjersku Kulturu
CRKVA U SVIJETU ČASOPIS ZA VJERSKU KULTURU GODINA III BROJ 6 SPLIT 1968 DACHAU NAJVEĆE SVEĆENIČKO GROBLJE Jedna tužna — veoma tužna — obljetnica ponukala me je da uzmem pero u ruku. Ove godine se navršila 35. godišnjica osnutka prvoga kon centracionog logora u Zapadnoj Evropi, koji je zatim postao simbolom okrutnosti i nasilja, užasa i patnje, tiranije i ropstva. I to u punom XX stoljeću! (Napominjem odmah na početku: Dachau ipak nije bio najgori nje mački logor. To znam iz vlastitog iskustva, jer sam proživio tri razna nacistička logora. Jednako tvrde i svi drugovi koji su bili razasuti po raznim logorima Reicha te imali prigodu da uspoređuju. No jer je Dachau bdio prvi njemački logior, ostalo je najpoznatijim logorom i postao simbo lom novovjekovnog ropstva). LOGOR DACHAU Po naredbi Hi nil era (koji je tada bio još samo šef policije u Mün- chenu) logor Dachau je službeno otvoren dne 22. ožujka 1933. U prvo vrijeme nalazio se u jednoj napuštenoj tvornici oružja posred dachauske močvare, blizu gradića Dachau (15 km sjeverozapadno od glavnoga grada Bavarske, Münchena). Bio je predviđen za 5.000 zatvorenika, ali naci stička revnost i okrutnost brzo je premašila sve Himlerove prognoze.^ Logor se prenaglo punio »neprijateljima III Reicha«, pa se već g. 1938. pi istupilo njegovu proširenju. Samo po službenim nacističkim registrima od 1933. do 1945. kroz Dachau je prošlo više od 206.000 robijaša.2 A ko liki su otišli (osobito Židovi) neregistrirani na drugi svijet, to sam Bog znade ! U Dachauu su bile zastupane mnoge narodnosti (gotovo sve evrop ske), no najviše je bilo Rusa, Pioljaka i Nijemaca. -

Fifth Sunday of Easter May 19, 2019 Pastor
Fr. Luis R. Largaespada Fifth Sunday of Easter May 19, 2019 Pastor Fr. Damian Flanagan Parochial Vicar Mrs. Mary E. Fernández, Ed.S. School Principal Mrs. Patricia Zapatero Director of Religious Education Roberto Berrocal Music Director OFFICE HOURS (Horas de Oficina) Monday thru Friday/Lunes a Viernes 8:00 am-5:00 pm CHURCH IS OPEN (La iglesia está abierta) Daily/Diario 9:00 am-7:00 pm MASS SCHEDULE (Horario de Misas) SATURDAY VIGIL 5:30 pm (English) SUNDAY 9:00 am (English, live streaming) 10:30 am (English, live streaming) 12:30 pm (Español, transmisión digital en vivo) 5:30 pm (English) 7:00 pm (Español) DAILY MASS (Chapel) Misa Diaria (Capilla) 8:00 am (English) 7:00 pm (Español, martes [en la iglesia] y jueves [en la capilla]) EUCHARISTIC ADORATION Adoración Eucarística Thursdays/Jueves, 8:30 am-7:00 pm DAILY ROSARY Rezo del Rosario 7:30 am (Monday-Friday/Lunes a viernes) RECONCILIATION (Reconciliación) Saturdays/Sábados 4:30-5:15 pm Before Sunday Masses if a priest is available. Antes de las misas del domingo si hay un sacerdote disponible. BAPTISMS & MARRIAGES (Bautizos y Matrimonios) For information, call the office. Para información, llame a la oficina.. Salvator Mundi, Leonardo da Vinci, (c.1500) Private Collection, Location Unknown Page 2 Fifth Sunday Easter (Cycle C) A Sunday Reflection If the Cross is the sign of the Christian, Love is the identifying Growing in Faith. Firm in Hope. mark. Love and the Cross go together. Fervent in Charity. In today’s gospel the Lord opens His heart to the disciples. -

At Easter Pope Calls Christians to Be Channels of Mercy, Justice, Peace
April 7, 2013 Think Green 50¢ Recycle Volume 87, No. 14 Go Green todayscatholicnews.org Serving the Diocese of Fort Wayne-South Bend Go Digital TTODAYODAY’’SS CCATHOLICATHOLIC Alleluia! The Triduum and Easter liturgies highlighted At Easter pope calls Christians to be Pages 1, 8-9 channels of mercy, justice, peace Pope Francis’ first general audience BY CINDY WOODEN Step out of the comfort zone VATICAN CITY (CNS) — With Jesus’ Resurrection Page 3 “love has triumphed, mercy has been victorious,” Pope Francis said in his first Easter message “urbi et orbi” (to the city and the world). “Let us become agents of this mercy, channels through which God can water the earth, protect all creation and Miracle recognized make justice and peace flourish,” the pope said after cel- ebrating Easter morning Mass March 31. Foundress of Sisters of St. Pope Francis offered special prayers for peace in Syria and the rest of the Middle East, for an end to violence Francis on path to sainthood in Africa — especially in Mali, Nigeria, Congo and the Page 3 Central African Republic — and in Asia, particularly on the Korean peninsula. He prayed for “peace in the whole world, still divided by greed looking for easy gain, wounded by selfishness which threatens human life and the family, selfishness that Holy Cross continues in human trafficking, the most extensive form of slavery in this 21st century.” ordinations Pope Francis said he would like to bring the good news Three to be ordained to of Christ’s Resurrection to each person on earth, “to every house and every family, especially where suffering is priesthood Saturday greatest: in hospitals, in prisons.” Easter, he said, “means that the love of God is stronger Page 4 than evil and death itself; it means that the love of God can transform our lives and let those desert places in our hearts bloom.” Easter dawned with blue skies and sunshine in Rome, All Diocese Team but as the crowds gathered in St. -

Errata Corrige Bollettino III Trimestre
Errata corrige al Bollettino dell’Ufficio della Proprietà Letteraria Artistica e Scientifica Anno XXXI - N. 7-8-9 luglio agosto-settembre 1975 Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto d’autore (R.P.G.) - Parte I PAG. NUMERO DI LEGGASI REGISTRAZIONE 809 212941 Pubblicatore: Gabrieli Edit. 928 212942 Titolo: MANUALE PICTORIAL TEST OF INTELLIGENCE 796 212943 Titolo: SALAMMBO 923 212944 Titolo: PER UNA DEMOCRATICA ATTUAZIONE DEL PIANO DI URBANISTICA COMMERCIALE – ATTI DELLA CONFERENZA 5 DICEMBRE 1974 822 212945 AUTORE: BIBLIOTECA COMUNALE DELL’ARCHIGINNASIO, MONTANARI Luigi (A cura di) Titolo: IL FONDO FABBRI – L’ARCHIGINNASIO 922 212947 Titolo: ATTI COSTITUTIVI E ELEMENTI PER IL PROGRAMMA 931 212948 Titolo: L'ARGOMENTAZIONE DIMOSTRATIVA IN ARISTOTELE - COMMENTO AGLI ANALITICI SECONDI - I 943 212949 Autore: ARBIZZANI, COLLINI, MAGNANI Enea, MAZZOLI VIGARANI 811 212951 Titolo: MIRRA - VOL. XVIII DELLE TRAGEDIE Luogo e data di pubblicazione: Asti 1974 921 212952 Pubblicatore: F.N.A.A. - Roma Titolo: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO – PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELL’ABBIGLIAMENTO STIPULATO IN MILANO IL 14 NOVEMBRE 1974 893 212954 Autore: PIRACCININI Orlando (A cura di) 891 212955 Autore: BENTINI Jadranka Titolo: IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 926 212957 Autore: BULGARELLI Germano, ed altri Titolo: UN ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO - PER L'ATTUAZIONE DI UN NUOVO PRINCIPIO EDUCATIVO-FORMATIVO I QUADERNI DELLA GIUNTA REGIONALE 8 944 212958 -

Rundbrief Erscheint Zum Todestag Von Karl Reihen Vorgestellt
Inhalt Seite An die Freunde von Karl Leisner 2 Volksmission in Kleve 4 Die ersten drei Exerzitien des jungen Karl Leisner 6 Gerleve 10 Schönstatt 28 ´s-Heerenberg 43 Exerzitienwesen im Bistum Münster 54 Johannes Maria Verweyen 57 Johannes Maria Verweyen und Karl Leisner 63 Brief von Mutter Leisner an Frau Frede 65 Meditative Gedanken am „Portal der Versöhnung“ in Kevelaer 66 Porträts im „Portal der Versöhnung“ von in der Nazi-Diktatur verfolgten oder 70 hingerichteten Frauen und Männern Nachrichten aus aller Welt 76 Einladung 77 Lebensdaten Karl Leisners 78 Weihekurs von Karl Leisner 78 Gedicht zur Priesterweihe und Primiz 81 Eucharistiefeier am 12. August – Gedenktag des Seligen Karl Leisner 85 Karl Leisner und das Kaspertheater 88 Mitglieder des IKLK 92 Informationsmaterial über Karl Leisner 1 Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde von Karl Leisner! Dieser Rundbrief erscheint zum Todestag von Karl Reihen vorgestellt. In diesem ist es der Philosoph Leisner am 12. August, dem seit der Seligsprechung und Gottsucher Johannes Maria Verweyen. offiziellen kirchlichen Gedenktag. Es wäre gut, in Der Aspekt der Stellvertretung zeigt sich auch den Gemeinden an diesem Tag einen Gottesdienst deutlich im Fries am „Portal der Versöhnung“ in zu feiern und dazu vor allem junge Menschen Kevelaer1. Die dort dargestellten Personen werden einzuladen, um ihnen die Bedeutung Karl Leisners in diesem Rundbrief beschrieben. vor Augen zu stellen. Klaus Riße nahm an den Feierlichkeiten anläßlich Beim Studium der Tagebücher Karl Leisners fiel der Enthüllung des Portals am 26. Oktober 1997 teil mir auf, welche Bedeutung für ihn als junger und schildert seine Begegnung mit dem Kunstwerk. -

0 Acta Capituli Generalis Provincialium Ordinis
ACTA CAPITULI GENERALIS PROVINCIALIUM ORDINIS PRÆDICATORUM BONONIÆ A DIE XVI IULII AD DIEM IV AUGUSTI MMXVI SUB FR. BRUNO CADORÉ SACRÆ TEOLOGIÆ DOCTORE TOTIUSQUE EIUSDEM ORDINIS MAGISTRO CELEBRATI ROMÆ EX CURIA GENERALITIA AD S. SABINAM MMXVI 0 DIFFINIERUNT SUB FR. BRUNO CADORÉ UNIVERSI ORDINIS PRAEDICATORUM MAGISTRO Priores Provinciales fr Jesús Antonio DÍAZ SARIEGO, Provinciæ Hispaniæ fr Loïc Marie LE BOT, Provinciæ Tolosanæ fr. Michel LACHENAUD, Provinciæ Franciæ fr. Fausto ARICI, Provinciæ S. Dominici in Italia fr. Aldo TARQUINI, Provinciæ Romanæ S. Catharinæ Senensis fr. Francesco LA VECCHIA, Provinciæ S. Thomæ Aquinatis in Italia fr. Johannes BUNNENBERG, Provinciæ Teutoniæ fr. Martin GANERI, Provinciæ Angliæ fr. Paweł KOZACKI, Provinciæ Poloniæ fr. Benedikt Tomáš MOHELNÍK, Provinciæ Bohemiæ fr. Anto GAVRIĆ, Provinciæ Croaticæ, Annuntiationis BMV fr. Pedro DA CRUZ FERNANDES, Provinciæ Portugalliæ fr. René L. DINKLO, Provinciæ Neerlandiæ fr. Gregory CARROLL, Provinciæ Hiberniæ fr. Jorge Rafael DIAZ NUÑEZ, Provinciæ S. Iacobi in México fr. Juan José SALAVERRY VILLARREAL, Provinciæ S. Ioannis Baptistæ de Perú fr. Said LEÓN AMAYA, Provinciæ S. Ludovici Bertrandi de Colombia fr. Javier GONZÁLEZ IZQUIERDO, Provinciæ Dominæ Nostræ de Rosario fr. Javier María POSE, Provinciæ Argentinæ S. Augustini fr. Kenneth Raymond LETOILE, Provinciæ S. Joseph in SFAS fr. Frans MICALLEF, Provinciæ S. Pii V Melitensis fr. André DESCÔTEAUX, Provinciæ S. Dominici Canadensis fr. Mark C. PADREZ, Provinciæ SS. Nominis Iesu in SFAS fr. Thomas G. BROGL, Provinciæ Germaniæ Superioris et Austriæ fr. James Vincent MARCHIONDA, Provinciæ S. Alberti Magni in SFAS fr. Kevin SAUNDERS, Provinciæ Assumptionis BMV Australiæ et N. Zelandiæ fr. Edivaldo António DOS SANTOS, Provinciæ fr Bartholomaei de Las Casas in Brasilia fr. -

Program and Events
ALBA ENGLISH Program and Events 89 ALBA - 5 OTTOBRE - 24 NOVEMBRE 2019 89th International Alba White Truffle Fair ALBA – 5TH OCTOBER 24TH NOVEMBER 2019 www.fieradeltartufo.org INFO ABOUT THE FAIR Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba Tel. +39 0173 361051 ALBA [email protected] www.fieradeltartufo.org United Nations Designated INFO ABOUT TRUFFLES Educational, Scientific and UNESCO Creative City Centro Nazionale Studi Tartufo Cultural Organization in 2017 Tel. +39 0173 228190 [email protected] - www.tuber.it WITH THE MAIN SUPPORT OF WINERY VISIT BOOKING Piemonte on Wine Tel. +39 0173 635013 SPNSORED BY [email protected] www.piemonteonwine.it INFO ABOUT THE TERRITORY Ente Turismo Langhe WITH THE CONTRIBUTION OF Monferrato Roero Tel. +39 0173 35833 [email protected] www.langheroero.it HOTEL, RESTAURANT OFFICIAL SPARKLING WINE OFFICIAL MINERAL WATER AND TOUR BOOKINGS Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero Tel. +39 0173 362562 +39 0173 366328 OFFICIAL RICE OFFICIAL PARTNER [email protected] www.tartufoevino.it IN COLLABORATION WITH CREDITS Communication and MAIN SPONSOR coordination project: Blulab Visual: Gianluca Bagnasco Printing: L’artigiana Design & website: Blulab Photos: Davide Carletti, Davide Dutto, Tino Gerbaldo, Giulio Morra, Luca Privitera, Stefania Spadoni 1 Cortile della Maddalena 13 Church of San Giuseppe 2 Coro della Maddalena 14 Palazzo Banca d’Alba A21 TORINO - PIACENZA 3 Sala Beppe Fenoglio 15 Piazza Pertinace / Piazza San Giovanni A6 TORINO - SAVONA P23 A33 ASTI - CUNEO 4 Civic museum of Archaeology 16 Piazza Cagnasso Via Torino and natural Sciences “F. Eusebio” 17 Piazza Garibaldi 5 Ponzio - Truffle Museum 18 www.museotartufoalba.it 18 Piazza Medford PIAZZA MEDFORD 6 Piazza Falcone 19 Palazzo Mostre e Congressi “G. -

505 7. Testi Non Posseduti Dalla Biblioteca 1945 1946
7. TESTI NON POSSEDUTI DALLA BIBLIOTECA 1945 1 Deportazione : settimanale degli ex internati in Germania. - Torino : Società editrice torinese, 1945-[1946?]. Posseduto da: Istituto storico della resistenza di Torino (TO0 G1) e da: dalla Biblioteca nazionale di Torino (TO0 02). - TO00199405. PER.317 ; GIORN.I.282 2 Diario della prigionia in Germania / Enrico Ampatti. - [S.l. : s.n.], dopo il 1945. - 33 p., [8] c. di tav. ; 33 cm. Posseduto da: Biblioteca di stooria moderna e contemporanea di Roma (IEI 02). - IEI0163388. 3 Dora, Auschwitz, Buchenwald, Bergen-Belsen : croquis clandestins / Léon Delarbre. - Paris : M. De Romilly, c1945. - XII, [20] c.di tav. ; 24 cm. Posseduto da: Biblioteca E. Artom della Comunità ebraica di Torino (TO0 67). - IEI0123681. B.III.111 4 La prova : storia di un campo di concentramento / Willi Bredel ; prefazione di Felice Balbo. - Torino : Orma, 1945. - 249 p. ; 22 cm. Posseduto da: Istituto storico della resistenza di Torino (TO0 G1). - TO00526172. DAERA.Rno.17 5 I soldati della palude : tredici mesi di campo di concentramento : relazione oggettiva apolitica / Wolgang Langhoff. - Torino : Libreria editrice Eclettica, 1945. - 235 p. : ill. ; 20 cm. Posseduto da: Istituto storico della resistenza di Torino (TO0 G1). - TO00643836. DAERA.Rno.58 1946 6 Cavalli 8, uomini... : pagine di un internato / Luigi Fiorentino ; disegni Gino Zannini. - Milano : La Lucerna, stampa 1946. - 266 p., [24] c. di tav. : ill. ; 20 cm. Posseduto da: Biblioteca nazionale centrale di Firenze. - CUB0278258. 7 Don Narciso Sordo da Trento a Mauthausen per l'olocausto / Angelo De Gentilotti. - Bolzano : Tip. P. Mariz, 1946. - 16 p. Posseduto da: Biblioteca nazionale centrale di Firenze. -

Testimoni Di Libertà. Chiesa Bresciana E Repubblica Sociale Italiana
MAURILIO LOVATTI Testimoni di libertà Chiesa bresciana e Repubblica Sociale Italiana (1943 – 1945) Grafica: Tipografia Camuna S.p.A. - Breno/Brescia © Edizioni Opera Diocesana San Francesco di Sales - Brescia 2015 ISBN: 978-88-6146-066-9 È vietata la riproduzione dei testi senza autorizzazione scritta. Prefazione “Purificare la memoria” è un compito delicato e indispensabile per una crescita equilibrata delle persone e della società. Con quest’e- spressione s’intendono almeno due cose. Anzitutto non censurare il passato, non nasconderlo o non alterarlo perché non ci piace, perché non corrisponde all’idea che vogliamo avere di noi stessi; poi pren- dere una posizione corretta nei confronti del passato, riconoscendo- ne con sincerità gli errori e le insufficienze in modo da superare il rischio di ripeterli. La ‘censura’ a livello personale produce nevrosi e quindi immagini infondate e comportamenti irrazionali; a livello sociale, poi, censurare il passato produce intolleranza, aggressività, incapacità di un dialogo sincero e fruttuoso. Di dialogo abbiamo un bisogno profondo e urgente in questi tempi nei quali le cultu- re si confrontano, si contrappongono, si criticano a vicenda; e per il dialogo è condizione previa necessaria la sincerità, la correttezza, la libertà interiore. Ora, nella nostra memoria di Italiani hanno un posto importante gli anni del fascismo, della guerra e della resisten- za. Rivisitare quegli anni, farlo con un animo obiettivo e sereno, è indispensabile per costruire poco alla volta, con fatica, una memoria 5 che sia condivisa e che contribuisca, quindi, ad arricchire la com- pattezza morale del nostro paese. Non è un impegno facile perché anche la memoria è sottomessa a valutazioni animose, di parte, che tendono a esacerbare i conflitti e a contrapporre le interpretazioni.