QUALESTORIA Rivista Di Storia Contemporanea 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Libertarian Marxism Mao-Spontex Open Marxism Popular Assembly Sovereign Citizen Movement Spontaneism Sui Iuris
Autonomist Marxist Theory and Practice in the Current Crisis Brian Marks1 University of Arizona School of Geography and Development [email protected] Abstract Autonomist Marxism is a political tendency premised on the autonomy of the proletariat. Working class autonomy is manifested in the self-activity of the working class independent of formal organizations and representations, the multiplicity of forms that struggles take, and the role of class composition in shaping the overall balance of power in capitalist societies, not least in the relationship of class struggles to the character of capitalist crises. Class composition analysis is applied here to narrate the recent history of capitalism leading up to the current crisis, giving particular attention to China and the United States. A global wave of struggles in the mid-2000s was constituitive of the kinds of working class responses to the crisis that unfolded in 2008-10. The circulation of those struggles and resultant trends of recomposition and/or decomposition are argued to be important factors in the balance of political forces across the varied geography of the present crisis. The whirlwind of crises and the autonomist perspective The whirlwind of crises (Marks, 2010) that swept the world in 2008, financial panic upon food crisis upon energy shock upon inflationary spiral, receded temporarily only to surge forward again, leaving us in a turbulent world, full of possibility and peril. Is this the end of Neoliberalism or its retrenchment? A new 1 Published under the Creative Commons licence: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works Autonomist Marxist Theory and Practice in the Current Crisis 468 New Deal or a new Great Depression? The end of American hegemony or the rise of an “imperialism with Chinese characteristics?” Or all of those at once? This paper brings the political tendency known as autonomist Marxism (H. -
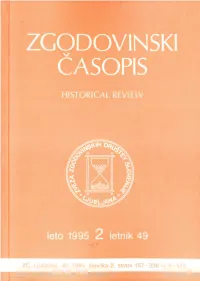
Historical Review
ZGODOVINSKI V ČASOPIS HISTORICAL REVIEW ZČ, Ljubljana, 49, 1995, številka 2, strani 157-336 in V-VIII UDC 949.712(05) ZGODOVINSKI UDK ČASOPIS STORICAL RLVI ISSN 0350-5774 GLASILO ZVEZE ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE Uredniški odbor: dr. Bogo Grafenauer dr. Vasilij Melik (glavni in odgovorni urednik) Janez Stergar (namestnik glavnega urednika) Nataša Stergar (tehnični urednik) dr. Miro Stiplovšek dr. Peter Štih Za znanstveno vsebino prispevkov so odgovorni avtorji. Ponatis člankov in slik je mogoč samo z dovo ljenjem uredništva in navedbo vira. Redakcija tega zvezka je bila zaključena 31. 5.1995. Izdajateljski svet: dr. Milica Kacin-Wohinz, Zdravko Klanjšček, dr. Jože Koropec, Samo Kristen, dr. Vasilij Melik, dr. Darja Mihelič, dr. Janko Pleterski, Janez Stergar, Prvenka Turk Prevodi: Niko Hudelja in Sergij Vilfan (nemščina), Lidija Berden in Janez Stanonik (angleščina) Zunanja oprema: Neta Zwitter Sedež uredništva in uprave: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, SI-1000 Ljubljana, Aškerčeva 2/1, tel.: (061) 17-69-210 Letna naročnina: za nečlane in ustanove 3900 SIT, za društvene člane 2700 SIT, za društvene člane- upokojence 2000 SIT, za društvene člane-študente 1350 SIT (vse za leto 1995) Cena tega zvezka v prosti prodaji je 1080 SIT Tekoči račun: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 50101-678-49040 Sofinancirajo: Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani Znanstveno-raziskovalni center SAZU Tisk: Tiskarna Slovenija, Ljubljana, julij 1995 Naklada: 2000 izvodov Po mnenju Ministrstva za kulturo Republike Slovenije št. 415- 348/92 mb. z dne 24. 4. 1992 šteje Zgodo vinski časopis za proizvod, od katerega se plačuje 5-odstotni prometni davek. -

Prispevki Za Novejšo Zgodovino
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO PRISPEVKI ZA NOVEJŠO ZGODOVINO Letnik XXXIX Ljubljana 1999 Številka 1 Contributions to the Contemporary History Contributions a l'histoire contemporaine Beiträge zur Zeitgeschichte UDC 949.172"18/19" (05) UDK ISSN 0353-0329 Uredniški odbor: dr. Zdenko Čepič (glavni urednik), dr. Jasna Fischer (odgovorna urednica) dr. Damijan Guštin (pomočnik glavnega urednika), mag. Boris Mlakar, dr. Jože Pirjevec, dr. Janko Prunk, dr. Franc Rozman Redakcija zaključena 4. oktobra 1999 Za znanstveno vsebino prispevkov in točnost podatkov odgovarjajo avtorji. Lektorica: Marjetka Kastelic Naslovnica: Janez Suhadolc, dipl. ing. arh. Prevodi: Andrej Turk - angleščina Bibliografska obdelava: Nataša Kandus Izdaja: Inštitut za novejšo zgodovino SI - 1000 Ljubljana, Kongresni trg 1, Republika Slovenija tel. 200 31 20, fax 200 31 60, e-mail (glavni urednik) [email protected] Založil: Inštitut za novejšo zgodovino s sofinanciranjem Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike Slovenije Računalniški prelom: MEDIT d.o.o., Notranje Gorice Tisk: Grafika - M s.p. Cena: 2000 SIT Zamenjave (Exchange, Austauch): Inštitut za novejšo zgodovino SI - 1000 Ljubljana, Kongresni trg 1, Republika Slovenija Prispevki za novejšo zgodovino so indeksirani v bazi Historical Abstract Kazalo CONTENTS - TABLE DES MATIERES - INHALT Beseda uredništva ........................................................................................ 5 Zdenko Čepič Kaj smo delali, kaj naredili? (Oris dejavnosti Inštituta za novejšo zgodovino ob 40 - letnici -

La Memoria Trieste, 1918-1919, Pavia Hocevar Ricorda Nell'opera
M. Kacin Wohinz, Appunti sui rapporti italo-sloveni, Quaderni, vol. XVI, 2004, p. 79- 107 79 APPUNTI SUI RAPPORTI ITALO-SLOVENI TRATTATI DALLA COMMISSIONE STORICO-CULTURALE MISTA1 MILICA KACIN WOHINZ CDU 327(450:497.4)"19" Lubiana Intervento RIASSUNTO: In questo contributo l'autrice tra tta alcuni aspetti del lungo percorso che nel luglio del 2000 ha portato la commissione di storici italo-sloveni, di cui è stata una delle componenti, a siglare trenta pagine di documento in entra mbe le lingue. Il documento in questione rappresenta la sintesi accettata all'unanimità dei rapporti tra le due nazioni dall'ini zio del risorgimento nazionale sloveno intorno al 1880 fino alla delimitazione dei confini dopo il Memorandum di Londra nel 1956. Da questo punto di vista, il risultato de/ lavoro costituì il primo passo all'approfondimento di ricerche comuni su problemi comuni, soprattutto nella fa se successiva alla seconda guerra mondiale, periodo che scientificamente è ancora poco documentato. La memoria Trieste, 1918-1919, Pavia Hocevar ricorda nell'opera Pot se vije: "La torpediniera ritornò da Venezia seguita da una nave militare italiana! La deputazione la salutò [ ...] oltre a una enorme massa di popolazione italiana. Noi perdemmo il fiato, delusi ci guardammo e in silenzio ci separammo. Eppure non eravamo disperati: [ ...] esiste ancora Wilson, gli alleati, e avremo la Jugoslavia col proprio esercito [ ...] Un pomeriggio dell'agosto 1919 ci eravamo attardati in biblioteca e parlavamo del suo stato e dell'occupatore infuriato. Ad un tratto ci scuotono degli spari contro la finestra. Frantumi di vetro volano per la stanza, intorno all'edi ficio un chiasso improvviso, urla, spari! [ ...] Con i tavoli e con le sedie in un momento barrichiamo la porta - i militari stanno già battendo coi fucili e con grida selvagge pretendono che apriamo. -

Nekaj Predlogov Za Branje S Področja Pohodništva, Gora in Alpinizma. Za Sodelovanje V Akciji Lahko Izberete Tudi Druge Knjige
21. 9.–11. 12. 2018 Nekaj predlogov za branje s področja pohodništva, gora in alpinizma. Za sodelovanje v akciji lahko izberete tudi druge knjige. Tolmin, 21. 9. 2018 ZA OTROKE IN MLADINO BAVDAŽ, Marija (avtor, ilustrator). Poleti. Na planincah sončece sije. Ljubljana: DZS, 1994. 43 str., ilustr. Zbirka Pojdi, poišči, prisluhni ---. ISBN 86-341-0667-5, ISBN 86-341-1333-7. [COBISS.SI-ID 40333312] BUTTERFIELD, Moira. Sem krilat in divji, napadam z višine in sem močan. Živim v gorah. Kdo sem?. Tržič: Učila, 1998. 29 str., ilustr. Zbirka Kdo sem?. ISBN 961-233-185-5. [COBISS.SI-ID 76096512] GOLOB, Tadej. Zlati zob. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 314 str., ilustr. Knjižnica Sinjega galeba, 331. ISBN 978-961-01-1566-3. [COBISS.SI-ID 257986304] HAAS, Miha, AMBROŽ, Miha. Kdo kliče škrata Črnobrada? : vodnik po slovenskih učnih poteh. 1. izd. Ljubljana: Danu, 2010. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-269-352-7. [COBISS.SI-ID 253416960] KAJZER, Janez. Štirje srčni možje : dolgi vrsti raziskovalcev planinstva se je iz mraka davnih let posrečilo izluščiti glavne sestavine zgodbe o štirih srčnih možeh. V Ljubljani: Borec, 1980. [16] str., barvne ilustr. Kurirčkova zgodovinska slikanica. [COBISS.SI-ID 19472385] KOKALJ, Tatjana. Luža v čevlju. 1. izd. Dob: Brin, 2017. 230 str., ilustr. ISBN 978-961-94126-2-6. [COBISS.SI-ID 289846016] LEKŠE, Jože. Pujsek Koči : zgodba izpod koroških planin. Velenje: Knjižnica; Ravne na Koroškem: ZIP center, 2012. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-92287-6-0. [COBISS.SI-ID 263629056] LOOK, Lenore. Alvin Ho. Alergičen na taborjenje, pohodništvo in druge naravne katastrofe. -

Primorski Slovenski Biografski Leksikon
l*t PRIMORSKI SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON 19. SNOPI6 DODATEK B -L Uredil Martin Jevnikar GORICA 1993 GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA SODELAVCI 19. SNOPI<A IN NJIHOVE ZNA<KE (Imena umrlih sodelavcev so zaznamovana s križcem) ab dr. Aleš Brecelj, prof., Devin A. Bened. Anka Benedeti=, prof. zgod., Arhiv, muzej, služba U v Lj Ad= dr. France Adami=, univ. prof. v p , Lj. A. Pr. dr. Anton Prijatelj, dr. medic z.nanosti, Zdr. dom. Nova Gor. Bevk Samo Bevk, ravn. Mest muzeja v Idriji B. Jakov. mag. Božo Jakovljevi7, zgod. in ured., Buzet B. Lu. dr. Lucana Budal, prof., Gor. B. Lušina Branko Lušina, trgov, poslov., Nova Gor. B. Mar. dr. Branko Maruši=, višji znanst. sodcl. ZRC SAZU, Lj.-Solkan B-n Pavel Budin, sodnik in kult. delavec v Novi Gor. Breda Pahor Breda Pahor, =asnikarka in kult. delavka, Trst B.S. inž. Boris Sancin, ravn. RAITrstA v p., Trst (+) B.Z. Božo Zuanella, župnik v Tr=munu Cevc dr. Emilijan Cevc, akademik, znanst. svetnik ZRC SAZU, Lj <ellgoj Vojko Celigoj, prof. in kult. del., Ilir. Bistrica <eš= dr. Marija <eš=ut, prof., Gor. Dar. Košuta Darinka Košuta, por. Prin=i=, prof. Darovec Darko Darovec, prof. zgod., Pokraj, arhiv, Koper Dolenc Janez Dolenc, prof. v p., Tolmin Dr. Baje dr. Drago Baje, univ. prof. v Mariboru, Trst-Mrb E.D. dr. Emil Devetak, prof. v Gor. Er. Dol. dr Ervin Dolenc, dr. zgod. ved, asistent, Inštit. za novejšo zgod., Lj. FilSed Filip Sedmak, dipl. inž. v p., Nova Gor. Gultin Damijan Guštin, mag. zgod., asistent, Inštit. za novej. zgod., Lj. Har. dr. -

Severnojadranskimi Rasami« V Iredentističnem in Fašističnem Diskurzu
ACTA HISTRIAE ACTA ACTA HISTRIAE 24, 2016, 4 24, 2016, 4 ISSN 1318-0185 Cena: 11,00 EUR UDK/UDC 94(05) ACTA HISTRIAE 24, 2016, 4, pp. 689-992 ISSN 1318-0185 UDK/UDC 94(05) ISSN 1318-0185 Zgodovinsko društvo za južno Primorsko - Koper Società storica del Litorale - Capodistria ACTA HISTRIAE 24, 2016, 4 KOPER 2016 ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 4 ISSN 1318-0185 UDK/UDC 94(05) Letnik 24, leto 2016, številka 4 Odgovorni urednik/ Direttore responsabile/ Darko Darovec Editor in Chief: Uredniški odbor/ Gorazd Bajc, Furio Bianco (IT), Flavij Bonin, Dragica Čeč, Lovorka Comitato di redazione/ Čoralić (HR), Darko Darovec, Marco Fincardi (IT), Darko Friš, Aleksej Board of Editors: Kalc, Borut Klabjan, John Martin (USA), Robert Matijašić (HR), Darja Mihelič, Edward Muir (USA), Egon Pelikan, Luciano Pezzolo (IT), Jože Pirjevec, Claudio Povolo (IT), Vida Rožac Darovec, Andrej Studen, Marta Verginella, Salvator Žitko Urednik/Redattore/ Editor: Gorazd Bajc Prevodi/Traduzioni/ Translations: Maja Smotlak, Petra Berlot Kužner Lektorji/Supervisione/ Language Editor: Vida Rožac Darovec Stavek/Composizione/ Typesetting: Grafis trade d.o.o. Izdajatelj/Editore/ Published by: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko / Società storica del Litorale© Sedež/Sede/Address: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, SI-6000 Koper-Capodistria, Kreljeva 3 / Via Krelj 3, tel.: +386 5 6273-296; fax: +386 5 6273-296; e-mail: [email protected]; www.zdjp.si Tisk/Stampa/Print: Grafis trade d.o.o. Naklada/Tiratura/Copies: 300 izvodov/copie/copies Finančna podpora/ Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije / Slovenian Supporto finanziario/ Research Agency Financially supported by: Slika na naslovnici/ Foto di copertina/ Picture on the cover: Izrez stenske poslikave Toneta Kralja v Pnevmi, cerkev sv. -

Tarvisio T I a I L Sci Alpino Sci Nordico Sleddog Pista Ciclabile G
M. Fleons 2507 KÖTSCHACH - LIENZ KÖTSCHACH - LIENZ LIENZ Gail M. Peralba 2694 Hermagor 602 M. Volaia 2470 St.Stefan M. Cogliàns Tröpolach an der Gail P.so di Monte A U S T R I A Pierabech 1955 Gail VAL PUSTERIA- BOLZANO 2780 Croce Carnico Rif. Lambertenghi 1360 Romanin 2217 Hochwipfel Forni Avoltri Rif. Marinelli Creta di Timau Collina 2186 Avoltri 888 2122 2015 G Vorderberg Collinetta M.Lodin Gail Timau Frassenetto Sonnleitn a Piani di Luzza 555 Sigilletto Nötsch i Feistritz im Gailtal Sappada Tors an der Gail F COME E DOVE Autimis M.Crostis Muse . P l i attrattive grandi con territorio piccolo Un a 2251 M.Paularo Creta di Aip Gartnerkofel M.Poludnig ve Cimon di Crasulina Cima T 2043 2195 1999 . 2279 Sappada D Givigliana Tarvisiano del comprensorio al guida e turistica Mappa Campolongo eg 2251 Cleulis M.Osternig t Gailtal an Laipacco n C o 1552 e M.Zermula 2050 b Stalis a z t P.so del Watschiger A. VILLACH - KLAGENFURT C Naßfeld H. r i TARVISIANO l 2143 1530 G a Hohenthurn i Piani di Vâs Ludaria Cason di Lanza a a z 685 Vuezzis T t G a P.so di Pramollo Sella Nevea, M. Cimon 1628 . i S. Stefano M.Siera C Naßfeldpaß t r Arnoldstein Rif. Chiampizulon 800 h F e i s l di Cadore i 578 2443 2442 n a n 2239 r 1832 s Gracco Valdaier ó M.Cocco Rigolato M. Cavallo 11 M. Corona a V 1941 Altipiano a Magnanins a 2462 Ligosullo di Pontebba l 949 V l a Arnoldstein Pöckau Tausia o z V Naunina l a n Thörl Creta Forata Costa t z o l i Valpicetto û l e a B o v e Zenodis M.Salinchiet 1736 Creton di l . -

Ars & Humanitas
ARS & HUMANITAS Revija za umetnost in humanistiko / Journal of Arts and Humanities revija za umetnost in humanistiko XIII/1 V/1-2 Spomin, II Memory, II 2019 2010 AH_XIII1_notranjost_FINAL.indd 1 26.8.2019 11:15:31 Ars 5.indb 1 20.12.2010 19:01:22 ARS & HUMANITAS Revija za umetnost in humanistiko / Journal of Arts and Humanities Založila / Published by Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani / Ljubljana University Press, Faculty of Arts Za založbo / For the Publisher Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete / the Dean of the Faculty of Arts Glavni urednici / Editors-in-Chief Vanesa Matajc, Špela Virant Tematski sklop sta uredili / Thematic section was edited by Katja Mahnič, Nataša Golob Uredniški odbor / Editorial Board Milica Antić Gaber, Tine Germ, Nataša Golob, Branka Kalenić Ramšak, Lev Kreft, Katja Mahnič, Marko Marinčič, Jasmina Markič, Florence Gaçoin Marks, Tatjana Marvin, Janez Mlinar, Borut Ošlaj, Blaž Podlesnik, Boštjan Rogelj, Irena Samide, Peter Simonič, Maja Šabec, Matej Šekli, Nataša Vampelj Suhadolnik, Alojzija Zupan Sosič Mednarodni svetovalni odbor / International Advisory Board Jochen Bonz (Bremen), Parul Dave-Mukherji (New Delhi), Thomas Fillitz (Dunaj), Karl Galinsky (Univ. of Texas), Hermann Korte (Siegen), Douglas Lewis (Washington), Helmut Loos (Leipzig), Bożena Tokarz (Katowice), Johannes Grabmayer (Celovec), Mike Verloo (Nijmegen) Urednica recenzij / Reviews Editor Špela Virant Oblikovanje in postavitev / Graphic design and type setting Jana Kuharič, Lavoslava Benčić Lektoriranje / Language Editing Rok Janežič, Paul Steed Tisk / Printed by Birografika Bori d.o.o. Naklada / Number of copies printed 150 Cena / Price 12 EUR Naslov uredništva / Address Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2 SI–1000 Ljubljana Tel. -

Časopis December 2014
24. december 2014 1001- solkanski ~asopis 1 24. december 2014 solkanski časopis Leto XXI, številka 83 Iz vsebine Drage Solkanke in Solkanci! December velja za najlepši mesec v letu, ko pisana umetna KS Solkan svetloba preganja temo, ko se poslavljamo od starega in v sebi Novi se je slikal, stari je podal poročilo nosimo upanje, ki nam ga podarja novo leto. Smo na pragu o opravljenem delu. Zraven še o volilnih sprememb za katere vemo, da morajo priti, sprememb, ki nam izbirah Solkancev. bodo vrnile sodelovanje, poštenje, zaupanje, tovariško pomoč Na straneh 2 - 3 in višji nivo zavesti. To je obdobje, ko si podarimo čas in pozornost, v današnjem Fotozgodba hitrem tempu življenja dragoceno darilo. Je čas poglabljanja Nov član uredniškega odbora Jure vase in tihega obračuna z življenjem v preteklem letu. Je tudi čas Batagelj je zadolžen za pisanje zgodb daril in veselja, je čas dobrote in zavesti o minljivosti. s fotoaparatom. Tokrat jo je pisal na Člani sveta KS Solkan, tega tako starosvetnega kraja, se bomo desnem bregu Soče, kjer nastaja trudili po svojih najboljših močeh, da bomo imeli posluh za kolesarska pot Solkan-Plave. potrebe kraja, delali v dobro vseh krajanov in krajank v skladu Na straneh 11 s svojimi pooblastili in možnostmi. Božič, praznik rojstva in družine, naj vam prinese notranji mir, Intervju ljubezen do sebe in drugih ter prijateljstvo. Ne ravno vsega, toda marsikaj tega, Dan samostojnosti in enotnosti Slovenije, naše edine domovine kar je dobro vedeti o kruhu, tudi res ve. nad katero smo zaradi sprevrženih dejanj tistih, ki bi nam Naš sogovornik je Karel Arenšek, ki nas morali biti za zgled, razočarani in tudi jezni, je vendar praznik, bo mimogrede naučil predeleti domačo ki bi moral biti svetel in ponosen. -

Trojka S Filozofske
Tomo Virk TROJKA S FILOZOFSKE Spisi o Vebru, Bartolu in Jugu Ljubljana 2020 Trojka_s_filozofske_FINAL.indd 1 17.2.2017 11:33:09 Trojka s filozofske: spisi o Vebru, Bartolu in Jugu Zbirka: Historia facultatis Uredniški odbor zbirke: Tine Germ, Janica Kalin, Ljubica Marjanovič Umek, Gregor Pompe, Jure Preglau, Matevž Rudolf, Tone Smolej Odgovorni urednik: Tine Germ Glavni urednik: Tone Smolej Avtor: Tomo Virk Recenzenta: Matevž Kos, Vid Snoj Tehnično urejanje, oblikovanje in prelom: Jure Preglau Fotografija stavbe Univerze v Ljubljani na naslovnici: razglednica iz zbirke Alojza Cindriča Fotografije Vebra, Bartola in Juga na naslovnici: iz arhiva NUK Izdala in založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Za založbo: Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Ljubljana, 2020 Prva e-izdaja Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Raziskovalni program št. P6-0239 (A) je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno de- javnost Republike Slovenije iz državnega proračuna. To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna licenca. / This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Publikacija je v digitalni obliki prosto dostopna na https://e-knjige.ff.uni-lj.si/ DOI: 10.4312/9789610603207 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI-ID=304945152 ISBN 978-961-06-0320-7 (pdf) Trojka_s_filozofske_FINAL.indd 2 17.2.2017 11:33:09 Kazalo 1 Uvodno pojasnilo . 7 2 Trojka s Filozofske (biografska skica) . 11 3 Tipologija humanističnih diskurzov v literarni vedi in vprašanje človekove človeškosti. 19 4 Scheler, Jug in etika resentimenta . -

Azienda Faunistico Venatoria “ Picco Di Mezzodi' “ Fusine in Valromana
Direzione Centrale Risorse Rurali Agroalimentari e Forestali Servizio Gestione Forestale e Produzione Legnosa AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA “ PICCO DI MEZZODI’ “ FUSINE IN VALROMANA CHI SIAMO E DOVE SIAMO • L’Azienda Faunistico Venatoria “Picco di Mezzodì”, dal 2007 è di proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è affidata al Servizio Gestione Forestale e Produzione Legnosa, che la gestisce tramite un Legale Rappresentante, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale per la gestione delle proprietà silvo-pastorali (D.G.R. 1032/2010) • Il territorio dell’ Azienda è situato nell’ alta Valcanale, in un ambiente integro, costituito nella quasi totalità da spazi naturali permanenti. • L’Azienda si estende per circa 650/ha. dalla Conca di Fusine, in Valromana, partendo da una quota di circa 900/m. s.l.m. dell’ Alpe del Lago Superiore, da nord lambisce il Mangarth, la Forcella di Ratece e la Valle della Lavina, ingloba parte del Rio Nero, il Colrotondo, sale oltre i 2.000/m. s.l.m. del Picco di Mezzodì che le da il nome, per proseguire a sud verso Cime Verdi, l’Alpe del Moritsch ed il Rio Bianco sin al confine di prossimità di Cave del Predil. I CONFINI E LA STORIA * L’Azienda si colloca all’ estremo nord-est della regione Friuli Venezia Giulia, confina a est con la Slovenia ed a nord è a meno di 10 km. dal confine con l’Austria. Raggiungerla è facile, seguendo l’Autostrada Alpe Adria (A23) uscire a Tarvisio, attraversare il centro in direzione Fusine e Cave del Predil, indi salire ai Laghi di Fusine.