Studi Germanici
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

(1) Abel, Hans Karl, Briefe Eines Elsässischen Bauer
296 Anhang 1: Primärliteraturliste (inklusive sämtlicher bearbeiteter Titel) (1) Abel, Hans Karl, Briefe eines elsässischen Bauernburschen aus dem Weltkrieg an einen Freund 1914-1918, Stuttgart/Berlin 1922.1 (2) Adler, Bruno, Der Schuß in den Weltfrieden. Die Wahrheit über Serajewo, Stuttgart: Dieck 1931. (3) Aellen, Hermann, Hauptmann Heizmann. Tagebuch eines Schweizers, Graz: Schweizer Heimat 1925. (4) Ahrends, Otto, An der Somme1916. Kriegs-Tagebuch von Otto Ahrends, Lt. Gefallen an der Somme 26. Nov. 1916., Berlin 1919. (erstmals 1916) (5) Ahrends, Otto, Mit dem Regiment Hamburg in Frankreich, München 1929. (6) Alberti, Rüdiger, Gott im Krieg. Erlebnisse an der Westfront. Berlin: Acker-Verlag 1930. (7) Alverdes, Paul, Die Pfeiferstube, Frankfurt am Main: Rütten & Loening Verlag 1929. (8) Alverdes, Paul, Reinhold oder die Verwandelten, München: G. Müller 1932. (9) Andreev, Leonid [Nikolaevič], Leonid Andrejew. Ein Nachtgespräch, Hrsg. v. Davis Erdtracht, Wien / Berlin / New York: Renaissance [1922]. (10) Arndt, Richard, Mit 15 Jahren an die Front. Als kriegsfreiwilliger Jäger quer durch Frankreich, die Karpathen und Italien, Leipzig: Koehler & Amelang 1930. (11) Arnim, Hans Dietlof von, Dreieinhalb Jahre in Frankreich als Neffe des Kaisers. Ge- fangenen-Erinnerungen, Berlin 1920. (12) Arnou, Z., Kämpfer im Dunkel, Leipzig: Goldmann 1929. (13) Arz [v. Straußenberg, Artur], Zur Geschichte des großen Krieges 1914 – 1918. Auf- zeichnungen, Wien / Leipzig / München: Rikola Verlag 1924. (14) Aschauer, Auf Schicksals Wegen gen Osten, Münster i. W.: Heliosverlag 1930. (15) Baden, Maximilian Prinz von: Erinnerungen und Dokumente, Berlin / Leipzig 1927. (16) Balla, Erich, „Landsknechte wurden wir ...“ Abenteuer aus dem Baltikum, Berlin: Tradition 1932. (17) Bartels, Albert, Auf eigene Faust. Erlebnisse vor und während des Weltkrieges in Ma- rokko, Leipzig 1925. -

Band 20 Als PDF in Druckversion
Georg Britting Georg Britting Sämtliche Werke Herausgegeben von Ingeborg Schuldt-Britting Band 20 Georg-Britting-Stiftung Georg Britting Briefe an Georg Jung 1943 bis 1963 Georg-Britting-Stiftung Georg Jung Editionsnotiz Neuauflage für die Eingliederung in diese Gesamtaus- gabe des 2005 als Einzelband erschienenen Briefban- des mit Korrekturen und Ergänzungen.. Inhalt und Bestand der Briefe blieben unverändert. Inhaltsverzeichnis Kapitel Seite Einleitung 9 Begegnung in Seesen 11 Skizze meines Lebens. Georg Jung 18 Briefe 19 Brief von Ingeborg Britting 321 Briefe von Georg Jung 324 Anhang 335 Erinnerungen an Georg Jung 337 Antike Vermaße. Typoscript. 345 Septembersonett von der gelben Wespe 348 Siglen 351 Werk-Register (alphabetisch sortiert) 353 Namensverzeichnis 357 Anmerkungen 365 7 Einleitung Nachdem in den Jahren 1987-1996 der List Verlag (in der Nachfolge des Süddeutschen Verlags) von Georg Britting eine fünfbändige kommentierte Werkausgabe in sechs Bänden und einen zusätzlichen Almanach heraus- gebracht hatte, folgte im Jahr 2002 die Dokumentation: »Georg Britting als Theaterkritiker in Regensburg« 1912–1914 u.1918–1921. Hg. Ingeborg Schuldt-Britting und Michael Herrschel. Im Jahr 2004 schloß sich ein erster Briefband an: »Aus goldenem Becher.« Briefe von Georg Britting an Alex Wetzlar 1939 und 1945 bis 1957. Hg. Ingeborg Schuldt-Britting. Beide Dokumentationen erschienen im Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M. In: Regensburger Beiträge. Zur deutschen Sprach-und Literaturwissen- schaft, Reihe A / Quellen, Nr.12 und.13, herausgegeben von Bernhard Gajek. Mit den hier ungekürzt vorgelegten Briefen an seinen Freund Georg Jung aus den Jahren 1942–1963 ist das dichterische Werk von Georg Britting abgeschlossen. Die Originale liegen in der Bayerischen Staatsbibliothek. Bei den Abschriften wurden die unterschiedlichen brittingschen Schreib- weisen beibehalten. -

Academy, Building. See Bauakademie Aegyptens Stelle in Der
Cambridge University Press 0521836484 - Becoming Historical: Cultural Reformation and Public Memory in Early Nineteenth- Century Berlin John Edward Toews Index More information Index Academy, Building. See Bauakademie Apostolic Church Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte, 101 See also church; ecclesiastical reform; aesthetic mode of existence, 425–429. See religion also reflective ego according to Frederick William IV, Alexandra, Empress of Russia, 193–196 60–64 Allgemeine Bauschule. See Bauakademie role of Bishop in, 62 altar of Liberation Cathedral, 128–129 role of state in, 61–62 Altenstein, Karl von Stein zum, 20 a priori empiricism, 7 Altes Museum, 140 archaeology, linguistic. See linguistic See also Liberation Cathedral; archaeology neo-classical architecture architecture, 117–204 and Bauakadamie, 173 See also commercial architecture; exterior staircase of, 145 ecclesiastical architecture; Gothic facade, 142–145 architecture; Lehrbuch; neo-classical galleries, 147–148 architecture; Schinkel, Karl Friedrich; Greece as paradigm of historical culture, Werke der hoeheren Baukunst 150 , 152 and The Basilicae ofChristian Rome , 101 historical narrative of, 148 ecclesiastical, 178–196 and history of formation of culture out emphasis on early Christian basilica, of nature, 148–150 56–57, 106–107 as instrument to construct ethical and English capitalism, 162–163 community, 150 –151 focus on cultural guardians, 188–196 rotunda, 145–147 and fusion of pagan and Christian spatial relations and visual ornamentation traditions, 196 in, 151 –154 as high art, 118–119 tension between secular and sacred historical and poetic aspects of, culture, 160 187–188 transformation of labor force into ethical nature and human culture in, 176–178 community, 159 –160 plans for Berlin Cathedral, 56–57 as work of art, 148 Sammlung Architektonischer Entwuerfe, 168 Ancillon, J. -

Gerhard Schumann - Biographie
Justus-Liebig-Universität-Gießen Gießener Elektronische Bibliothek Dissertation Gerhard Schumann - Biographie. Werk. Wirkung eines prominenten nationalsozialistischen Autors Simone Bautz Fachbereich 05 Sprache, Literatur, Kultur fachübergreifend Institut für Neuere deutsche Literatur / Institut für Neuere Geschichte Jahr: 2008 Prodekan: Herr Prof. Dr. Joybrato Mukherjee 1. Berichterstatter: Herr Prof. Dr. Gerhard Kurz 2. Berichterstatter: Herr Prof. Dr. Winfried Speitkamp Tag der Disputation: 20.11.2006 Inhaltsverzeichnis: 1. Einleitung 1.1 Vorwort 1 1.2 Zielsetzung der Arbeit 4 1.3 Methodik 7 1.4 Quellenlage 16 1.5 Forschungsbericht 18 2. Kindheit und Jugend 1911-1930 2.1 Elternhaus und Jugendbewegung 1911-1925 43 2.2 Die Internatsjahre in Schöntal und Urach 1926-1930 61 3. Karriere I. Studienjahre in Tübingen 1930-1934 - Dichtung und Hochschulpolitik 3.1 Tübingen am Vorabend des >>Dritten Reiches<< - Beitritt zur NSDAP, SA und zum Nationalsozialistischen Deutschen Stu- dentenbund 1930 77 3.2 Schumann als Dichter der jungen Mannschaft 95 3.3 Die Machtergreifung 1933 104 3.4 Die verhinderte Bücherverbrennung in Württemberg 122 3.5 Die SA-Führerschule-Rottenburg 3.5.1 Die Einrichtung der Schule 132 3.5.2 Arbeitsdienst und Wehrsport 138 3.5.3 Der Schadenweilerhof 143 3.6 Der so genannte Röhmputsch 145 4. Karriere II. Reichsdichtung und Kulturpolitik 1935-1939 4.1 Konsolidierung der Macht - Schwäbischer Dichterpreis 1935 152 4.2 Kulturpolitische Arbeit im Reichskultursenat 158 4.3 Nationaler Buchpreis 1936 162 4.4 Die 5. Berliner Dichterwoche - Woche des deutschen Buches 1936 168 4.5 Schumanns Tätigkeit in der Reichsschrifttumskammer 1937-1939 4.5.1 Die Ernennung und Aufgabenbereiche 174 4.5.2 Der Aufbau der Reichsschrifttumskammer 176 4.5.3 KdF - Gründung und Aufgabenbereiche 184 4.5.4 Die Gleichschaltung der Theater - Bamberger Dichterkreis - Gründung der E.T.A.-Hoffmann-Gesellschaft am 14. -

Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis Für Das
Institut für Germanistik - Teilfach Neuere deutsche Literatur K O M M E N T I E R T E S V O R L E S U N G S V E R Z E I C H N I S Wintersemester 2017/18 Stand: 20. November 2017 2 KVV NdL, WS 2017/18, Stand: 20.11.17 Institut für Germanistik – Teilfach Neuere deutsche Literatur Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis Wintersemester 2017/18 L e h r v e r a n s t a l t u n g e n 1. Vorlesungen S. 3 2. Seminare Ia S. 8 3. Seminare Ib S. 13 4. Seminare II S. 24 5. Masterseminare S. 37 6. Forschungskolloquien S. 43 7. BA-Abschlusskolloquien S. 45 8. MA-Abschlusskolloquium S. 45 9. Hinweis: ‚Agora‘, e-Plattform Hamburger Geisteswissenschaften S. 46 HINWEIS: Das Institut für Germanistik ist im September 2017 in das Ausweichquartier Überseering 35, 22297 Hamburg umgezogen. Das Geschäftszimmer des IfG befindet sich dort in Raum Ü35-08046 (8. Stock). 3 KVV NdL, WS 2017/18, Stand: 20.11.17 1. Vorlesungen LV-Nummer: 52-200 LV-Name: Ringvorlesung: Einführung in das Studium der Neueren deutschen Literatur [DSL/DE-E-NdL] [DSL-W] [SLM-WB] Koordination: Alena Lyons Zeit/Ort: 2st. Mi 16–18 Ü35–A (Raum 00002) ab 18.10.17 (Kernzeit) Die Vorlesung 52-200 führt in wichtige Probleme, Wissensbereiche und Verfahrensweisen der germanistischen Literaturwissenschaft im Teilfach Neuere deutsche Literatur ein. Sie eröffnet den thematischen Horizont, vor dem die konkreten Fragestellungen in den Seminaren und Tutorien abgehandelt werden. Diese dreifache Spiegelung des Stoffes schafft eine solide Grundlage für die kommenden Semester. -

2. Weltanschauung, Medien Und Kultur Bei Der
2. Weltanschauung, Medien und Kultur Bei der Erziehung und 'Heranbildung' des 'neuen Menschen' für eine neue, zugleich durch ihn gebildete 'neue Volksgemeinschaft' spielte die Implementierung von nationalsozialistischer Welt- anschauung die entscheidende Rolle. Die wichtigsten Bestandteile dieses gleichermaßen umfas- senden wie disparaten Kernbereichs des Nationalsozialismus sollten den Jugendlichen des Dritten Reiches über die spezifischen Formen der weltanschaulichen Schulung, über die HJ-kontrollierten Medien und über die im Zugriff des NS-Jugendverbandes befindlichen Kultursparten quasi-im- plantatorisch vermittelt und abrufbereit verfestigt werden. Die diesen Transformationssphären in unterschiedlichen Gewichtsanteilen innewohnenden und differenziert aufeinander abgestimmten Wirkungsmechanismen sind von spezialisierten Ämtern der Reichsjugendführung und deren teil- weise hochqualifizierten Mitarbeitern gesteuert worden. Als zentrale Kriterien bei der Installation von Weltanschaung im 'neuen Menschen' galten die Kategorien 'Vorbild' und 'Erleben'. So wa- ren geschulte Führer, die schon vorlebten, was verlangt wurde, ebenso wichtig wie die planvolle Gestaltung von Erlebnissen, die weit über unmittelbares Erleben hinausreichten und auch medial vermitteltes, mentalitätsprägendes und 'seelenformendes' Erfahren einschloß. 2.1 „Erziehung zum Nationalsozialismus". Die weltanschauliche Schulung der HJ „Millionen von Mädeln und Jungen sollen, es ist nicht einfacher zu sagen, zu Nationalsozialisten erzogen werden." 2.1.1 Die Schulungsarbeit -

Kollaborierende Intellektuelle in Weimar – Die ›Europäische Schriftsteller-Vereinigung‹ Als ›Anti-P.E.N.-Club‹
Frank-Rutger Hausmann Kollaborierende Intellektuelle in Weimar – Die ›Europäische Schriftsteller-Vereinigung‹ als ›Anti-P.E.N.-Club‹ In seinen Erinnerungen mit dem einfühlsamen Titel Ein Leben wird besichtigt. In der Welt der Eltern1 berichtet der Berliner Verleger Wolf Jobst Siedler, der seit 1938 die Mittelstufe der Hermann Lietz-Schule auf der Ettersburg bei Wei- mar besuchte, er habe 1941 an der Abschlussveranstaltung eines europäischen Dichterkon gresses im dortigen Nationaltheater teilgenommen. Er habe aller- dings vergessen, welche Kundgebungen im Einzelnen stattgefunden hätten, und die französischen, spanischen oder italienischen Namen hätten ihm damals ohne- hin nichts gesagt. Siedler ist einer der wenigen Zeitzeugen, die dieses Ereignis, dessen Einzelheiten scheinbar in Vergessenheit geraten sind, überhaupt erwäh- nen.2 Joseph Goebbels und seine Mitarbeiter hatten, wie so oft, bei der Planung ihrer ›Europäischen Schriftsteller-Vereinigung‹ (ESV) im Jahr 1941 Modelle ko- piert und miteinander verschmolzen, die in der geschmähten ›Systemzeit‹ der Weimarer Republik ersonnen worden waren, und sie für die Gleichschaltung des kulturellen Lebens instrumentalisiert: den seit 1929 auf Anregung des Deutschen Städtetages am 22. März, Goethes Todestag, stattfindenden ›Tag des deutschen Buchs‹, die seit 1932 auf der Wartburg abgehaltenen Dichtertreffen, wo dem Sieger eine silberne Rose verliehen wurde, die auf dem Gutshof des in Ungnade gefallenen, zunächst völkisch vereinnahmten Schriftstellers Hanns Grimm durch- geführten Lippoldsberger Dichtertage und, zu guter Letzt, die Treffen des inter- nationalen P.E.N.-Clubs (Poets-Playwrights, Essayists-Editors, Novelists). Dieses Verfahren hatte in den Augen des Propagandaministers den Vorzug, eine demo- kratischen Gepflogenheiten entsprechende Normalität vorzuspiegeln, die aber nur als täuschende Fassade für die gleichschalterischen und expansionistischen Ziele des Nationalsozialismus diente, vor allem gegenüber dem Ausland. -

Friedo Lampe: Idyllen Auf „Vulkanischem Grund“. Erzählen Im Stil Des Magischen Realismus Während Des Dritten Reichs
Friedo Lampe: Idyllen auf „vulkanischem Grund“. Erzählen im Stil des Magischen Realismus während des Dritten Reichs Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultäten der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg i. Br. vorgelegt von Annette Hoffmann aus Freiburg Erstgutachter: Prof. Dr. Günter Schnitzler Zweitgutachter: Prof. Dr. Carl Pietzcker Vorsitzender des Promotionsausschusses des Gemeinsamen Ausschusses der Philosophischen Fakultäten I-IV: Prof. Dr. Ulrich Rebstock Datum der Disputation: 7. Januar 2002 Inhalt Einleitung 1. Der Magische Realismus im ästhetischen und 13 historischen Kontext der zwanziger Jahre 1.1. Nachexpressionismus 13 1.1.1. Friedo Lampe, Krise. Briefe zweier Dichter 13 1.1.2. Ein neuer Naturalismus?? 16 1.1.3. Die Magie der Wirklichkeit 20 1.2. Begriffsbestimmung des Magischen Realismus 23 und seine inhaltliche Bestimmung 1.3. Rezeption 31 2. Friedo Lampe: ein exemplarischer Lebenslauf 36 im Dritten Reich 2.1. 1899-1930: Jugend und Studium 36 2.2. 1930-1945: Ausbildung und Berufsleben 40 2.2.1. Friedo Lampe als Volksbibliothekar in Stettin 40 2.2.2. Die Machtergreifung und die Gleichschaltung 41 der Volksbüchereien 2.2.3. Das Verbot von Am Rande der Nacht 50 2.2.4. Friedo Lampe beim Rowohltverlag 57 2.2.5. Die Situation von Autoren und Verlagen im 59 Nationalsozialismus 2.3. Ambivalente Lebenswirklichkeit im Dritten Reich: 65 Idylle auf „vulkanischem Grund“ 3. Überlegungen zur Gattung der Idylle 73 3.1. Die Idylle als biographisches Muster 73 3.2. Die Idylle zwischen Ideal und Wirklichkeit 74 3.3. Transformation der Idylle 84 4. Konfigurationen und Deformationen des 88 Idyllischen im Werk Friedo Lampes 4.1. -
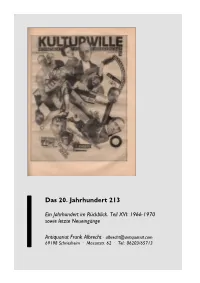
Das 20. Jahrhundert 213
Das 20. Jahrhundert 213 Ein Jahrhundert im Rückblick. Teil XVI: 1966-1970 sowie letzte Neueingänge Antiquariat Frank Albrecht · [email protected] 69198 Schriesheim · Mozartstr. 62 · Tel.: 06203/65713 Das 20. Jahrhundert 213 D Verlag und A Ein Jahrhundert im Rückblick S Antiquariat Teil XVI: 1966-1970 2 sowie letzte Neueingänge 0. Frank J A Albrecht H Inhalt R H 1966 .............................................................................. 1 69198 Schriesheim U 1967 ............................................................................ 12 Mozartstr. 62 1968 ............................................................................ 20 N 1969 ............................................................................ 27 Tel.: 06203/65713 D 1970 ............................................................................ 38 FAX: 06203/65311 E Letzte Neueingänge ..................................................... 47 Email: R Register ....................................................................... 50 [email protected] T USt.-IdNr.: DE 144 468 306 D Steuernr. : 47100/43458 A Die Abbildung auf dem Vorderdeckel zeigt S eine Fotomontage von Max Schwimmer für die Zeitschrift „Kulturwille“ 2 (Katalognummer 510). 0. J A H Spezialgebiete: R Autographen und H Widmungsexemplare U Belletristik in Erstausgaben N Illustrierte Bücher D Judaica Kinder- und Jugendbuch E Kulturgeschichte R Unser komplettes Angebot im Internet: Kunst T http://www.antiquariat.com Politik und Zeitgeschichte Russische Avantgarde Sekundärliteratur -
Das 20. Jahrhundert 275
Das 20. Jahrhundert 275 Lesefutter für den Sommer Teil 1 sowie letzte Neueingänge Antiquariat Frank Albrecht · [email protected] 69198 Schriesheim · Mozartstr. 62 · Tel.: 06203/65713 Das 20. Jahrhundert 275 D Verlag und A S Lesefutter für den Sommer Antiquariat 2 sowie letzte Neueingänge Frank 0. J A Albrecht H R H Inhalt 69198 Schriesheim U Mozartstr. 62 N Lesefutter ........................................................................ 1 Tel.: 06203/65713 D Letzte Neueingänge ...................................................... 40 FAX: 06203/65311 E Register ......................................................................... 44 Email: R [email protected] T USt.-IdNr.: DE 144 468 306 D Steuernr. : 47100/43458 A S Die Abbildung auf dem Vorderdeckel zeigt eine Einbandillustration von 2 Walter Trier (Katalognr. 109). 0. J A H Spezialgebiete: R Autographen und H Widmungsexemplare U Belletristik in Erstausgaben N Illustrierte Bücher D Judaica E Kinder- und Jugendbuch R Kulturgeschichte Unser komplettes Angebot im Internet: Kunst T Politik und Zeitgeschichte http://www.antiquariat.com Russische Avantgarde D Sekundärliteratur A und Bibliographien S Geschäftsbedingungen Gegründet 1985 2 0. Alle angebotenen Bücher sind grundsätzlich vollständig und, wenn nicht an- J ders angegeben, in gutem Erhaltungszustand. Die Preise verstehen sich in Euro Mitglied im (€) inkl. Mehrwertsteuer. Das Angebot ist freibleibend; Lieferzwang besteht P.E.N.International A H nicht. Die Lieferungen sind zahlbar sofort nach Erhalt. Der Versand erfolgt auf und im Verband Kosten des Bestellers. Lieferungen können gegen Vorauszahlung erfolgen. Es Deutscher Antiquare R besteht Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB bis zur vollständigen Bezah- H lung. Dem Käufer steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht des Vertrages nach § U 361a BGB zu, das bei der Lieferung von Waren nicht vor dem Tag ihres Ein- Sparkasse Heidelberg N gangs beim Empfänger beginnt und ab dann 14 Tage dauert. -
In Partial Fulfillnent April 1966
MORÏTZ JAHN TN SETNEN PROSAWERKEN VERSTICH EINER INTERPRETATION A Thesis Presented. to the Faculty of Graduate Studies ancl Researeh The University of illanitoba In Partial Fulfillnent of the Requirements for the Degree Master of Arts by Rosmarln Peters April 1966 Á.CIo{O!/IEDGI'MNTS f l,rould- Iike first of all to express my gratitud_e to Dr. Moritz Jahn for his time and- co- operation in d-iscussing with me his rvorks in connection with my thesis. Every conversation with him was d-eeply rewarding and most enlighteni-ng in terms of the thesis t and spiritually enriching from a personal point of view. I would. like to thank Dr. Jahn also for putting at rny disposal a personal notebook containing comments regard-ing his work. I received- permission from hirn to copy several tapes as v¡ell, oo which are a rad-io broad-cast about Jahn (tfre text spoken by Dieter Bel1mann) , a d-iscourse on lov¡ German humour ( spoken by Dr. Jahn), and_ read_ings by the poet out of his works. ivly sineere thanks go out also to Dr. Heinrich i¡lesehe, Professor for Trow German at the university of Göttingen and- d.irector of the Nied.ersäehsisches trrjörterbuch. Through him and- his family I first mad'e the acquaintance of Moritz Jahn and- his vtorks ' Professor l¡lesche put at my d-isposal rnuch valuable material on the subject of I-,ow German language and. literature, as roell as offering me his invaluable ad-vice and. assistance. sachse f would- like to thank also Herr Gü::ther ' Dr. -
Autographen-Auktion 5
AUTOGRAPHEN-AUKTION 5. April 2008 Los 274 Winston S. CHURCHILL Axel Schmolt Autographen-Auktionen 47807 Krefeld Steinrath 10 Telefon 02151-93 10 90 Telefax 02151-93 10 9 99 E-Mail: [email protected] AUTOGRAPHEN-AUKTION Inhaltsverzeichnis Los-Nr. Geschichte - Deutsche Geschichte allgemein (ohne Preußen) 1 - 7 - Preußen 8 - 32 - I. Weltkrieg 33 - 44 - Weimarer Republik 45 - 64 - Deutschland 1933-1945 65 - 165 - Deutsche Geschichte seit 1945 166 - 215 - Geschichte des Auslands bis 1945 216 - 254 - Geschichte des Auslands seit 1945 255 - 343 - Kirche-Religion 344 - 353 Literatur 354 - 496 Musik 497 - 754 - Oper-Operette (Sänger/- innen) 755 - 965 Bühne - Film - Tanz 966 - 1132 Bildende Kunst 1133 - 1269 Wissenschaft 1270 - 1341 - Forschungsreisende und Geographen 1342 - 1355 Luftfahrt 1356 - 1362 Weltraumfahrt 1363 - 1372 Sport 1373 - 1411 Widmungsexemplare - Signierte Bücher 1412 - 1499 Sammlungen - Konvolute 1500 - 1514 Autographen – Auktion am Samstag, den 5. April 2008 47807 Krefeld, Steinrath 10 Die Versteigerung beginnt um 11.00 Uhr. Pausen nach den Gebieten Literatur und Bühne-Film-Tanz Im Auktionssaal sind wir zu erreichen: Telefon (02151) 93 10 90 und Fax (02151) 93 10 999 Während der Auktion findet im Auktionssaal keine Besichtigung statt. Die Besichtigung in unseren Geschäftsräumen kann zu den nachfolgenden Terminen wahrgenommen werden oder nach vorheriger Vereinbarung. 29.3.2008 (Samstag) von 11.00 bis 16.00 Uhr 31.3.2008 bis 4.4.2008 von 11.00 bis 17.00 Uhr Bei Überweisung der Katalogschutzgebühr von EUR 10,- senden wir Ihnen gerne die Ergebnisliste der Auktion zu. Autographen - Auktionen Axel Schmolt Steinrath 10, 47807 Krefeld Tel. 02151 – 93 10 90 / Fax 02151 – 93 10 999 Internet: http://www.schmolt.de Wichtiger Hinweis: Mit der Abgabe der Gebote für die Autographen, Dokumente und Bildpostkarten aus der NS-Zeit verpflich- tet sich der Bieter dazu, diese Ware lediglich für historisch-wissenschaftliche Sammelzwecke zu erwerben und in keiner Weise propagandistisch im Sinne des § 86 StGB zu benutzen.