Interventi Del Presidente Della Repubblica Sergio Mattarella
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Italy's Atlanticism Between Foreign and Internal
UNISCI Discussion Papers, Nº 25 (January / Enero 2011) ISSN 1696-2206 ITALY’S ATLANTICISM BETWEEN FOREIGN AND INTERNAL POLITICS Massimo de Leonardis 1 Catholic University of the Sacred Heart Abstract: In spite of being a defeated country in the Second World War, Italy was a founding member of the Atlantic Alliance, because the USA highly valued her strategic importance and wished to assure her political stability. After 1955, Italy tried to advocate the Alliance’s role in the Near East and in Mediterranean Africa. The Suez crisis offered Italy the opportunity to forge closer ties with Washington at the same time appearing progressive and friendly to the Arabs in the Mediterranean, where she tried to be a protagonist vis a vis the so called neo- Atlanticism. This link with Washington was also instrumental to neutralize General De Gaulle’s ambitions of an Anglo-French-American directorate. The main issues of Italy’s Atlantic policy in the first years of “centre-left” coalitions, between 1962 and 1968, were the removal of the Jupiter missiles from Italy as a result of the Cuban missile crisis, French policy towards NATO and the EEC, Multilateral [nuclear] Force [MLF] and the revision of the Alliance’ strategy from “massive retaliation” to “flexible response”. On all these issues the Italian government was consonant with the United States. After the period of the late Sixties and Seventies when political instability, terrorism and high inflation undermined the Italian role in international relations, the decision in 1979 to accept the Euromissiles was a landmark in the history of Italian participation to NATO. -

GLOBAL HYBRID PUBLIC-PRIVATE BODIES: the WORLD ANTI-DOPING AGENCY (WADA) Lorenzo Casini *
Draft paper for the Global Administrative Law Conference on “Practical Legal Problems of International Organizations” Geneva, March 20-21, 2009 GLOBAL HYBRID PUBLIC-PRIVATE BODIES: THE WORLD ANTI-DOPING AGENCY (WADA) Lorenzo Casini * TABLE OF CONTENTS: Introduction 1. The Olympic regime and the relationship between sporting institutions and public authorities 2. The fight against doping: the World Anti-Doping Agency (WADA) 2.1. An equal public-private partnership: WADA’s structure 2.2. WADA’s public interest mission and its normative functions 2.3. Global hybrid public-private norms: the World Anti-Doping Code (WADC) 3. WADA and the anti-doping regime: a model for global administrative governance? 3.1. The institutional design of global private regimes: towards equal public- private partnerships? 3.2. Global private “law”: hybrid law-making processes and the interplay between global institutions and domestic authorities 3.3. Global harmonization of regulation and its discontents 3.4. The role of administrative law in private and hybrid public-private regimes: transparency, participation, due process, and review * Research Fellow, Institute for International Law and Justice (IILJ), New York University School of Law; Professor of Administrative Law, Faculty of Architecture “L. Quaroni”, University of Rome “La Sapienza”. The author warmly thanks Sabino Cassese, Sarah Dadush, Benedict Kingsbury, Euan MacDonald, Giulio Napolitano and Eran Shamir-Borer for their helpful comments. 3-12-2009 Introduction In 1960, at the opening ceremony of the Rome Olympics, when the unified German team entered the stadium for the Parade of Nations, the President of the International Olympic Committee (IOC) Avery Brundage, addressing himself to Giovanni Gronchi, then President of the Italian Republic, observed: “East German athletes and West German athletes in the same uniform marching behind the same leaders and the same flag”. -

The Eisenhower Administration and Italy's
IkeBrogi and Italy Ike and Italy: The Eisenhower Administration and Italy’s “Neo-Atlanticist” Agenda ✣ ecent scholarship has conªrmed that the major West European countriesR played a vital role in shaping the international system after World War II. Even the diplomacy of the much berated French Fourth Republic has now been redeemed.1 This article examines the extent to which Italy sought to improve its international position during a crucial phase of the Cold War. It also considers how the United States exploited Italy’s international political ambitions. Conventional wisdom holds that Italian leaders after World War II sur- rendered almost all of their leeway in foreign policy to Italy’s European and Atlantic partners. Italy’s humiliating defeat in the war, the task of economic reconstruction, the country’s deep political divisions, and the long record of Italy’s subordination to the great powers in Europe all posed formidable ob- stacles to any dream of diplomatic prominence. Even after an economic re- covery took hold in the 1950s, Italy’s inºuence in world politics was less than its demographic and economic size would have implied. Italy’s faction-ridden political elites, the traditional argument goes, ensured that the country always subordinated its foreign policy to domestic concerns. As an American politi- cal analyst, Norman Kogan, put it in 1957, “the key objective of Italian For- eign Policy is to protect the domestic social structure from internal dangers.” This tendency allegedly induced Italian leaders to defer to the United States, which they regarded as the best guardian of their country’s internal stability and perhaps even of their own political ambitions. -

Statement by Giovanni Gronchi (5 March 1946)
Statement by Giovanni Gronchi (5 March 1946) Caption: On 5 March 1946, before the National Council, Giovanni Gronchi, Italian Minister for Industry, gives an initial review of the efforts made to revive the Italian economy and outlines the aid granted to the country by UNRRA. Source: Discorsi parlamentari: Gronchi, Giovanni. Roma: Senato della Repubblica-Segretariato Generale- Servizio Studi, 1986. 601 p. p. 201-220. Copyright: (c) Translation CVCE.EU by UNI.LU All rights of reproduction, of public communication, of adaptation, of distribution or of dissemination via Internet, internal network or any other means are strictly reserved in all countries. Consult the legal notice and the terms and conditions of use regarding this site. URL: http://www.cvce.eu/obj/statement_by_giovanni_gronchi_5_march_1946-en- 951fa14f-a137-4479-8838-1f504797dce7.html Last updated: 05/07/2016 1/10 Statement by Giovanni Gronchi (5 March 1946) In response to two questions regarding industrial production from National Council members Della Giusta, Molinari and Giavi (National Council, sitting of 5 March 1946) PRESIDENT: The Minister for Trade and Industry has the floor. GRONCHI: Minister for Trade and Industry. I welcome this opportunity to set out, albeit briefly, what the current and previous governments have done to rebuild our industries, and what we are now intending to do, in so far as we are able. Mr Della Giusta’s question perhaps sets the debate in a wider context, namely the general direction that our economic and industrial policy should take. I am not sure whether this is the most appropriate forum for responding to the questions that he has raised. -

Il 4 Novembre a Vittorio Veneto (A Cura Di Ido Da Ros)
Il 4 Novembre a Vittorio Veneto (a cura di Ido Da Ros) Presentiamo una sorta di albo d’oro degli oratori ufficiali che si sono succeduti ai microfoni di Piazza del Popolo per la celebrazione del 4 Novembre, anniversario della Vittoria e giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. In testa alla graduatoria – a partire dal secondo dopoguerra - troviamo l’on. Tina Anselmi e il colonnello Lorenzo Cadeddu, entrambi con quattro presenze, seguiti dagli onorevoli Carlo Bernini e Marino Corder e dal generale comandante il 1° Fod Giovanni Ridinò con tre presenze; lo stesso numero che può vantare Bernardo Mattarella, padre dell’attuale Presidente della Repubblica. Sono sei i Capi di Stato ad aver presieduto la cerimonia nella nostra città: Giovanni Gronchi, Giuseppe Saragat, Sandro Pertini, Francesco Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro e Giorgio Napolitano. Tre, invece, i Presidenti del Consiglio: Vittorio Emanuele Orlando (nel 1919), Amintore Fanfani e, per due volte consecutive, Aldo Moro. La prima celebrazione del 4 Novembre risale al 1919 e vide appunto la presenza del Capo del Governo Vittorio Emanuele Orlando e dell’ex Presidente del Consiglio, Luigi Luzzatti. Nel periodo compreso tra le due guerre mondiali la Festa fu in parte “oscurata” anche a Vittorio Veneto dalla vicinanza cronologica dell’anniversario della Marcia su Roma (28 ottobre), che il regime celebrava in grande stile. Meritano comunque di essere ricordate le celebrazioni del Decennale e del Ventennale, svoltesi alla presenza rispettivamente del re Vittorio Emanuele III (1928) e del principe Umberto di Savoia (1938). Dopo la tragica parentesi della Seconda Guerra Mondiale, le celebrazioni ripresero in quest’ordine: 1948: Maurizio Lazzaro di Castiglioni, generale di Corpo d’Armata e Francesco Franceschini, deputato vittoriese. -
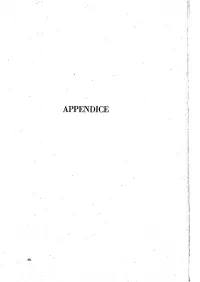
APPENDICE I - ' ' ' -Il
vi APPENDICE I - ' ' ' -il PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA ENRICO DE NICOLA, Capo prov visorio dello Stato dal 28 giugno 1946 al 24 giugno 1947 dal 25 giugno al 31 dicembre 1947 ENRICO DE NICOLA, Presidente della Repubblica ; dal 1° gennaio 1948 all'11 maggio 1948 LUIGI EINAUDI, Presidente della Repubblica dall'll maggio 1948 >"..". r ?.-.' V-r^v;*-"^"^ - •«• « ***•••>*• , . :ir.'-.•.:••.• L T • ~ i : ~ . ..' -» "• »-1 -?. ' *- / >^1 • - A •; li ENRICO DE NICOLA 82. • ' ? LUIGI EINAUDI PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI GIOVANNI GRONCHI. dall'8 maggio 1948 PRESIDÈNTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IVANOE BONOMI dall'8 maggio 1948 GIOVANNI GRONCHI -J-Ì IVANOE BONOMI PRESIDENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DALLA I ALLA XXVI LEGISLATURA VINCENZO GIOBERTI dall'8 maggio al 20 luglio 1848 e dal 16 ott. 30 die. 1848 IL . LORENZO PARETO dal 1° febbr. al 30 marzo 1849 III. LORENZO PARETO dal 30 luglio al 20* nov. 1849 IV . PIER DIONIGI PINELLI dal 20 die. 1849 al 25 aprile 1852 UHBANO RATTAZZI dall'll maggio 1852 al 27 ott. 1853 CARLO BON-COMPAGNI dal 16 al 21 nov. 1853 V ... CARLO BON-COMPAGNI. dal 19 die. 1853 al 16 giugno 1856 CARLO CADORNA.. dal 7 genn. al 16 luglio 1857 VI .. CARLO CADORNA. dal 14 die. 1857 al 14 luglio 1858 URBANO RATTAZZI. dal 10 genn. 1859 al 21 genn. 1860 VII . GIOVANNI LANZA dal 2 aprile al 28 die. 1860 VIII URBANO RATTAZZI. dal 18 febbr. 1861 al 2 marzo 1862 SEBASTIANO TECCHIO dal 22 marzo 1862 al 21 magg. 1863 GIOVANNI BATTISTA CASSINIS dal 25 maggio 1863 al 7 sett. 1865 IX. -

Communicating Europe: Italy Manual
Communicating Europe: Italy Manual Information and contacts on the Italian debate on EU enlargement in the Western Balkans Supported by the Global Opportunities Fund – Reuniting Europe of the UK Foreign & Commonwealth Office 19 May 2008 Contents ABOUT THIS MANUAL ...................................................................................................................... 1 A. MEDIA ...................................................................................................................................... 2 1. ELECTRONIC MEDIA: TV AND RADIO ......................................................................................... 2 2. PRINT MEDIA: NATIONAL PRINT MEDIA ..................................................................................... 8 2.1. The quality dailies .............................................................................................................. 9 2.2. Weeklies ........................................................................................................................... 12 2.3. Press Officers of EU Institutions in Italy ............................................................................ 13 2.4. Online Media ................................................................................................................... 14 2.5. News Agencies ................................................................................................................ 14 2.6. Regional print media ..................................................................................................... -

Il Presidente Della Repubblica – Rassegna Bibliografica
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA BIBLIOTECA QUIRINALE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Percorsi tematici 1/I _________ Giugno 2014 SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA BIBLIOTECA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Rassegna bibliografica I _________ Giugno 2014 A cura di Carla Capobianchi Ricerche e documentazione dai siti Internet a cura di Nicoletta Grella Le nuove indicazioni bibliografiche inserite nel Percorso tematico durante il semestre gennaio-giugno 2014 sono evidenziate in giallo. INDICE ___________________________________________________ IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA La figura e il ruolo Repertori pag. 1 Monografie pag. 3 Miscellanea pag. 17 Letteratura grigia pag. 32 Dottrina pag. 33 Profili comparatistici pag. 60 POTERI E ATTRIBUZIONI Repertori pag. 83 Formazione del Governo Repertori pag. 84 Monografie pag. 84 Miscellanea pag. 85 Dottrina pag. 87 Profili comparatistici pag. 101 Scioglimento delle Camere Repertori pag. 103 Monografie pag. 103 Miscellanea pag. 104 Dottrina pag. 105 Profili comparatistici pag. 111 Promulgazione delle leggi e rinvio delle leggi alle Camere Repertori pag. 112 Monografie pag. 112 Miscellanea pag. 113 I Letteratura grigia pag. 117 Dottrina pag. 118 Profili comparatistici pag. 124 Emanazione dei decreti aventi valore di legge Monografie pag. 126 Miscellanea pag. 126 Dottrina pag. 127 Autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge di iniziativa del Governo Monografie pag. 136 Miscellanea pag. 136 Nomina dei senatori a vita Monografie pag. 139 Miscellanea pag. 139 Dottrina pag. 139 Messaggi alle Camere Monografie pag. 141 Miscellanea pag. 141 Letteratura grigia pag. 141 Dottrina pag. 142 Comando delle Forze armate Repertori pag. 143 Monografie pag. 143 Miscellanea pag. 144 Dottrina pag. 144 Ratifica dei trattati internazionali . Miscellanea pag. -

Can a Troubled Political Era Be Detected by Machine Learning Methods? an Application on the End of Year Speeches of the Italian Presidents
Can a troubled political era be detected by machine learning methods? An application on the End of Year speeches of the Italian Presidents Franco M. T. Gatti1, Arjuna Tuzzi2 1Università degli Studi di Padova – [email protected] 2Università degli Studi di Padova – [email protected] Abstract President Oscar Luigi Scalfaro took office in 1992, when the Italian political and judicial climate was highly turbulent. As his speeches may be considered a good source of information for grasping the transition between the so called "First" and the "Second" Republic, this study aims at analysing the 71 End of Year speeches pronounced by the 11 Presidents of the Italian Republic in order to check whether we are able to detect a clear-cut fracture within the corpus by means of supervised machine learning methods applied to texts. For this purpose, our corpus has been arranged in three different configurations to assess the performance of different classification tasks within the training set (cross-validation procedure) and to observe in which one of the three arrangements the algorithms perform better. For the final attribution task we chose the configuration that showed the highest accuracy and we split the set of speeches in a training set and a test set to observe how the algorithms assign the text chunks of the test set to the two classes (First or Second Republic). A comparison between the performance of the two different algorithms used in this work, i.e. Support Vector Machine (SVM) and Random Forest (RF) has been discussed throughout the whole study. -

A Loyola Rome Student's Guide to World War Ii in Rome
A LOYOLA ROME STUDENT’S GUIDE TO WORLD WAR II IN ROME & ITALY By Philip R. O’Connor, Ph.D. Loyola University Rome Center 1968-69 DOWNLOADABLE VERSION AVAILABLE PLEASE DIRECT COMMENTS AND SUGGESTIONS TO [email protected] Tenth Edition – September 2015 LOYOLA ROME STUDENT’S GUIDE TO WORLD WAR II IN ROME & ITALY DEDICATION & ACKNOWLEDGEMENTS This Guide to World War II in Italy and Rome is dedicated to those who served the Allied cause in the Italian War of Liberation 1943-45. Of special remembrance are the five Loyolans who, in the words of Abraham Lincoln, “gave the last full measure of devotion” on Italian soil: John J. Burke, John L. Carmody, Kenneth E. Krucks, Thomas A. McKitrick and Dean P. Reinert. John Felice, founder and guiding light of the Loyola Rome Center for thirty years and whose name was given to the Campus in 2004, was an intelligence officer in the British Eighth Army seconded to the American 12 th Air Force, 47 th Bombardment Group (Light) in preparation for the invasions of Sicily and the Italian mainland. John, who first inspired this Guide, passed away in January 2008, having lived the life of a great man. Another who served was the author’s uncle, Edward O’Connor. He followed his older brother, the author’s father, Philip J., into the U.S. Navy. Philip served in the South Pacific while Ed crewed in a 5-inch gun aboard the light cruiser USS Philadelphia . Before his nineteenth birthday, Eddie O’Connor participated in the invasion of Sicily, the landing at Salerno, the sbarco at Anzio-Nettuno followed by four months of daily missions from Naples to shell German forces besieging the beachhead, and the invasion of Southern France. -

I Presidenti Della Repubblica Italiana
EDIZIONI SIMONE Espansione on line S356/2 Gruppo Editoriale Simone Percorso 5 ➜ La struttura dello stato secondo la costituzione lezione 3 Il Presidente della repubblica I Presidenti della Repubblica italiana La Repubblica italiana ha avuto fino a oggi dodici Presidenti. Enrico De Nicola (1948) Enrico De Nicola, nato a Napoli nel 1877, è stato uno dei maggiori avvocati penalisti di inizio secolo. Presidente della Camera dei deputati dal 1920 al 1924, è stato eletto Capo provvisorio dello Stato il 1° luglio 1946 dall’Assemblea costituente. In tale veste egli ha diretto i lavori che hanno portato alla nascita della Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1° gen- naio 1948. Nella stessa data, Enrico De Nicola ha assunto il titolo di primo Presidente della Repubblica italiana, carica che ha ricoperto fino all’11 maggio 1948. Luigi Einaudi (1948 – 1955) Luigi Einaudi, nato a Carrù (Cuneo) nel 1874, è stato giornalista e professore universitario. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, soprattutto nelle materie economiche, alcune delle quali tradotte nelle principali lingue straniere. Nominato senatore del Regno d’Italia nel 1919 si è rifugiato in Svizzera durante il fascismo. Rientrato in Italia alla fine della se- conda guerra mondiale, ha partecipato ai lavori della Consulta nazionale e dell’Assemblea costituente. È stato eletto Presidente della Repubblica l’11 maggio 1948, portando a termine il suo man- dato settennale. Giovanni Gronchi (1955 – 1962) Giovanni Gronchi (1887 – 1978) è nato a Pontedera, in provincia di Pisa. È stato insegnante di Lettere e Filosofia ed è tra i fondatori del partito popolare italiano. Durante il fascismo si è ritirato a vita privata per contrasti con il regime, ma ha ripreso la vita politica alla fine della seconda guerra mondiale. -

“ … the Tricolored Flag, a Pledge of Our Determination to Reaffirm, To
000 - I-XXIX_00-Presentazione Prima Parte ING nuova edizione 05/09/14 10:28 Pagina I “ … the Tricolored Flag, a pledge of our determination to reaffirm, to defend, to strengthen national unity, the cause to which many Italians pledged their commitment and their lives”. Giorgio Napolitano From the address by the President of the Republic on the occasion of the Italian Flag Day. Reggio Emilia, January 7, 2011. 000 - I-XXIX_00-Presentazione Prima Parte ING nuova edizione 05/09/14 10:28 Pagina II II The Embassy of Italy in Washington Inauguration of the Parliament of the Kingdom of Italy. Turin, February 18, 1861. Inauguration of the Constituent Assembly, Rome, 1946. Photos courtesy of the Library of the Chamber of Deputies. Rome. 000 - I-XXIX_00-Presentazione Prima Parte ING nuova edizione 05/09/14 10:28 Pagina III III Rome, March 31, 1911. The King and the Queen visit the Exhibition at the Palazzo delle Belle Arti, on the occasion of the 50th Anniversary of the Unification of Italy. Photo courtesy of the Secretariat General of the Presidency of the Republic. 50th Anniversary of the Unification of Italy. His Majesty reads from the text of his address in Campidoglio. President of the Republic, Giovanni Gronchi, as he addresses Parliament on the occasion of the celebrations of the 100th Anniversary of the Unification of Italy. Photos courtesy of the Library of the Chamber of Deputies. Rome. 000 - I-XXIX_00-Presentazione Prima Parte ING nuova edizione 05/09/14 10:28 Pagina IV IV The Embassy of Italy in Washington Rome, April 22, 2013.