S E Gît S Iu M
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Se-183-00 Sommario.Vp
STUDI MIGRATION EMIGRAZIONE STUDIES rivista trimestrale quarterly journal CENTRO STUDI EMIGRAZIONE - ROMA ANNO XLVIII - LUGLIO-SETTEMBRE 2011 - N. 183 SOMMARIO 150 anni della nostra storia: la pastorale agli emigrati in Europa e Australia a cura di VINCENZO ROSATO 355 – Introduzione, Vincenzo Rosato 357 – Cronologia e storia dell’emigrazione italiana, Matteo Sanfilippo 371 – Santa Sede e movimenti migratori: una lunga storia di attenzione alla persona umana, Gabriele Bentoglio 385 – Emigrazione italiana in Europa: missione e cura pastorale, Giovanni Graziano Tassello 407 – I pionieri del servizio ai migranti italiani. Gli interventi provvidenziali di Pallotti, Bosco, Scalabrini, Bonomelli e Cabrini a partire dall’Unità d’Italia, Vincenzo Rosato 427 – L’emigrazione nella memoria storica italiana. Una riflessione critica, Roberto Sala 442 – Gli italiani di Bedford: sessant’anni di vita in Inghilterra, Margherita Di Salvo 461 – Guerre fra compagni a cavallo del 1900. Il movimento socialista italiano in Svizzera ed il socialismo elvetico fra classe e nazione, Domenico Guzzo Coordinatore editoriale: Matteo Sanfilippo - Centro Studi Emigrazione - Roma 2011 477 – L’emigrazione italiana in Australia, Fabio Baggio, Matteo Sanfilippo 500 – Identity and cultural maintenance: Observations from a case study of third-generation Italian-Australians in South Australia, Melanie Smans, Diana Glenn 515 – Recensioni 524 – Segnalazioni 354 «Studi Emigrazione/Migration Studies», XLVIII, n. 183, 2011. Introduzione Gli ultimi 150 anni della storia italiana sono stati attraversati da numerose vicende, che hanno segnato profondamente le sorti della na- zione. Il grande sforzo di unificare il paese non ha, però, corrisposto al desiderio pressante di creare un unico popolo, anzi fin dall’inizio l’Ita- lia come il resto dell’Europa ha visto la partenza di tanti, che si sono sparsi per tutti i continenti. -

Teachings on Spiritual Life
SAINT JOHN BOSCO TEACHINGS ON SPIRITUAL LIFE An anthology Introduction and notes by Aldo Giraudo LAS – ROME Introduction Aldo GIRAUDO, sdb Which of his writings best portray Saint John Bosco as a teacher of inner life and give us, if not all of his “spiritual doctrine",1 at least the most characteristic features of his spirituality, that fertile flow of good fruits we think of as a “school of holiness valid for every state of life”?2 The question is pertinent since not only did Don Bosco, like St Alphonsus, not leave behind pages revealing the intimacy of his being; he also did not consider bringing together a systematic picture of a spirituality, as we would call it today, or an ascetica, as he would have called it in his era: a harmonious set of spiritual reflections. Certainly he gave us splendid testimonies, few and modest as they were, of the spiritual life of others. He saw them in action and was himself a concomitant factor for them: Louis Comollo, Dominic Savio, Michael Magone, Francis Besucco.3 Though in narrative form and written to edify, these documents do highlight inner experiences and essential features of Christian spirituality as proposed for young people. A study of these biographical sketches, the inner pursuits of their youthful characters, and the general atmosphere of growth and development in the educational setting, in the community which was the context in which their spiritual adventure unfolded, allows us to garner the essential features of a model of youthful holiness, and the salient principles of a vade-mecum of ascetics comparable with the Introduction to the Devout Life by St Francis de Sales. -

La-Mia-Fede-Nei-Santi-Di-Ogni-Giorno
1 MARTINO CARBOTTI LA MIA FEDE nei Santi di ogni giorno Pugliesi Editore 2 Introduzione Non è assolutamente semplice per me, figlio, delineare la figura di mio padre: Ninuccio Carbotti. Non vi nascondo di averci pensato per molto tempo, dubbioso, circa i tanti aspetti su cui avrei dovuto soffermarmi e una delle domande che mi sono subito posto è stata: ma oltre alla figura di padre modello che io conoscevo, cos'altro conosco della vita di mio padre? E qui ho avuto delle perplessità ..... sì dico perplessità perché tutti i padri presumo hanno un determinato comportamento con i figli, dettato dal ruolo, c'è chi lo fà con più severità e chi meno, chi è pedante e chi meno, chi è accondiscendente e chi meno e via dicendo ma sicuramente tutti si apprestano a svolgere questo compito basilare con uno sconfinato e immenso amore !!! Ma un padre oltre a questo è anche un “uomo”ed è proprio il profilo umano, di uomo tra gli uomini, che mi ha portato ad iniziare questo lavoro, oserei dire di ricerca, esegetico, di tutti gli scritti e archiviazioni varie che con pazienza e passione certosina egli aveva iniziato ed implementato nei vari anni della sua vita. Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia molto unita, sotto tutti gli aspetti. Mio padre apparteneva a quelle belle famiglie di una volta, numerose: erano otto figli, madre, padre e “zizì” a carico (una zia di mia padre, sorella minore di mia nonna, la quale viveva sotto lo stesso tetto a causa di lievi problemi invalidanti) e come tradizione comanda, tutti i figli maschi e dico tutti nessuno escluso, hanno ereditato dal padre l'arte della lavorazione del legno. -

Santissimo Nome Di Gesù
3 gennaio SANTISSIMO NOME DI GESÙ Il Santissimo Nome di Gesù fu sempre onorato e venerato nella Chiesa fin dai primi tempi, ma solo nel secolo XIV cominciò ad avere culto liturgico. San Bernardino, aiutato da altri suoi confratelli, soprattutto dai beati Alberto da Sarteano e Bernardino da Feltre, diffuse con tanto zelo e fervore la devozione del Nome di Gesù per l’Europa intera, che finalmente venne istituita la festa liturgica. Nel 1530 Clemente VII autorizzò l’Ordine francescano a celebrare l’ufficio divino del Santissimo Nome di Gesù. PREGHIERA Guarda, o Padre, questa tua famiglia che onora il santo Nome di Gesù tuo Figlio: donaci di gustare la sua dolcezza in questa vita, per godere la felicità eterna nella patria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 1 4 gennaio BEATA ANGELA DA FOLIGNO, penitente, terziaria Nacque a Foligno (Perugia) nel 1248 da nobile famiglia. Da giovane, anche sposata, si lasciò andare alla mondanità. Dopo la morte del marito distribuì tutti i suoi beni ai poveri e si iscrisse al Terz’Ordine della Penitenza. Assidua nella meditazione della Passione del Signore, lasciò molti e bellissimi scritti di vita spirituale, che le meritarono reputazione di grande mistica. Morì il 4 gennaio 1309 e venne sepolta a Foligno nella chiesa di San Francesco. Clemente XI ne confermò il culto il 7 maggio 1701. PREGHIERA O Dio, che hai dato alla beata Angela da Foligno una profonda conoscenza dei misteri del tuo Figlio, per i suoi meriti e la sua intercessione donaci di vivere in questo mondo nella verità del Cristo, per meritare la gioia della tua manifestazione nella gloria. -

RSS Vol17 1990 A009 N2
ISSN 0393-3830 RICERCHE STORICHE SALESIANE RIVISTA SEMESTRALE DI STORIA RELIGIOSA E CIVILE 17 ANNO IX - N. 2 LUGLIO-DICEMBRE 1990 LAS - ROMA RICERCHE STORICHE SALESIANE Rivista semestrale di storia a cura religiosa e civile dellTstituto Storico Salesiano - Roma Luglio-Dicembre 1990 Anno iX - N. 2 17 Direzione: Istituto Storico Salesiano Via della Pisana, 1111 00163 ROMA Abbonamento per il 1990: Associata alla Unione Italia; L. 2 0 . 0 0 0 Stampa Periodica Italiana Estero; L. 25.000 Fascicolo singolo: Italia; L. 1 2 . 0 0 0 Estero; L. 14.000 Amministrazione: Editrice LAS (Libreria Ateneo Salesiano) Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 00139 ROMA Manoscritti, corrispondenze, libri per recensione e riviste c.c.p. 57492001 intestato a: in cambio devono essere inviati Pontifìcio Ateneo Salesiano alla Direzione della Rivista Libreria LAS RICERCHE STORICHE SALESIANE RIVISTA SEMESTRALE DI STORIA RELIGIOSA E CIVILE ANNO IX - N. 2 (17) LUGLIO-DICEMBRE 1990 SO M M A RIO Sommari - Summaries ......................................................................... 271-275 STUDI F erreira Antonio da Silva, Ventanni di formazione del personale sa lesiano nelVispettoria deU'Uruguay e del Brasile ( 1876-1895) .... 277-294 ZiMNiAK Stanislaw, Don Pietro Pirone superiore dell’Ispettoria Austro-Ungarica (1911-1919) .................................................. 295-346 TESTI P rellezo José Manuel, L ’Oratorio di Valdocco nel «Diario» di don Chiala e don Lazzero (1875-1888. 1895). Introduzione e testi critici.......................................................................................... 347-442 NOTE D al C ovolo Enrico, I Padri della Chiesa negli scritti del salesiano don Giuseppe Quadrio ............................................................... 443-455 D ickson W. John, Refounding or renewal? A historical case study 457-464 RECENSIONI (v. pag. seg.) REPERTORIO BIBLIOGRAFICO a cura di Saverio Gianotti . -
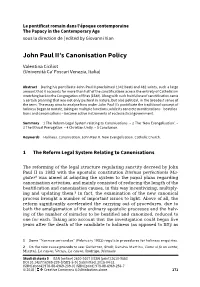
John Paul II's Canonisation Policy
Le pontificat romain dans l’époque contemporaine The Papacy in the Contemporary Age sous la direction de | edited by Giovanni Vian John Paul II’s Canonisation Policy Valentina Ciciliot (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Abstract During his pontificate John Paul II proclaimed 1342 beati and 482 saints, such a large amount that it accounts for more than half of the sanctifications across the entirety of Catholicism stretching back to the Congregation of Rites (1588). Along with such fruitful use of sanctification came a certain planning that was not only pastoral in nature, but also political, in the broadest sense of the term. The essay aims to analyse how under John Paul II’s pontificate the traditional concept of holiness began to mutate, taking on multiple functions, while its concrete manifestations – beatifica- tions and canonisations – became active instruments of ecclesiastical government. Summary 1 The Reform Legal System relating to Canonisations. – 2 The ‘New Evangelisation’. – 3 The Ethical Prerogative. – 4 Christian Unity. – 5 Conclusion. Keywords Holiness. Canonisation. John Paul II. New Evangelisation. Catholic Church. 1 The Reform Legal System Relating to Canonisations The reforming of the legal structure regulating sanctity decreed by John Paul II in 1983 with the apostolic constitution Divinus perfectionis Ma- gister1 was aimed at adapting the system to the papal plans regarding canonisation activities, and mainly consisted of reducing the length of the beatification and canonisation causes, in this way incentivizing, multiply- ing and updating them.2 In fact, the examination of the new canonical process brought a number of important issues to light. Above of all, the reform significantly accelerated the carrying out of procedures, due to both the amalgamation of the ordinary apostolic processes and the halv- ing of the number of miracles to be beatified and canonized, reduced to one for each. -

The Holy See
The Holy See MESSAGE OF JOHN PAUL II TO THE BISHOP OF SUSA (ITALY) ON THE FIRST CENTENARY OF THE ERECTION OF THE STATUE OF THE MOTHER OF THE LORD ON THE SUMMIT OF MOUNT ROCCIAMELONE To my Venerable Brother Bishop Vittorio Bernardetto of Susa 1. I was pleased to learn that this year the Church in Valsusa is celebrating the first centenary of the statue of the Mother of the Lord erected on Mount Rocciamelone. Remembering with gratitude the festive welcome I was given on 14 July 1991 during my Pastoral Visit to Susa, and the profound moment of prayer in the Cathedral of St Justus in front of the triptych that Bonifacio Rotario, a citizen of Asti, carried to that peak on 1 September 1358, I would like to join spiritually in the celebrations by which the entire diocesan community intends to mark this significant anniversary. A hundred years ago, in spiritual continuity with the ancient act of faith that gave birth to Marian devotion on Rocciamelone, Canon Antonio Tonda, provost of the cathedral, and Prof. Giovanni Battista Ghirardi, encouraged by Bl. Bishop Edoardo Giuseppe Rosaz, thought of erecting a statue of the Blessed Virgin on the highest peak of the western Alps, which was later done with the generous contribution of 130,000 "children of Italy". With this project, imitating the disciple whom Jesus loved (cf. Jn 19:27), the Church in Valsusa showed her desire to welcome Mary "into her home", so that she would repeat to the sons and daughters of this land what she once said at Cana in Galilee: "Do whatever he tells you" (Jn 2:5). -

SEGUSIUM 38 in Copertina: Susa, Cinta Di Mura, in Una Delle Tavole Del Theatrum Sabaudiae (1682)
SEGUSIUM 38 In copertina: Susa, cinta di mura, in una delle tavole del Theatrum Sabaudiae (1682). Il fregio nella pagina precedente è la riproduzione di un sigillo-timbro – visibilmente usurato – del secolo XVIII della Provincia di Susa (Museo Civico - Susa). Società di Ricerche e Studi Valsusini SEGUSIUM SUSA - Settembre 1999 - Anno XXXVI - n. 38 Il Consiglio Direttivo di Segusium Giulio Fabiano, presidente onorario. Lino Bortolo Perdoncin, presidente - Tullio Forno, vicepresidente - Ferruccio Pari, segretario - Giorgio Maffiodo, tesoriere - Consi- glieri: Natalino Bartolomasi, Enea Carruccio, Mario Cavargna, Mauro Minola, Alberto Perino, Luigi Pognant Gros. Il Comitato di Redazione della rivista Direttore: Tullio Forno. Comitato: Piero Del Vecchio, Giulio Fabiano, Laura Grisa, Mau- ro Minola, Ferruccio Pari, Alberto Perino. Direttore responsabile: Tullio Forno. Autorizzazione del Tribunale di Torino, n. 1666, 31 luglio 1964. Proprietà riservata Finito di stampare dalla Grafica Chierese nel mese di settembre 1999. * * * Segusium - Società di Ricerche e Studi Valsusini Sede: Via Unione Sovietica 8 (dei Fossali) - 10059 Susa (TO) Indirizzare la corrispondenza a: Segusium - Casella Postale 43 - 10059 Susa (TO) I versamenti vanno fatti indirizzando a Segusium - Conto Corrente Postale n. 29681103 - 10059 Susa (TO). SEGUSIUM - Susa - Settembre 1999 - Anno XXXVI - n. 38 SOMMARIO Questo numero 38 . pag. 6 RICERCHE E STUDI Mario Cavargna: La strada romana «Per Alpes Cottias» . pag. 11 Giancarlo Chiarle: I visconti di Baratonia e di Villar Focchiardo . pag. 35 Maria Luisa Moncassoli Tibone: Un messaggio per le genti: la Gran Reliquia dipinta in Val di Susa . pag. 97 Per Giorgio Gagnor: La devozione sulla montagna di Condove . pag. 107 Piero Del Vecchio: Simboli e significati della devozione popolare . -
Nuove Accessioni 2016/01
Polo Bibliotecario Parlamentare Nuove Biblioteca Biblioteca del Senato della Camera Accessioni Anno 20 16 Numero 1 Polo Bibliotecario Biblioteca del Senato Biblioteca della Camera Parlamentare “Giovanni Spadolini” dei deputati Piazza della Minerva, 38 Via del Seminario, 76 00186 Roma 00186 Roma Tel. 06.6706.3717 Tel. 06.6760.3672 sito web: www.parlamento.it/polobibliotecario accesso integrato ai cataloghi: http://opac.parlamento.it Le Biblioteche della Camera e del Senato, procedendo nel percorso di integrazione intrapreso nell’ambito del Polo bibliotecario parlamentare, presentano ora congiuntamente la rassegna delle più recenti pubblicazioni acquisite e catalogate. E’ così possibile cogliere la ricchezza e la complementarietà dei materiali offerti al servizio delle attività di studio e di ricerca del Parlamento e dell’intera cittadinanza. La rassegna è organizzata in sezioni (Diritto, Economia e finanza, Politica e istituzioni, Società, Storia, Altre discipline), con ulteriori articolazioni tematiche all'interno di ciascuna. Nuove Accessioni comprende monografie, periodici, risorse elettroniche; vi sono inclusi anche materiali di “letteratura grigia” utili alla ricerca in ambito politico-parlamentare, cioè studi, ricerche e dossier non reperibili attraverso i consueti canali di distribuzione commerciale e prodotti da soggetti esterni, quali ministeri, enti locali, istituti specializzati, centri di studio e di ricerca pubblici e privati. Per la ricerca e la consultazione dei dossier curati, nella XVII legislatura, dalla Camera dei deputati -

Le Pontificat Romain Dans L'époque Contemporaine the Papacy in the Contemporary
e-ISSN 2610-9107 Studi di storia 5 ISSN 2610-9883 — Le pontificat romain dans l’époque contemporaine The Papacy in the Contemporary Age sous la direction de | edited by Giovanni Vian Edizioni Ca’Foscari Le pontificat romain dans l’époque contemporaine The Papacy in the Contemporary Age Studi di storia Collana coordinata da Laura Cerasi Mario Infelise Anna Rapetti 5 Studi di storia Coordinatori Laura Cerasi (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Mario Infelise (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Anna Rapetti (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Comitato scientifico Claus Arnold (Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, Deutschland) Marina Caffiero (Sapienza Università di Roma, Italia) Giovanni Filoramo (Università degli Studi di Torino, Italia) Marco Fincardi (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Stefano Gasparri (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Vincenzo Lavenia (Università di Macerata, Italia) Simon Levis Sullam (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Adelisa Malena (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Alberto Masoero (Università degli Studi di Genova, Italia) Rolf Petri (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Giorgio Politi (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Silvio Pons (Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’, Italia) Antonella Salomoni (Università della Calabria, Cosenza, Italia) Enzo Traverso (Cornell University, Ithaca, New York, United States) Giovanni Vian (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Chris Wickham (All Souls College, University of Oxford, United Kingdom) Direzione e redazione Università -

Le Pontificat Romain Dans L'époque Contemporaine The
DANS L’ DANS ROMAIN LE PONTIFICAT e-ISSN 2610-9107 Studi di storia 5 ISSN 2610-9883 ÉPOQUE CONTEMPORAINE — Le pontificat romain dans l’époque contemporaine VIAN The Papacy in the Contemporary Age sous la direction de | edited by Giovanni Vian Edizioni Ca’Foscari 5 Le pontificat romain dans l’époque contemporaine The Papacy in the Contemporary Age Studi di storia Collana coordinata da Laura Cerasi Mario Infelise Anna Rapetti 5 Studi di storia Coordinatori Laura Cerasi (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Mario Infelise (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Anna Rapetti (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Comitato scientifico Claus Arnold (Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, Deutschland) Marina Caffiero (Sapienza Università di Roma, Italia) Giovanni Filoramo (Università degli Studi di Torino, Italia) Marco Fincardi (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Stefano Gasparri (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Vincenzo Lavenia (Università di Macerata, Italia) Simon Levis Sullam (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Adelisa Malena (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Alberto Masoero (Università degli Studi di Genova, Italia) Rolf Petri (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Giorgio Politi (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Silvio Pons (Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’, Italia) Antonella Salomoni (Università della Calabria, Cosenza, Italia) Enzo Traverso (Cornell University, Ithaca, New York, United States) Giovanni Vian (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Chris Wickham (All Souls College, University -

DON BOSCO 2015 Ultimo Tracciati.Indd
1 2 le guide dell’Europea L’indice EUROPEA EDITORIALE Direzione e Coordinamento Editoriale Il prete senza tempo: Presentazione Giusi Suffi a e Patrizia Guerra Rettor Maggiore Ángel Fernández Artime Pag. 04 Direttore Responsabile Enrico Romanetto Amico e maestro della gioventù: Presentazione Grafi ca e Advertising Arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia Pag. 05 Manuela Amadei, Andrea Pilloni Vita e opere Pag. 06 Una realizzazione EUROPEA EDITORIALE C.O.M. s.r.l. Luoghi e memorie: Castelnuovo Don Bosco Pag. 14 Direzione, Redazione, Pubblicità, Amministrazione Via Givoletto 5/c - 10149 Torino Tel. 011.4539211 (r.a.) - Fax 011.45.56.830 Le biografi e: Margherita Occhiena Pag. 16 Luoghi e memorie: Il Colle e la Basilica Pag. 18 e-mail: [email protected] - grafi [email protected] Luoghi e memorie: Chieri Pag. 28 www.europeaeditoriale.com Luoghi e memorie: Torino Pag. 32 Iscrizione al registro degli Editori e Stampatori presso l’Uffi cio Territoriale del Governo di Torino, Le biografi e: Domenico Savio Pag. 38 Prefettura al n. 2229 Luoghi e memorie: Maria Ausiliatrice Pag. 40 Stampa: Grafi che Giglio Tos S.r.l. Salesiani nel mondo Pag. 42 I dati personali e le attività sono state pubblicate in conformità alla legge 675/96, con il fi ne di pubblicizzare le attività e le iniziative delle pubblicazioni della Europea Editoriale. I Ostensione 2015: Papa Francesco a Torino Pag. 43 dati sono stati trattati con la massima riservatezza e non saranno diffusi a terzi. Le cartine riprodotte hanno valore puramente indicativo della zona interessata e Itinerari e percorsi: i musei Pag. 45 pertanto non vogliono avere carattere di completezza degli elementi (località, strade, orografi a ecc.) presenti sul territorio.