L' Accoglienza in Valle Camonica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Il Comitato Per Montecampione
Il giro d’ Italia mette a nudo i problemi di MONTECAMPIONE Pubblichiamo qui di seguito l' articolo di Brescia Oggi sulla tappa del Giro d'Italia 2014. Ne avevamo dato la notizia qualche giorno fa, dichiarandoci ben felici che finalmente i nostri Comuni, ed in particolare quello di Artogne sul cui territorio insiste la strada 1200-1800 che porta al Bassinale (Plan) spendessero un po' della nostra IMU, almeno nel comprensorio. Ci siamo sbagliati, poiché il sindaco Cesari, sentito appunto dal giornalista D. Benzoni, si è affrettato a mettere le mani avanti ed ha detto: "LA NOSTRA VOLONTÀ (Cesari, se lo vorrà, ci dirà a chi attribuire le maiuscole) c'è. Certo i conti bisogna farli con una serie di problemi: da quello finanziario a quello logistico. Serve la compartecipazione economica dei Comuni ed in questi frangenti si sa bene che cosa significhi; l'assenza di alberghi a Montecampione viene poi a rimarcare una basilare carenza per la stazione turistica". A questo punto è il giornalista che gli fa notare che la strada che porta al Plan è impraticabile e ricorda che era intestata ad Alpiaz che, essendo fallita, è ora rappresentata dal Curatore. Ed ecco il sindaco Cesari "È ANCHE DA LUI che dipende il rifacimento del fondo. Salire fino al complesso Le Baite per gli automobilisti oggi è come avventurarsi in una gimkana tra buche ed avvallamenti; provate a immaginare la carovana rosa che che si inerpica in queste condizioni proibitive". Sempre cronache surreali quindi, per non dire marziane. Parla di mancanza di alberghi ! Al sindaco Cesari abbiamo già fatto, in un altro post su Facebook, l'elenco delle convenzioni che speriamo sempre possa servire. -

The Valle Camonica National Prehistory and Proto-History Centre
OPENING TIMES Information Check on websites prior to visit; subject to modification. Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri (Tel. 0364.42140) HOW TO GET THERE: www.parcoincisioni.capodiponte.beniculturali.it www.lacittadina.it FROM THE SOUTH www.facebook.com/ParcoNaquane print: A4 Motorway/Freeway: exit at Seriate or Rovato; road SS42 (Tonale and Mendola), direction Passo del Tonale, exit Nadro-Ceto, Capo di Ponte, Open throughout the year from 8:30 until 13:30 Cimbergo-Paspardo - Rock art sites and follow signs for Capo di Ponte. Closed on Mondays ■ For Naquane locality Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo After passing Capo di Ponte railway station, keep to the right at the www.parcoarcheologico.massidicemmo.beniculturali.it level crossing and take the road leading to the Chiesa delle Sante. Open throughout the year from 8:30 until 13:30 Closed on Mondays ■ For Cemmo locality At the first roundabout on the outskirts of Capo di Ponte, turn left and MUPRE (Tel. 0364.42403) follow signs for the Massi di Cemmo. www.mupre.capodiponte.beniculturali.it ■ For the Capo di Ponte museum (MUPRE) www.facebook.com/mupre.vallecamonica 7, Via S. Martino Open throughout the year from 14:00 until 19:00 1 Closed on Sundays FROM THE NORTH From the Aprica Pass or Tonale Pass, after reaching Edolo continue on road SS42 (Tonale and Mendola) direction Brescia; exit Capo di Ponte- TICKET PRICES Sellero direction Capo di Ponte. The ticket office shuts 30 minutes before closing time. E ■ For Naquane locality ADULTS: 4 (admittance to the Naquane National Rock Engravings Park After the second roundabout, turn left into Via Limit and follow signs and MUPRE; entry to the Cemmo National Archaeological Park is free). -

Nevediversa 2021
NEVEDIVERSA Il turismo invernale nell’epoca della transizione ecologica tra conflitti, discordanze e preoccupazioni, ma anche buone pratiche e nuove speranze. 2021 Sommario Premessa 5 Friuli Venezia Giulia 72 Neve e ghiaccio bollenti 9 Emilia Romagna 73 Temperatura 11 Marche, Umbria 74 Precipitazioni 14 Toscana 74 Neve al suolo 15 Abruzzo 75 Permafrost 17 Campania 75 Effetti sugli ecosistemi 19 Calabria 76 L’affidabilità della neve Basilicata 76 nei comprensori sciistici 20 Buone pratiche 77 I numeri dello sci alpino 24 Liguria 78 FOCUS ALPI 26 Piemonte 80 Premessa 26 Valle D’Aosta 85 Viola St Grée 26 Lombardia 87 Nevegàl, il colle dei bellunesi dove sciare è sempre più difficile 28 Veneto 89 Coppa del Mondo di Snowboard Trentino 90 A cura di Cross nel centro storico di Bergamo, Claudia Apostolo pericolo scampato 29 Alto Adige 93 Vanda Bonardo Dopo 50 anni Montecampione Friuli Venezia Giulia 94 Elisa Cozzarini se non si ripensa muore 29 Emilia Romagna 97 Paola Fagioli L’insostenibile logica Enrica Querro dei grandi comprensori sciistici 31 Marche 97 Abruzzo 99 Contributi di FOCUS APPENNINI 33 Antonio Tardito, Legambiente del Vittoriese Premessa 33 Campania 100 Nevegàl, il colle dei bellunesi dove sciare è sempre più difficile Natura, bioeconomia ed ecoturismo: Basilicata 101 le scelte per gli Appennini 34 Silvia Valenti, Legambiente Lombardia Calabria 102 Snowboard cross a Bergamo, pericolo scampato Attivo e sostenibile: Sicilia 102 il turismo a misura degli Appennini 35 Sardegna 104 Livio Pelamatti, Legambiente Valcamonica La tutela della -

Welcoming Refugees in the Camonica Valley: Critical Analysis of a Reception Model Between Opportunities and Limits
Welcoming refugees in the Camonica Valley: critical analysis of a reception model between opportunities and limits. Beatrice Bellavia Supervisor: Bas van Heur Master thesis presented in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science in Urban Studies (VUB) and Master of Science in Geography, general orientation, track ‘Urban Studies’ (ULB) Date of submission: 10 August 2020 Acknowledgements I wish to express my gratitude to all the people who supported me during the realization of this project. Firstly, I am extremely thankful to my supervisor Bas van Heur, for guiding me through the definition of my RQs, for his availability, and his motivating recommendations. I would equally like to thank Agostino Zanotti, Carlo Cominelli, Paolo Erba, and Angelo Mazzù, for sharing with me their experiences and insights, giving a huge contribution to this research. My deepest appreciation goes to the whole MUS staff, for this wonderful opportunity and for everything I have learned. I sincerely want to thank all my MUS coursemates and Belgian friends too, who became my family abroad, and with whom I was lucky enough to share the perks and joys of these last two years, not least a semester of global pandemic. Finally, words will never be enough to thank my Italian family, friends, and Daniel: because you always believed in me and for being there, even with kilometers of distance. 1 Disclaimer This master's thesis came about (in part) during the period in which higher education was subjected to a lockdown and protective measures to prevent the spread of the COVID-19 virus. -

Milan Bergamo Airport Has Confirmed Its Position As THIRD Largest Italian Airport on the National Flown Freight Volume Ranking
Why is Milan/Bergamo an opportunity? Quick overview of our main characteristics • 4th airport in Italy for total passengers. Very close to 3rd position. • 3rd airport in Italy for total freight. Approaching 2nd position. • Very large and wealthy catchment area: strong concentration of companies and inhabitants. BGY airport is in the middle of the area with more based companies, more inhabitants, larger GDP than in the remaining part of Lombardy region. • Many passengers are repeaters, arriving from strong provinces such as Milan – Monza Brianza – Bergamo – Brescia. • Airport infrastructures and terminal in continuous expansion. • Particular care for business passengers: services available to suit their needs & preferences. PASSENGER TRAFFIC GROWTH 2002 – 2013: continuous growth in passengers volume 2014 AIRPORT 1 Roma FCO 2 Milano Malpensa MXP 3 Milan Linate LIN 4 Milano Bergamo BGY 5 Venezia VCE 6 Catania CTA 7 Bologna BLQ 8 Roma CIA 9 Palermo PMO 16th 8th 7th 6th 5th 4th 10 Bari BRI Position in the annual ranking of the Italian airports by passenger numbers 2014 saw a total of 8.774.256 passengers, down only 2% vs 2013, despite a 3 weeks period of total closure for runway reconstruction. Without such closure, the trend would have given us +3,5% vs 2013. CARGO TRAFFIC Third largest Italian airport for cargo traffic (data in tons) 160.000 140.630 140.000 136.339 134.449 128.687 130.974 122.398 123.206 117.005 116.112 120.000 114.720 112.556 106.921 100.354 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 During 2014 Milan Bergamo airport has confirmed its position as THIRD largest Italian airport on the national flown freight volume ranking. -
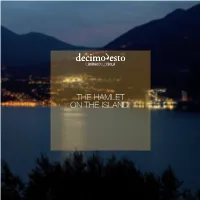
The Hamlet on the Island
ILBORGOSULL’ISOLA THE HAMLET ON THE ISLAND. 1 A stone’s throw from Milan, and in the heart of Lombardy, Lake Iseo is a tourist destination of surprising beauty, which in many ways remains still hidden from the masses. It has a discreet charm consisting of opposites and contrasts. The sweet natural beauty of the lake, the advanced technology of the sailing, the worldliness of the Millemiglia, ILBORGOSULL’ISOLA the tradition of Franciacorta, the organisation of the hospitality and, in the midst of all these, the peace and silence of Montisola AN EXCLUSIVE itself. Not a break but rather a destination goal for the visitors more OPPORTUNITY discerning about the authenticity of their travelling. IN MONTISOLA. Recognised as one of the “MOST BEAUTIFUL VILLAGES IN ITALY”, MONTISOLA is the heart of Lake Iseo. In its timeless atmosphere, the Old HAMLET OF SINCHIGNANO is reborn through an informed and traditional restoration. The noble splendour and humble crafts of the rural SIXTEENTH CENTURY are revived in the exclusive residential complex of the hamlet of DECIMOSESTO. A parenthesis in history and tradition that opens itself up to the land artist Christo. New visions and unusual communal lives in www.avraileisure.it the silence of the lake: the fishing nets and yellow towels of the artist, the wooden boats and the engineering of the yachts, the local olive oil and the sparkling wine of Franciacorta. All car-free and well-served. 5 ILBORGOSULL’ISOLA AN HISTORIC The MANOR HOUSE, with two floors inhabited by the nobles and an attic, for the servants, overlooks the ancient courtyard. -

Easychair Preprint Hosting Refugees in Mountain Areas As a New Form Of
EasyChair Preprint № 1011 Hosting Refugees in Mountain Areas as a new Form of Social Innovation Manfred Perlik EasyChair preprints are intended for rapid dissemination of research results and are integrated with the rest of EasyChair. May 25, 2019 Social and Solidarity Economy: Moving Towards a New Economic System 1 HOSTING REFUGEES IN MOUNTAIN AREAS AS A NEW FORM OF SOCIAL INNOVATION Manfred PERLIK Centre for Development and Environment, Univ. of Bern, CH-3012 Bern Laboratoire Pacte, Université de Grenoble/France, F-38100 Grenoble Mittelstrasse 43, CH-3012 Bern/Switzerland [email protected] Abstract “Social innovation“ has become a buzzword and sometimes it seems that it is the successor of the famous “best practices”. In fact it is sometimes hard to distinghuish what is really a social innovation.The presentation argues that hosting migrants in mountain areas is a real social innovation as it it is a statement against the current tendencies of isolation and xenophobia in Europe and may help in the long run to stabilize fragile municipalities and regions in its peripheral regions. In this sense, it could counteract increasing territorial cleavages between mountains and plains, and between rural and metropolitan areas. The paper presents three examples from the Italian Alps. Experiences from the other Alpine countries will be added in the oral presentation. The paper concludes that hosting migrants may be favourable for regions and migrants. The new situation may create a laboratory situation to develop new forms of cooperation -

City, Province, Emotions
CITY, PROVINCE, EMOTIONS One land, many facets. MUNICH Camonica Valley Lake Idro Trompia Valley Lake Iseo Sabbia Valley Lake Garda Venice VENICE 2 Table of contents 4 Art, history, and culture 6 Brescia city of art 8 Treasures in the province 10 The lake province 12 Elegant Lake Garda 14 The discreet charm of Lake Iseo 15 Pure nature: Lake Idro 16 Up on the summits 18 Mountain for children and adults 19 Sports, snow, fun 20 Ski resorts in Brescia’s mountains 22 Fun between lakes and mountains 25 Hiking, relaxation, via ferratas, and mountain huts 26 Golf and vineyard strolls 27 On the saddle! 28 Food & Wine excellence 30 Franciacorta and Brescia’s great wines 32 Starred Brescia 33 Typical and traditional products 34 Spa relaxation 36 Sirmione: wellness and beauty 37 Boario, Vallio, and Ponte di Legno spa centres 38 Business, crafts, and great events 40 Business meetings and congresses: a strategic hub 42 Great events 43 Sacred Ways: devotional itineraries and culture 43 Crafts, artisanal shops, traditions 44 Useful information 3 art, h story, and culture Discover this land’s treasures The fascinating mosaic of cultures, historical events, and ages of which the city of Brescia was a protagonist is the reason why there is a wealth of cultural sites visible in every corner of its old centre and its province. Piazza della Loggia 4 5 Brescia city of art A stratified city From the Bronze Age to the skyscrapers symbolising today’s entrepreneurial spirit, passing from the time where Brescia was a religious and economic capital under the Cenomani Gauls and the Romans, the Lombard domination, and Charlemagne’s Franks. -

Contraints for an Interpretation of the Italian Geodynamics: a Review Vincoli Per Una Interpretazione Della Geodinamica Italiana: Una Revisione
Mem. Descr. Carta Geol. d’It. LXII (2003), pp. 15-46 16 figg. Contraints for an interpretation of the italian geodynamics: a review Vincoli per una interpretazione della geodinamica italiana: una revisione SCROCCA D. (1), DOGLIONI C. (2), INNOCENTI F. (3) ABSTRACT - To properly frame the seismic data acquired RIASSUNTO - Per un opportuno inquadramento dei dati with the CROP Project, the geophysical and geological charac- sismici acquisiti nell’ambito del Progetto CROP negli ultimi anni, teristics of the Italian region and a review of magmatism are vengono sinteticamente descritte le principali caratteristiche geo- briefly illustrated and commented. fisiche, magmatologiche e geologiche della regione italiana. A description of the crustal and lithospheric structure is Le informazioni disponibili sulle struttura crostale e lito- coupled with a synthesis of the available geophysical data sets, sferica sono accompagnate da una sintesi dei dati relativi alle namely: Bouguer gravity anomalies, heat flow data, magnetic anomalie gravimetriche di Bouguer, al flusso di calore, alle ano- anomalies, seismicity, tomography and present-day stress field. malie magnetiche, alle caratteristiche sismologiche e al campo Several magmatic episodes with different geodynamic signifi- di stress attuale. cance occurred in Italy. A review of magmatism in the Alps Inoltre, viene fornita una panoramica degli eventi magma- and in the Apennines is provided; igneous products are distin- tici che hanno caratterizzato la complessa evoluzione geodina- guished, in the Tyrrhenian and circum-Tyrrhenian region, in mica della regione in esame. Una particolare attenzione è stata relation with the nature of the dominant magmatic source. dedicata al magmatismo della regione tirrenica e circum-tirre- Finally, the tectonic evolution of the Alps and the Apen- nica; i prodotti ignei sono stati distinti in relazione alla natura nines is synthesised together with a comparison of the main della sorgente magmatica dominante. -
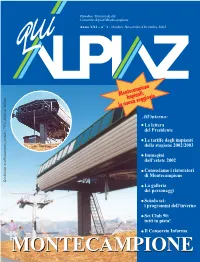
Montecampione Montecampione
Periodico Trimestrale del Consorzio Alpiaz Montecampione Anno XXI - n° 3 - Ottobre-Novembre-Dicembre 2002 Montecampione Impianti: la nuova seggiovia All'interno: La lettera del Presidente Le tariffe degli impianti della stagione 2002/2003 Immagini dall’estate 2002 Conosciamo i ristoratori di Montecampione Spedizione in abbonamento postale - 70%- filiale di Milano La galleria dei personaggi Scuola sci: i programmi dell’inverno Sci Club 90: tutti in pista! Il Consorzio Informa MONTECAMPIONEMONTECAMPIONE Percorso Vita ARRIVO PARTENZA La lettera del Presidente tutti i Montecampionesi, siamo oramai giunti al termine dell’anno e siamo in attesa di una stagione A invernale che tutti ci auguriamo finalmente piena di neve e di soddisfazioni. È quindi tempo di consuntivi, ed è soprattutto giunto il momento di esporvi in Periodico trimestrale del estrema sintesi il resoconto di quei programmi che ho cercato di impostare nel Consorzio Alpiaz Montecampione corso di quest’anno e che inevitabilmente costituiranno la guida per l’attività dei 25040 ARTOGNE (Brescia) prossimi anni. www.consorzioalpiaz.it Nel momento in cui ho assunto la responsabilità del Consorzio ho fatto una Anno XXI - n. 3 Ottobre-Novembre-Dicembre 2002 analisi della situazione in cui si trovava Montecampione ed ho ripercorso gli ultimi 25 anni vissuti in questa stazione, facendone argomento di discussione con Direttore Responsabile e Redattore il Consiglio. FRANCO MANENTI Mi sono reso conto che si era arrivati ad un bivio e che era necessario scegliere una strategia chiara e decisa che potesse portare Montecampione fuori da quella Autorizzazione del Tribunale di Brescia stagnazione in cui la nostra stazione si trova oramai da anni. -
Migration by Necessity and by Force to Mountain Areas
Mountain Research and Development (MRD) MountainAgenda An international, peer-reviewed open access journal Target knowledge published by the International Mountain Society (IMS) www.mrd-journal.org Migration by Necessity and by Force to Mountain Areas: An Opportunity for Social Innovation Manfred Perlik1,2* and Andrea Membretti3 * Corresponding author: [email protected] 1 Centre for Development and Environment, University of Bern, Mittelstrasse 43, 3012 Bern, Switzerland 2 Pacte, Laboratory of Social Sciences, University of Grenoble, 14bis Avenue Marie Reynoard, 38100 Grenoble, France 3 Department of Civil Engineering and Architecture, University of Pavia, Sociology of the Territory, Via Ferrata 5, 27100 Pavia, Italy Ó 2018 Perlik and Membretti. This open access article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (http:// creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Please credit the authors and the full source. This article discusses current European migration flows, their that can contribute to the future of the entire Alpine economic impacts on the European Alps, and future options for space. Rather than focusing on drivers of migration or its addressing issues of migration. It explores these issues from the humanitarian or constitutional aspects, the paper explores the perspective of regional development, taking into account the potential benefits to all parties of a better integration of currently prevailing goals of economic competitiveness and migrants into the host regions, and the possibility that this could local self-interest. It focuses on the Alps, a region in which rural become a model of social innovation. It suggests an agenda for areas are losing economic, demographic, and decision-making research on how to reach this potential and agenda points for power due to outmigration. -

Consorzio- Msa Li Vuole Portare
I COMMERCIANTI ORMAI HANNO CAPITO DOVE QUESTA UNIONE COMUNI –CONSORZIO- MSA LI VUOLE PORTARE Montecampione deve uscire dall'asfissia in cui l'ha ridotta l'esistenza di questo Consorzio gestito dai Comuni attraverso i collaborazionisti : anche i commercianti sono oramai esausti. La riunione chiamata COMITATO CONSULTIVO, convocata dai collaborazionisti del Consorzio per rifare ALPIAZ e per rifinanziare ancora una volta MSA, ora con i soldi dei commercianti, poi con quelli dei consorziati, ha avuto esito finalmente positivo per Montecampione : È STATA UN GRANDE FLOP ! E questo FLOP non poteva che essere constatato dal NUS (Nuovo Ufficio Stampa) che ha riconosciuto che i pochi presenti avrebbero riferito ai molti assenti, quelli che si sono rifiutati di partecipare... Nessuna relazione sugli interventi in sala, da parte del NUS, forse perché qualcuno ha ricordato che a suo tempo è stata presentata anche una alternativa alla MSA, e senza costi, perchè l’imprenditore avrebbe gestito la società con capitali propri... ed era veramente e professionalmente interessato solo alla gestione degli impianti. Cosa dovrebbero dunque riferire i pochi presenti ai tanti assenti ? Che Daminelli e la controfigura che non debbono pagare affitti, non debbono pensare a mettere insieme gli stipendi dei dipendenti (anzi, loro ci prendono pure lo stipendio per stare lì), loro, che vengono a Montecampione come villeggianti da quando erano bambini nelle case di genitori e parenti, si permettono ora di insegnare ai commercianti, cosa debbano fare ! A loro che, ogni giorno che viene, temono di non potercela più fare, proprio perché lorsignori vogliono PER SÉ e per la loro "politica" del cortiletto, Montecampione PAESE FANTASMA, che vede gente solo per due brevi periodi all'anno.