Vallagarina»
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
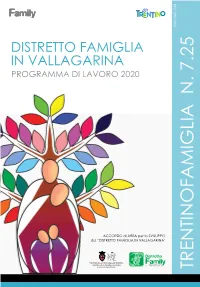
Programma Distretto Vallagarina 2020 Web
Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili PROGRAMMA DI LAVORO DISTRETTO FAMIGLIA VALLAGARINA 2020 Determinazione del Dirigente n. 171 di data 19 giugno 2020 Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità", art. 16: Trentino "Distretto per la famiglia". Accordo di area per lo sviluppo del "Distretto famiglia nella Vallagarina". Approvazione del Programma di lavoro per l'anno 2020. __________________________________________________________________________________________________________________________________ Programma di lavoro Distretto Famiglia Vallagarina 1 Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili Provincia Autonoma di Trento Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili Luciano Malfer Via don G. Grazioli, 1 - 38122 Trento Tel. 0461/ 494110 – Fax 0461/494111 [email protected] – www.trentinofamiglia.it A cura di: Francesca Cenname, Enrica Zandonai, Debora Nicoletto, Chiara Sartori Impaginazione a cura di: Chiara Sartori (tsm-Trentino School of Management) Copertina a cura di: Lorenzo Degiampietro Stampato dal Centro Duplicazioni della Provincia autonoma di Trento nel mese di LUGLIO 2020. __________________________________________________________________________________________________________________________________ Programma di lavoro Distretto Famiglia Vallagarina 2 Provincia autonoma -

Comunità Della Vallagarina
Comunità della Vallagarina Comuni di Rovereto, Ala, Avio, Mori, Pomarolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano Provincia autonoma di Trento Assessorato alla Cultura Regione autonoma Trentino-Alto Adige Autonome Region Trentino-Südtirol Compagnia di Lizzana Quarantunesima Rassegna Fabio e Alberta Barberi Co.F.As. Compagnie Filodrammatiche Associate festival nazionale di teatro amatoriale 3/02 - 23/03 2018 Comunità della Vallagarina Provincia autonoma di Trento Regione autonoma Trentino - Alto Adige Autonome Region Trentino - Südtirol Comune di Rovereto Comune di Ala Comune di Avio Comune di Mori Comune di Pomarolo Comune di Trambileno Comune di Vallarsa Comune di Villa Lagarina Comune di Volano DNA TRENTINO Scegli Altemasi, bevi responsabilmente. bevi Altemasi, Scegli ALTEMASI, SPUMANTI TRENTODOC. Tradizione, competenza enologica e territorio vocato: ecco il segreto di una gamma completa e di pregio. Altemasi Riserva Graal, Millesimato, Rosé, Pas Dosé: quattro piaceri diversi, uniti da una firma che significa Trentino. 3893_CA_Altemasi_DNA_160X240.indd 1 01/12/16 11:49 Quarantasei serate di spettacolo in quattordici Teatri della Vallagarina: a Rovereto, Lizzana, Ala, Serravalle, Avio, Sabbionara, Mori, Pomarolo, Trambileno, Vallarsa, Castellano, Pedersano, Volano e, novità di quest’anno, Pannone. Un Concorso Nazionale e un Concorso Regionale che al Teatro Zandonai di Rovereto e al Teatro San Floriano di Lizzana mettono a confronto rispettivamente cinque tra le migliori Compagnie italiane di prosa amatoriale e cinque tra quelle del Trentino-Alto Adige, selezionate tra oltre cento domande di partecipazione giunte da tutto il Paese. Un Circuito che negli altri Comuni del territorio, e in collaborazione con la Co.F.As., esprime il meglio del Teatro popolare trentino. DNA TRENTINO Il tutto seguito da un pubblico in costante crescita che nella scorsa edizione ha superato le dodicimila presenze. -

7 /0 3 Le M E to C a Tu Tte 29 O Ne Sti Se N a Sse , Furb I Se De Ven Ta 15 E N C
Comunità festival nazionale della Torna, con numeri importanti, la rassegna di teatro amatoriale Sipario d’Oro. sipariodoro.it Vallagarina 47 serate di spettacolo in 14 teatri della Vallagarina: a Rovereto, Lizzana, Ala, di teatro amatoriale Serravalle, Avio, Sabbionara, Mori, Pomarolo, Trambileno, Vallarsa, Castellano, Pedersano, Volano e, novità di quest’anno, Noarna. 12 mila le presenze dello scorso anno a confermare un trend in continua crescita. Il Sipario è un contenitore di più eccellenze: un Concorso Nazionale e un Concorso Regionale che al Teatro Zandonai di Rovereto e al Teatro San Floriano di Lizzana mettono a confronto rispettivamente cinque tra le migliori Compagnie italiane di prosa amatoriale e quattro tra quelle del Trentino- Alto Adige, selezionate tra oltre cento domande di partecipazione giunte da tutto il Paese. ABBONAMENTO Questo in sintesi il Sipario d’Oro. Un omaggio a una delle più belle espressioni dell’Arte popolare qual è appunto il Teatro amatoriale. Quattro spettacoli nei Teatri di Avio e Sabbionara 24 € Da molti anni il Sipario d’Oro non solo allieta gli spettatori ma è anche palestra di crescita culturale dell’individuo e della comunità. È rapporto diretto, vivo, In vendita presso la AL MART CON autentico dell’Arte scenica con gli spettatori. È ricchezza di testi e autori Filodrammatica I Rusteghi IL SIPARIO D’ORO che spaziano nei vari generi della prosa: classica e contemporanea, locale di Avio 338 5992840 e la Gli abbonati del Festival e internazionale. È senza età perché coinvolge giovani e meno giovani. Cassa Rurale Vallagarina - hanno diritto all’ingresso È prezioso perché arriva nelle comunità più piccole e decentrate. -

Ex-Post Evaluation of the Common Market
Ex-post evaluation of the Common Market Organisation for wine Annex Prepared for: European Commission - DG Agriculture Tender AGRI / EVALUATION / 2002 / 6 This study has been financed by the Commission of the European Communities. The conclusions, recommendations and opinions presented in this report reflect the opinion of the consultant and do not necessarily reflect the opinion of the Commission. Innova SpA Via della Scrofa 117 00186 Rome Italy Tel. +39 06 68803253 Fax +39 06 68806997 Tender AGRI/EVALUATION/2002/6 Final Report- Annex CONSORTIUM INNOVA SpA (Italy) – Coordinator Mr Aleardo Furlani, Ms Rebeca Lucas, Ms Valentina Gentile EUROQUALITY (France) Mr Olivier Chartier, Mr Marc Ponsar Fundación para el Desarollo de la Ciencia y Tteconología en Extremadura (FUNDECYT) (Spain) Mr Carlos Cabo, Ms Manon van Leeuwen FORSCHUNGSANSTALT GEISENHEIM (Germany) Dr Dieter Hoffmann, Dr Karl-Heinz Bock, Dr Jana Seidemann SPI SA (Portugal) Mr Pedro Vieira, Mr Douglas Thompson PHYTOWELT GMBH (Germany) Mr Peter Welters HTTC (Greece) Mr Kyriakos Loukakis Mr JOHN MALCOLM – Consultant (UK) Internal Page 2 / 479 Tender AGRI/EVALUATION/2002/6 Final Report- Annex TABLE OF CONTENTS 2. INTRODUCTION .......................................................................................... 21 3. ANNEX TO CHAPTER 2 (OVERVIEW OF THE WINE MARKET) .... 21 3.1. The wine market – overview of key developments .......................................................................21 3.2. Market situation: macro-economic trends with special focus on table wine markets...............25 -

1 Proposta Regolamento Per L'utilizzo Di Prodotti Fitosanitari in Prossimità
Proposta regolamento per l’utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità delle aree sensibili in Vallagarina. Il lavoro sul “Regolamento per l’utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità delle aree sensibili”, trae origine dal Protocollo firmato il 13 luglio 2013 tra la Provincia Autonoma di Trento, Assessorato all’Agricoltura , i Sindacati agricoli e la nostra Comunità nel luglio 2013 , a seguito del quale abbiamo costituito il Tavolo dell’Agricoltura con l’adesione dei sindacati- associazioni agricole e della Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal dr Federico Bigaran. Il Tavolo individuò, quale azione prioritaria, il tentativo di omogeneizzare i regolamenti comunali vigenti in Vallagarina, stante il fatto che, siamo agli inizi del 2014, stava entrando in vigore il Nuovo Piano Azione Nazionale. Informammo dell’iniziativa ed ottenemmo il consenso a procedere da parte della Conferenza dei Sindaci. Da subito consultammo ed incontrammo i massimi esperti in materia di tutti i servizi e strutture pubbliche operanti in Trentino (oltre alla Pat, in tutti i suoi servizi, FEM, Apss, Appa, ecc) per avere il loro parere e contributo scientifico sul come procedere. Ricevemmo apprezzamento ed un invito a proseguire perché queste figure ed istituzioni avevano constatato che in Vallagarina c’erano le condizioni per sperimentare un qualcosa che poteva poi servire anche in altre zone del Trentino. Nell’aprile del 2014 convocai il tavolo Agricoltura, allargato ai rappresentanti dei Comuni della Vallagarina ed alle associazioni degli apicoltori , da cui scaturì la decisione unanime di valorizzare e partire dalla esperienza dei Comuni della Destra Adige,che avevano già elaborato un regolamento unitario, e si potè da subito contare sul prezioso e fondamentale contributo degli specialisti dei vari organismi provinciali in materia. -

Agritourism Activity—A “Smart Chance” for Mountain Rural Environment's
sustainability Article Agritourism Activity—A “Smart Chance” for Mountain Rural Environment’s Sustainability Ramona Ciolac *, Tiberiu Iancu *, Ioan Brad, Gabriela Popescu *, Diana Marin and Tabita Adamov * Faculty of Management and Rural Tourism, Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania”, Calea Aradului no.119, 300645 Timis, oara, Romania; [email protected] (I.B.); [email protected] (D.M.) * Correspondence: [email protected] or [email protected] (R.C.); [email protected] (T.I.); [email protected] (G.P.); [email protected] (T.A.) Received: 14 June 2020; Accepted: 31 July 2020; Published: 3 August 2020 Abstract: The debates regarding sustaining the rural world by improving the quality of life are numerous; one of the proposals being agritourism activity. This activity can be a “smart chance” for the sustainability of the mountain rural environment, because it has a multiplier effect on some important parts of economic and social life of the community. For instance, it can be an ally of agriculture, ensuring a diversification alternative for farms, an alternative for local guesthouses to capitalize their own local products, while ensuring the opportunity to obtain additional/complementary income, a possibility of adjusting the depopulation phenomenon and the abandonment of old houses and lands, at the same time offering a pleasant activity/alternative, especially for young people. In this context, the purpose followed in the paper is oriented through the transposition of agritourism activity into a “smart chance” for ensuring rural mountain sustainability. Being simultaneously an innovative and diversifying alternative, it is an actual one that starts from the study of two areas which are similar in terms of tourist potential. -

Local Institutions, Cooperative
AIEAA Conference 2013 Parma, 6‐7 June 2013 Between Crisis and Development: Which Role for the Bio‐Economy Organised Session 3 Agricultural and agro‐food local systems: is the territory a key resource to face the economic crisis? LOCAL INSTITUTIONS, COOPERATIVE SYSTEMS AND EXPORTS IN THE Sonia Marongiu National Institute of Agricultural Economics APPLE LOCAL Trentino Alto Adige DISTRICT IN [email protected] TRENTINO ALTO ADIGE Historical importance Description of the area Importance of the fruit growing sector in Trentino Characteristics of the farms The importance of Cooperation Scheme of the system of apple production Remarks The cultivation of apple in Trentino Alto Adige is documented by historical evidences: Toponyms (Malè, Malosco, Pomarolo, etc.) Carte di Regola (1564 Villa Dardine, 1641 Cles) Commerce with Austria and Russia in XVI century Starting from XIX century the general organization of agricultural sector changed: 1874: foundation of the Institute of San Michele all’Adige 1888: the fruit growers won the first prize in the Empire Fruit Exhibition in Vienna 1895: foundation of a Society for the fruit trade middle of ‘900: reinforcement of the Cooperative system, introduction of new varieties (for instance Renetta del Canada) and new cultivation techniques. Area of PDO “Mela Val di Non” (Reg. EC 1665/2003) Consortium Melinda Golden Delicious, Renetta Canada, Red Delicious 55 Municipalities 1,256 km2 (20% of the provincial territory) 57,621 inhabitants in 2011 (+6.4% over 2009; 11% of the population) 1 inhabitant in 14 has a farm (1 in 58 in the rest of province) UAA 30,323 ha (7,275 ha of fruit; 59% the apple surface) 2,800 farmers : 2,500 are fruit growers of whom 90% produce apples Other productive areas are located in Valle dell’Adige, Valle di Cembra, Valsugana, Vallagarina, Valle del Sarca e Lomaso. -

Elenco Codici Varietà Vitigni
Via Adriatica Foro, 7 Eno Tecno Chimica 66024 FRANCAVILLA AL MARE (CH) Tel. 085-816903 – Fax. 085-816193 Laboratorio Enochimico Autorizzato MIPAF P..IVA.: 00339500696 Enologo Anselmo Paternoster e-mail. [email protected] http://www.enotecnochimica.it Elenco delle Varietà per la sezione - I - Vitigni ad Uve da Vino Codici delle varietà 1 ABBUOTO N. 55 CARRICANTE B. 2 AGLIANICO N. 56 CASTIGLIONE N. 3 AGLIANICONE N. 57 CATANESE NERO N. 4 ALBANA B. 58 CATARRATTO BIANCO COMUNE B. 5 ALBANELLO B. 59 CATARRATTO BIANCO LUCIDO B. 6 ALBARANZEULI BIANCO B. 60 CESANESE COMUNE N. 7 ALBARANZEULI NERO N. 61 CESANESE D'AFFILE N. 8 ALBAROLA B. 62 CILIEGIOLO N. 9 ALEATICO N. 63 CLAIRETTE B. 10 ALICANTE N. 64 COCOCCIOLA B. 11 ALICANTE BOUSCHET N. 65 CODA DI VOLPE BIANCA B. 12 ANCELLOTTA N. 66 COLOMBANA NERA N. 13 ANSONICA B. 67 COLORINO N. 14 ARNEIS B. 68 CORINTO NERO N. 15 ARVESINIADU B. 69 CORTESE B. 16 ASPRINIO BIANCO B. 70 CORVINA N. 17 AVANA’ N. 71 CROATINA N. 18 AVARENGO N. 72 DAMASCHINO B. 19 BARBERA N. 73 DOLCETTO N. 20 BARBERA BIANCA B. 74 DOLCIAME B. 21 BARBERA SARDA N. 75 DOUX D’HENRY N. 22 BARSAGLINA N. 76 DURASA N. 23 BELLONE B. 77 DURELLA B. 24 BERVEDINO B. 78 ERBALUCE B. 25 BIANCAME B. 79 FALANGHINA B. 26 BIANCHETTA GENOVESE B. 80 FAVORITA B. 27 BIANCHETTA TREVIGIANA B. 81 FIANO B. 28 BIANCO D’ALESSANO B. 82 FOGLIA TONDA N. 29 BIANCOLELLA B. 83 FORASTERA B. 30 BIANCONE B. 84 FORTANA N. 32 BOMBINO BIANCO B. -

“Biglietto Da Visita” ® Calliano Calliano
Calliano “Biglietto da visita” ® Calliano Calliano La Giunta Comunale Sindaco: Marco Pompermaier Assessore: Romano Panizza Incarichi: Personale, Bilancio, Incarichi: Cultura, Istruzione, Sport, Finanze, Cantiere comunale, Sanità e Assistenza Affari generali, Patrimonio, Servizi, Recapiti: Cell. 335 8388106 Vigili del Fuoco Volontari E-mail: [email protected] Recapiti: Cell. 338 7057282 E-mail: [email protected] Vicesindaco: Cristian Marchelli Assessore: Stefano Battisti Incarichi: Urbanistica, Ambiente Incarichi: Ordine pubblico e Sicurezza, Recapiti: Cell. 347 7811376 Viabilità e Trasporti, Arredo urbano e Turismo E-mail: [email protected] Recapiti: Cell. 392 6940216 Assessore: Romeo Carpentari Consigliere con delega: Gabriele Battisti Incarichi: Lavori pubblici Incarichi: Attività economiche Recapiti: Cell. 335 7422143 Recapiti: Cell. 3355292088 Il Sindaco riceve tutti i lunedì o su appuntamento Il Vicesindaco, gli Assessori e il Consigliere con delega ricevono tutti i lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 o su appuntamento “La Collana di guide dei Paesi del Trentino”. “Biglietto da visita ®” è edita e stampata da Grafiche Dalpiaz srl - 38040 Ravina di Trento (TN) - Via Stella 11/b - Tel. 0461 913545 - www.grafichedalpiaz.com Calliano Calliano Numeri ed indirizzi utili Municipio: tel. 0464 834116 - fax 0464 834075 Scuola Materna: tel. 0464 834429 Centralino: tel. 0464 834116 Forze di polizia sovra comunali: tel. 0464 484227 - fax 0464 424748 Comprensorio: tel. 0464 484211 Carabinieri: via Marconi, 10 - tel. 0464 834114 Municipio: tel. 0464 834116 - fax 0464 834075 Carabinieri Pronto Intervento: 112 Biblioteca: tel. 0464 834116 - fax 0464 834075 Vigili del Fuoco: via Garibaldi, 9 - tel. 0464 835511 Farmacia: via Valentini, 15 - tel. 0464 834118 V.V.F. Pronto Intervento: 115 Canonica (padre Mario Pangallo): via Valentini, 15 - tel. -

Schema Di STATUTO Della
Schema di STATUTO della CASSA RURALE VALLAGARINA Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa Società cooperativa a mutualità prevalente ASSEMBLEA STRAORDINARIA - 25 novembre 2018 1 TITOLO I Costituzione – Denominazione e Scopo Mutualistico – Appartenenza al Gruppo Bancario Cooperativo ed Assoggettamento alla Direzione e Coordinamento della Capogruppo – Princìpi Ispiratori – Sede – Competenza Territoriale – Durata Art. 1 Denominazione. Scopo mutualistico 1.1 E’ costituita una società cooperativa per azioni denominata “Cassa Rurale Vallagarina – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa”, di seguito definita anche la “Società”. La Cassa Rurale Vallagarina è una società cooperativa a mutualità prevalente. 1.2 Essa è la continuazione della Cassa Rurale Bassa Vallagarina, della Cassa Rurale degli Altipiani e della Cassa Rurale di Isera. Art. 2 Princìpi ispiratori 2.1. Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai princìpi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci cooperatori (i “Soci Cooperatori” e, singolarmente il “Socio Cooperatore”; congiuntamente ai Soci Finanziatori, come definiti all’articolo 24.3, i “Soci” e, singolarmente, il “Socio”), e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. 2.2. La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con i princìpi e le linee guida della cooperazione trentina e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico- finanziaria e lo scambio mutualistico tra i Soci Cooperatori nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale. -

E-Commerce and Italian Wine: Can They Match Successfully? a Mystery Shopping Analysis
Master's Degree programme in International Management (D.M. 270/2004) Final Thesis E-commerce and Italian Wine: can they match successfully? A Mystery Shopping analysis Supervisor Ch. Prof. Marco Valentini Graduand Alice Facchinello Matriculation Number 833410 Academic Year 2015 / 2016 Index Abstract ............................................................................................................................................................. 1 CHAPTER 1 – Introduction .............................................................................................................................. 3 1.1 Changes and New Opportunities .......................................................................................................... 3 1.2 Italy: Unexplored Fields in Wine Market and E-Commerce ............................................................... 4 1.3 What will be discussed in the Next Chapters....................................................................................... 6 Suppliers ................................................................................................................................................... 6 Consumers ................................................................................................................................................ 7 Research ................................................................................................................................................... 7 CHAPTER 2 – The Taste of Italian Wine ........................................................................................................ -

N.88 Agosto 2020 Incontro
ANNO XXII N.88 AGOSTO 2020 INCONTRO EDITORIALE NOVITÀ IN CASSA I NOSTRI CONSULENTI ANALISI 16 Il nuovo ATM di Luserna 27 Bonus vacanze: come funziona? IN PRIMO PIANO La Cassa presente ai webinar 17 sui territori NEWS COOPERATIVE LOCALI L’Assemblea sociale 2020 Lezioni di musica a distanza 4 Il rimborso delle spese POS 28 con la Jan Novak! 18 ai commercianti 6 Premi allo studio Estate in compagnia con la CASSA CENTRALE 29 cooperativa “La Tata” 10 San Pietro in Cariano e Verona La dipendenza da gioco 24 Cassa Centrale in Assemblea ITINERARI 12 d’azzardo SPAZIO ASSeT 30 La Fucina Cortiana di Ala I NOSTRI PRODOTTI Seminari online per giovani 26 soci ed associazioni DAL TERRITORIO 14 Logo Green La Finestra, uno sguardo sul 36 territorio - Speciale Covid Editrice: Hanno collaborato: Michele Zagni, In copertina: Cassa Rurale Vallagarina Lara Campostrini, Monica Zambelli Villa Gresti nella Tenuta San Leonardo Andrea Cazzanelli, Avio (TN) Foto: Mauro Fermariello Direttore responsabile: Stefania Degasperi, Segreteria di redazione: Walter Liber Adriano Deimichei, Ufficio Relazioni Istituzionali Iscrizione registro stampa: Giuliano Deimichei, Cassa Rurale Vallagarina Tribunale di Rovereto n° 205 del 29/12/1995 Coordinatore: Andrea Fracchetti, Tel. 0464 678223 Serena Zomer Raffaello Gregori, Stampa e progettazione grafica: Luisa Pachera, Grafiche Fontanari Redazione: Alberto Poli, S. Margherita di Ala (TN) Cecilia Cavagna, Monica Sadler, Anita Dellai Andrea Tita, Sara Valle, Primo Vicentini, www.crvallagarina.it LA CELLULOSA PER LA PRODUZIONE DI QUESTA RIVISTA È SBIANCATA SENZA L’UTILIZZO DI CLORO (ECF) EDITORIALE Solidità e adattamento ella documentazione messa a di- nuove strategie anche grazie all’utilizzo sposizione in preparazione all’As- delle tecnologie, e un po’ tutti abbiamo Nsemblea, che abbiamo dovuto svol- scoperto qualcosa di nuovo e positivo che gere – ahimè – senza la partecipazione ci porteremo anche in seguito.