Ambito 10. Chianti
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Passion for Cycling Tourism
TUSCANY if not HERE, where? PASSION FOR CYCLING TOURISM Tuscany offers you • Unique landscapes and climate • A journey into history and art: from Etruscans to Renaissance down to the present day • An extensive network of cycle paths, unpaved and paved roads with hardly any traffic • Unforgettable cuisine, superb wines and much more ... if not HERE, where? Tuscany is the ideal place for a relaxing cycling holiday: the routes are endless, from the paved roads of Chianti to trails through the forests of the Apennines and the Apuan Alps, from the coast to the historic routes and the eco-paths in nature photo: Enrico Borgogni reserves and through the Val d’Orcia. This guide has been designed to be an excellent travel companion as you ride from one valley, bike trail or cultural site to another, sometimes using the train, all according to the experiences reported by other cyclists. But that’s not all: in the guide you will find tips on where to eat and suggestions for exploring the various areas without overlooking small gems or important sites, with the added benefit of taking advantage of special conditions reserved for the owners of this guide. Therefore, this book is suitable not only for families and those who like easy routes, but can also be helpful to those who want to plan multiple-day excursions with higher levels of difficulty or across uscanyT for longer tours The suggested itineraries are only a part of the rich cycling opportunities that make Tuscany one of the paradises for this kind of activity, and have been selected giving priority to low-traffic roads, white roads or paths always in close contact with nature, trying to reach and show some of our region’s most interesting destinations. -

La Toscana Dei Boschi
Regione Toscana Fondazione Giunta Regionale S. Giovanni Gualberto La Toscana dei boschi estratto dal volume “Attraverso le regioni forestali d’Italia” Millenario di S. Giovanni Gualberto Patrono dei Forestali d’Italia EDIZIONI VALLOMBROSA 2000 INDICE Presentazione ......................................................... Pag. 5 La Toscana dei boschi ............................................ « 9 La trasformazione del paesaggio forestale ............... « 10 I toponimi ............................................................. « 31 Il bosco e l’arte....................................................... « 42 Il clima .................................................................. « 56 I suoli .................................................................... « 62 La fauna selvatica................................................... « 67 Tre miliardi e mezzo di piante................................ « 72 La vegetazione forestale e i tipi di bosco ................. « 81 Tra le foreste più note: dall’Alpe al litorale ............. « 88 Lotta agli incendi e alle altre cause avverse ............. « 108 L’economia, l’occupazione, i prodotti silvani.......... « 116 La legislazione........................................................ « 121 Selvicoltura negli ultimi decenni ............................ « 125 I boschi di domani................................................. « 130 Bibliografia ............................................................ « 135 3 a cura di: A.A. Hofmann - D. Perulli Hanno collaborato: M. Agnoletti - ARSIA -

Suppl. N. 190 Alla Parte II
Anno L Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Seconda n. 44 del 28.10.2020 Supplemento n. 190 mercoledì, 28 ottobre 2020 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620 E-mail: [email protected] Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avvie- ne di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate. L’accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo. Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpre- tazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdi- zionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali. Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Or- gani la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale. Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l’attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. -

PRIMARIE 2012 25 NOVEMBREE DALLA 8 ALLE 20** ABBADIA SAN SALVATORE Via Adua, 9 * ASCIANO Saletta Comunale, Via Mameli (Sezioni Elettorali N
PRIMARIE 2012 25 NOVEMBREE DALLA 8 ALLE 20** ABBADIA SAN SALVATORE Via Adua, 9 * ASCIANO Saletta comunale, Via Mameli (sezioni elettorali n. 1, 2, 3 e 6)* Centro Sociale "Asciano Scalo", Via Martiri della Libertà 53 (sezione elettorali n. 4 e 5) Palestra, Viale Toscana, Arbia (sezioni elettorali n. 7 e 8) BUONCONVENTO Casa del Popolo* CASOLE D'ELSA Casole, Sede Pd, via Casolani (sezioni elettorali n. 1 e 2)* Pievescola, Centro polivante* Monteguidi, circolo Arci* Mensano, saletta casolani* Cavallano, saletta centro civico CASTELLINA IN CHIANTI Circolo Sangallo, Via Trento e Trieste, 58* CASTELNUOVO BERARDENGA Castelnuovo paese, Società Filarmonica, Piazza della Citerna 4 (sezioni elettorali n. 1, 2 e 3)* Casetta - Sede Pd, Via Peruzzi, 13 (sezione elettorale n. 4) Pianella - Piscina Comunale (sezioni elettorale 5 e 6) VAGLIAGLI - Sala polisportiva, ex scuola, Via Senese (sezione elettorale n. 7) Quercegrossa - Sede Misericordia, Via Del Chianti Classico, 5 (sezione elettorale 8) CASTIGLIONE D'ORCIA Castiglion d'Orcia, Sede Proloco, Viale Marconi, 13 (sezione elettorale n. 1 e 4)* Campiglia, Centro Civico Via Fiume (sezione elettorale n. 2) Gallina, campo sportivo, via colombaio Vivo d'Orcia, scuola materna via 4 novembre (sezione elettorale n. 3) CETONA circolo pd, Piazza Arnolfo (sezioni elettorali n. 1 e 2)* Le Piazze, Circolo Arci Via della Resistenza (sezione elettorale n. 3) CHIANCIANO TERME Sede pd, Via Dante Alighieri* CHIUSDINO Chiusdino, Palestra ex scuola media (sez. elettorale n.1)* Palazzetto, Circolo Arci, Via Massetana (sez. elettorale n. 2) Ciciano, Circolo Arci, Via Massetana 9 ( sez. elettorale n. 4) Frassini, Circolo Arci ( sez. elettorale n. 5) Montalcinello, Circolo Unitario, Via Ugo Mancini ( sez. -

ELENCO ACCOMPAGNATORI TURISTICI DI SIENA COGNOME NOME INDIRIZZO PROV. Alekseyenko Iryna Via Uopini, 10 Monteriggioni SI Alfieri
ELENCO ACCOMPAGNATORI TURISTICI DI SIENA CITTA' COGNOME NOME INDIRIZZO (di Residenza) PROV. Alekseyenko Iryna Via Uopini, 10 Monteriggioni SI Alfieri Veronica Via Umberto I°, 5 Piancastagnaio SI Alicia Andrea Loc. Monti 89 Gaiole in Chianti. SI Ambrosio Filomena Via Elia Mazzei, 34 Castelnuovo B.ga SI Amerighi Laura Montevarchi SI Angeli Pierluigi Via G. di Vittorio, 9 Chianciano Terme SI Angeletti Daniela Via Oslavia,105 Chiusi SI Ardenghi Daniela Via di Fontanella,21 Siena SI Aurigi Ilaria Via Alfieri, 23/B Castelnuovo B.ga SI Avanzati Alessandra Via Chianacce, 20 Montepulciano SI Azzalin Gianluca Piazza Nagj, 2 Poggibonsi SI Bacci Renato Via G..Matteotti 53 Volterra SI Baglioni Serena S.S. 146 Sud, 14 Montepulciano SI Baglioni Denise Loc. Terranera di Sotto, 172/A Subbiano (AR) Baiocchi Lisa Via Trento,48 Abbadia S.Salvatore SI Baldini Rita Via dello Spuntone, 2 Colle di Val D'Elsa SI Bandini Gaia Loc.Il Casalone Colle Val d'Elsa SI Bani Gloria Loc. Pancole, 19/A San Gimignano SI Baragli Viviana Località Sant'Andrea, 10 San Gimignano SI Barbagli Lisa Strada di Colle Pinzuto,52 Siena SI Barbetti Stefania Via Roma,2 Siena SI Barbetti Tiziana P.zza del Mercato 48 Siena SI Barbieri Gabriella Via dei Pispini,55 Siena SI Bardelli Federica Via Traversa Valdichiana Ovest , 62 Torrita di Siena SI Bardelli Sara Via Abruzzi, 20 Siena SI Bardelli Annalisa Via Leccetello, 53 Trequanda SI Bartalini Duccio P.zza G.Amendola.6 Siena SI Bartoli Francesca Via E.Fermi,14 Sinalunga SI Bassanelli Elisa Via Gallerani, 19 Siena SI Bastreghi Elena Via Lauretana Ovest, 1 Montepulciano SI Batelli Barbara Loc. -

Viva Xpress Logistics (Uk)
VIVA XPRESS LOGISTICS (UK) Tel : +44 1753 210 700 World Xpress Centre, Galleymead Road Fax : +44 1753 210 709 SL3 0EN Colnbrook, Berkshire E-mail : [email protected] UNITED KINGDOM Web : www.vxlnet.co.uk Selection ZONE FULL REPORT Filter : Sort : Group : Code Zone Description ZIP CODES From To Agent IT ITAOD04 IT- 3 Days (Ex LHR) Cities & Suburbs CIVITELLA CESI 01010 - 01010 CELLERE 01010 - 01010 AZIENDA ARCIONE 01010 - 01010 ARLENA DI CASTRO 01010 - 01010 FARNESE 01010 - 01010 LATERA 01010 - 01010 MONTEROMANO 01010 - 01010 ONANO 01010 - 01010 PESCIA ROMANA 01010 - 01010 PIANSANO 01010 - 01010 TESSENNANO 01010 - 01010 VEIANO 01010 - 01010 VILLA S GIOVANNI IN TUSC 01010 - 01010 MUSIGNANO 01011 - 01011 CELLENO 01020 - 01020 CHIA 01020 - 01020 CASTEL CELLESI 01020 - 01020 CASENUOVE 01020 - 01020 GRAFFIGNANO 01020 - 01020 LUBRIANO 01020 - 01020 MUGNANO 01020 - 01020 PROCENO 01020 - 01020 ROCCALVECCE 01020 - 01020 SAN MICHELE IN TEVERINA 01020 - 01020 SERMUGNANO 01020 - 01020 SIPICCIANO 01020 - 01020 TORRE ALFINA 01020 - 01020 TREVIGNANO 01020 - 01020 TREVINANO 01020 - 01020 VETRIOLO 01020 - 01020 ACQUAPENDENTE 01021 - 01021 CIVITA BAGNOREGIO 01022 - 01022 BAGNOREGIO 01022 - 01022 CASTIGLIONE IN TEVERINA 01024 - 01024 GROTTE SANTO STEFANO 01026 - 01026 MAGUGNANO 01026 - 01026 CASTEL S ELIA 01030 - 01030 CALCATA 01030 - 01030 BASSANO ROMANO 01030 - 01030 FALERIA 01030 - 01030 FABBRICA DI ROMA 01034 - 01034 COLLEMORESCO 02010 - 02010 COLLI SUL VELINO 02010 - 02010 CITTAREALE 02010 - 02010 CASTEL S ANGELO 02010 - 02010 CASTEL SANT'ANGELO 02010 -

From: 480,00 € the Permanent Route of L'eroica in 3 Stages Itinerary Day 1
PRICE PER PERSON IN DOUBLE ROOM TOUR LEVEL: FROM: 480,00 € AVID RIDER TOUR STYLE: DURATION: STANDARD SELF-GUIDED 5 DAYS/4 NIGHTS THE PERMANENT ROUTE OF L’EROICA IN 3 STAGES The Permanent Route of L'Eroica is a unique experience where you can live the adventure of L'Eroica all year round. The permanent route is long 209 km in the heart of the Terre di Siena region, through Chianti, Crete Senesi and Val d'Orcia. It’s a journey into the essence of the legendary Tuscan landscape, characterized by challenging and technical segments that make this route a great opportunity to practice cycling. The route alternates paved and gravel roads and has a total elevation gain around 3800 meters. Gravel roads cover approximately 112 km on 209 km. Your experience will be divided into three stages of around 70 km, the elevation gain achieved each day will be higher than 1100 meters. ITINERARY DAY 1 – “BENVENUTI IN TOSCANA” Individual arrival, dinner on your own and accommodation in 3 stars hotel located very close the city center of Siena. Siena is the perfect point to start the route of L'Eroica and offers a good connection with the largest cities, airports and train stations. At your arrival you will receive road book, maps and all the informations to complete the route of L'Eroica. HOTEL INCLUDED MEALS Hotel Breakfast DAY 2 – VAL D’ARBIA HILLS AND MONTALCINO 74 km – elevation gain: 1480 meters Just outside the city of Siena you’ll ride through a very typical segment of white road, located between “Colle Malamerenda” and Radi, deep in the gentle hills of Siena, studded of farmhouses, medieval villages, merging your ride with the Via Francigena itinerary. -

Comune Di Castelnuovo Berardenga
Data immissione 30.06.2004 Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA STATUTO Delibera n. 161 del 29/11/2001. ELEMENTI COSTITUTIVI Art. 1 Principi fondamentali 1. Il Comune di Castelnuovo Berardenga è ente autonomo locale il quale ha la rappresentatività generale della propria comunità nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento. 2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto. 3. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge. 4. Nell’ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie. 5. Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” è richiamato nel presente statuto con la formula “Testo Unico”. Art. 2 Finalità e funzioni 1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, secondo il principio di sussidiarietà. 2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’attività amministrativa. 3. Nell’ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni l’amministrazione comunale si impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie per consentire a entrambi i sessi di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale. -

Popolazione Delle Frazioni Geografiche E Delle Località Abitate Dei Comuni (20 Faseicoli 1'Egionali E Una Appenrliee Con Le Tavole Riassuntive) Voi
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 11° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 24 OTTOBRE 1971 VOLUME III POPOLAZIONE DELLE, FRAZIONI GEOGRAFICHE E DELLE LOCALITA ABITATE, DEI COMUNI FASCICOLO 9 TOSCANA ROMA - 1974 06 74 - Contratto del 20-12-1972 - (c. 1.400) - Soc. A.B E.T.E. - Roma INDICE AVVERTENZE . Pago V PROVINCIA DI MASSA-CARRARA TAVOLA 1 - Superficie territoriale e densità - Numero delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei - Popolazione residente per tipo di località abitata ......................... » 2 TAVOLA 2 - Altitudine e popolazione residente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle località abitate . » 3 PROVINCIA DI LUCCA TAVOLA 1 - Superficie territoriale e densità - Numero delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei - Popolazione residente per tipo di località abitata ......................... » 12 TAVOLA 2 - Altitudine e popolazione residente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle località abitate ..... » 13 PROVINCIA DI PISTOIA TAVOLA 1 - Superficie territoriale e densità - Numero delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei - Popolazione residente per tipo di località abitata ......................... » 30 TAVOLA 2 - Altitudine e popolazione residente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle località abitate ... .. » 31 PROVINCIA DI FIRENZE TAVOLA 1 - Superficie territoriale e densità - Numero delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei - Popolazione residente per tipo di località abitata ...... ................. » 38 TAVOLA 2 - Altitudine e popolazione residente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle località abitate .... » 39 ì 1 t IV i lNDICE I ! I I PROVINCIA DI LIVORNO TAVOLA 1 - Superficie territoliale e jdensità - Numero delle frazioni geografiche, dei centri e ~ei nuclei - Popolazione residente per tipo di località abitata .1... !. Pago 56 I TAVOLA 2 - Altitudine e pop~~~zio~e iresidente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle locahta ablt,te . -

Piano Strutturale E Al Regolamento Urbanistico Vigenti Del Comune Di Gaiole in Chianti PIANO STRUTTURALE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
+ D.C.C. n. 2 del 04/03/2015 Varianti puntuali al Piano strutturale e al Regolamento urbanistico vigenti del Comune di Gaiole in Chianti PIANO STRUTTURALE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ....................................................................................... 5 Art. 1 - Natura e funzioni del Piano Strutturale ............................................................ 5 Art. 2 - Efficacia del P.S. ................................................................................................ 5 Art. 3 - Attuazione del P.S. ............................................................................................ 6 Art. 4 - Elaborati del P.S. ............................................................................................... 6 TITOLO II - DISCIPLINA STRUTTURALE DEL TERRITORIO E STATUTO DEI LUOGHI .............. 10 Art. 5 - Sistemi territoriali ........................................................................................... 10 Art. 5/bis - Invarianti strutturali ................................................................................. 11 Art. 5/ter - Obiettivi della parte gestionale del Piano ................................................ 12 CAPO I - SISTEMA DEL FONDOVALLE ............................................................................... 13 Art. 6 - Subsistema del territorio aperto di fondovalle .............................................. 13 Art. 7 - UTOE fondovalle asciutto .............................................................................. -
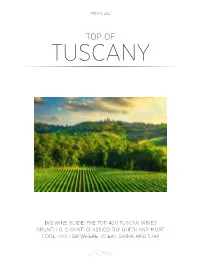
Top of Tuscany
SPECIAL 2021 TOP OF TUSCANY BIG WINE GUIDE: THE TOP 400 TUSCAN WINES BRUNELLO, CHIANTI CLASSICO, BOLGHERI AND MORE COOL TIPS FOR WHERE TO EAT, DRINK AND STAY Contents 05 Trends & facts 2020/2021 08 The three tenors Legends that have made history 14 The magnificent seven Talents of the year 19 Top 5 white wines The best white wines of the year 20 Top 10 red wines Editorial The best red wines of the year 22 Best buys 2020 10 wines offering top value for money ow that our lives are centred primarily on our own gardens and our own wine cellars (where time and finances allow), we have much more leisure 24 Vernaccia San Gimignano to do what we wish. COVID-19 has affected many things, including our N 28 Maremma view of ourselves as wine connoisseurs and quasi-globetrotters. The majority of our tours of Italy and Tuscany planned for spring and summer 32 Morellino die Scansano DOCG 2020 were limited to the works of Fruttero & Lucentini (especially their ’The Pal- io of Dead Riders’, the best Siena book of all) and to exploring the depths of var- 35 Montecucco ious bottles of mature Brunello, Chianti Classico, Vino Nobile or Bolgheri Supe- 38 Brunello di Montalcino riore. However, things will eventually change, and if you should find the time to flick through this edition of Top of Tuscany as you rekindle your wanderlust with 46 Vino Nobile die Montepulciano a glass of Tignanello or Masseto, we would be delighted. The following pages offer a colourful mix of wine stories, and above all a wealth 50 Chianti Classico DOCG of bottles tasted: we have selected more than 400 from all over Tuscany, with 145 granted the ’Top of Tuscany’ accolade. -
PERCORSO LUNGO - 209 KM Tabella Di Marcia
PERCORSO LUNGO - 209 KM Tabella di marcia COMUNE LOCALITÀ DIREZIONE STRADA O VIA E KM KM KM MARCIA MARCIA NOTE DI MARCIA ENTE PROPRIETARIO TOT PARZ ARRIVO 25/H 10/H GAIOLE IN CHIANTI Partenza Piazza Ricasoli 0 0 209,50 4:30 6:00 CONTROLLO Gaiole in Chianti Molin Lungo Incrocio SX S.P. 408 2,30 2,30 207,20 4:35 6:09 Gaiole in Chianti Ponte di Ferro Incrocio SX S.P. 484 4,90 2,60 204,60 4:41 6:19 Gaiole in Chianti Madonna a Brolio Diritto Strada privata Castello di Brolio 9,60 4,70 199,90 4:53 6:38 Inizio 1° strada bianca Gaiole in Chianti Grotta Incrocio DX S.C. della Grotta 11,50 1,90 198,00 4:57 6:46 Gaiole in Chianti Leccione Incrocio SX S.C. 24 12,90 1,40 196,60 5:00 6:51 Fine 1° strada bianca Gaiole in Chianti Le Bagnaie Incrocio SX S.P. 408 18,60 5,70 190,90 5:14 7:14 Castelnuovo Berardenga Pianella Diritto S.P. 408 19,60 1,00 189,90 5:17 7:18 Siena San Giovanni a Cerreto Incrocio SX Strada di Montechiaro 22,20 2,60 187,30 5:23 7:28 Inizio 2° strada bianca Siena 4 vie Incrocio DX Strada di Pieve a Bozzone 25,30 3,10 184,20 5:30 7:41 Fine 2° strada bianca Siena Due Ponti Incrocio DX S.S. 715 Siena/Bettolle 30,70 5,40 178,80 5:43 8:02 Siena Due Ponti Rotatoria 3° uscita S.S.