Qfondazione G. Brodolini
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

30Years 1953-1983
30Years 1953-1983 Group of the European People's Party (Christian -Demoeratie Group) 30Years 1953-1983 Group of the European People's Party (Christian -Demoeratie Group) Foreword . 3 Constitution declaration of the Christian-Democratic Group (1953 and 1958) . 4 The beginnings ............ ·~:.................................................. 9 From the Common Assembly to the European Parliament ........................... 12 The Community takes shape; consolidation within, recognition without . 15 A new impetus: consolidation, expansion, political cooperation ........................................................... 19 On the road to European Union .................................................. 23 On the threshold of direct elections and of a second enlargement .................................................... 26 The elected Parliament - Symbol of the sovereignty of the European people .......... 31 List of members of the Christian-Democratic Group ................................ 49 2 Foreword On 23 June 1953 the Christian-Democratic Political Group officially came into being within the then Common Assembly of the European Coal and Steel Community. The Christian Democrats in the original six Community countries thus expressed their conscious and firm resolve to rise above a blinkered vision of egoistically determined national interests and forge a common, supranational consciousness in the service of all our peoples. From that moment our Group, whose tMrtieth anniversary we are now celebrating together with thirty years of political -

Archivio Centrale Dello Stato Inventario Del Fondo Ugo La Malfa Sala Studio
Archivio centrale dello Stato Inventario del fondo Ugo La Malfa Sala Studio INVENTARIO DEL FONDO UGO LA MALFA (1910 circa – 1982) a cura di Cristina Farnetti e Francesca Garello Roma 2004-2005 Il fondo Ugo La Malfa è di proprietà della Fondazione Ugo La Malfa, via S.Anna 13 – 00186 Roma www.fondazionelamalfa.org [email protected] Depositato in Archivio centrale dello Stato dal 1981 Il riordino e l’inventariazione è stato finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi II INDICE GENERALE INTRODUZIONE .................................................................................................V INVENTARIO DEL FONDO ............................................................................ XI SERIE I. ATTI E CORRISPONDENZA...............................................................1 SERIE II ATTIVITÀ POLITICA .........................................................................13 SOTTOSERIE 1. APPUNTI RISERVATI 50 SERIE III. CARICHE DI GOVERNO ................................................................59 SOTTOSERIE 1. GOVERNI CON ORDINAMENTO PROVVISORIO (GOVERNO PARRI E I GOVERNO DE GASPERI) 61 SOTTOSERIE 2. MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO (VI GOVERNO DE GASPERI) 63 SOTTOSERIE 3. MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO (VI E VII GOVERNO DE GASPERI) 64 SOTTOSERIE 4. MINISTRO DEL BILANCIO (IV GOVERNO FANFANI) 73 SOTTOSERIE 5. MINISTRO DEL TESORO (IV GOVERNO RUMOR) 83 SOTTOSERIE 6. VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO (IV GOVERNO MORO) 103 SOTTOSERIE 7. FORMAZIONE DEL GOVERNO E VICEPRESIDENTE -

Statuto E Attività 1962-2012
ISTITUTO PER LA DOCUMENTAZIONE E GLI STUDI LEGISLATIVI Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica STATUTO E ATTIVITÀ 1962-2012 JOVENE EDITORE NAPOLI 2012 ISLE Via del Plebiscito 102 - 00186 ROMA Tel. 06 679 5142 - Fax 06 679 3449 [email protected] DIRITTI D’AUTORE RISERVATI © Copyright 2012 ISBN 978-88-243-2109-9 JOVENE EDITORE Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI NA - ITALIA Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87 web site: www.jovene.it e-mail: [email protected] Printed in Italy Stampato in Italia ISTITUTO PER LA DOCUMENTAZIONE E GLI STUDI LEGISLATIVI Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica UFFICIO DI PRESIDENZA Presidente Onorario Antonio Maccanico Presidente Giovanni Pieraccini Vicepresidenti In rappresentanza In rappresentanza dei Soci ordinari: dei Soci collettivi: Augusto Barbera Giuseppe Mazzei Francesco D’Onofrio Segretario Generale Silvio Traversa Consiglio Direttivo Augusto Barbera A.B.I. Francesco D’Onofrio Domenico Siniscalco ASSOGESTIONI Gaetano Gifuni Alessandro Rossi Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene s.r.l. Giuseppe Guarino Giuseppe Mazzei Il Chiostro Vincenzo Lippolis ENEL Antonio Maccanico GRUPPO FERROVIE DELLO STATO Donato Marra Giovanni Ialongo Massimo Sarmi Giovanni Pieraccini POSTE ITALIANE S.P.A. Massimo Scioscioli Gaetano Blandini Paolo Agoglia Elisabetta Serafin SIAE Franco Bernabé Silvio Traversa TELECOM ITALIA Ugo Zampetti UNICREDIT Tesoriere Massimo Scioscioli Revisori dei Conti Gaetano De Vito - Sebastiano Piana - Francesco Sposato INDICE GIOVANNI PIERACCINI, Presentazione.................................................................. p. 7 SILVIO TRAVERSA, Introduzione........................................................................... » 11 ANTONIO MACCANICO, La nascita dell’ISLE ...................................................... » 15 ANTIGONO DONATI, I primi quindici anni dell’ISLE......................................... » 19 GIULIANO AMATO, La Scuola di Scienza e Tecnica della Legislazione.............. -

An Exploratory Study Authors of the Summary: Hilde Heynen, André Loeckx, Marcel Smets Professors at the Catholic University of Louvain
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Directorate-General Telecommunications, Information Industries and Innovation URBAN ENVIRONMENT L· xpert Csontributions EUR 13145 EN URBAN ENVIRONMENT EXPERT CONTRIBUTIONS GREEN PAPER ON THE URBAN ENVIRONMENT With a view to the preparation of the Green Paper on the Urban Environment, Directorate-General XI of the Commis• sion of the European Communities or• ganized a series of international confer• ences attended by officials and experts from cities throughout Europe, the re• sults of which have been extremely valuable. This document, which contains the sum• mary reports of all the conferences, to• gether with studies on specific topics pre• pared by various experts, provides an opportunity for further development of the subjects covered in the Green Paper. URBAN ENVIRONMENT Expert (contributions PAN.. EURO?. D ' N:!i. N.C./CCM CL COMMISSION OFTHE EUROPEAN COMMUNITIES URBAN ENVIRONMENT Expert (contributions Commission of the European Communities Rue de la Loi 200 B-1049 Brussels Directorate-General 1990 Environment, Nuclear Safety and Civil Protection Ct^ ^a\ Published by the COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Directorate-General Telecommunications, Information Industries and Innovation L-2920 Luxembourg LEGAL NOTICE Neither the Commission of the European Communities nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use which might be made of the following information This publication is also available in the following languages: ES ISBN 92-826-1796-3 DA ISBN 92-826-1797-1 DE ISBN 92-826-1798-X GR ISBN 92-826-1799-8 FR ISBN 92-826-1801-3 IT ISBN 92-826-1802-1 NL ISBN 92-826-1803-X PT ISBN 92-826-1804-8 Cataloguing data can be found at the end of this publication Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1991 EUR 13145: ISBN 92-826-1800-5 Cat. -

48A SED D'fa PUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA V LEGISLATURA 48a SED D'fA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO LITNEDI '" 16 DICEMBRE 1968 Presidenza del Presidente FANFANI, indi del Vice Presidente SPATARO INDICE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIU~ CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA DIZIO E DEL LAVORO Annunzio di domanda . Pago 2785 Trasmissione di rapporto Pago 2786 COMMISSIONE SPECIALE DISEGNI DI LEGGE Annunzio di presentazione Costituzione 2778 . 2778 Nomina di membri 2778 Annunzio di presentazione e deferimento a Commissione permanente in sede referente CONGEDI . 2759 del disegno di legge n. 370; autorizzazione alla relazione orale: CONVALIDA DI ELEZIONI A SENATORE 2759 PRESIDENTE 2278 MARTINELLI 2778 CORTE COSTITUZIONALE Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante . 2780 Annunzio di ordinanze emesse da Autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità 2786 Deferimento a Commissioni permanenti in Annunzio di sentenze. 2785 sede redigente. 2782 Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente. 2783 CORTE DEI CONTI Presentazione di relazione. 2784 Trasmissione di determinazione. 2785 Trasmissione di relazioni sulla gestione fi~ GOVERNO nanziaria di enti . 2758 Composizione . 2759 TIPOGRAPIA DEL SENATO (1150) Senato della Repubblica ~ 2758 ~~ V Legislatura 48a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 16 DICEMBRE 1968 ~.~."~. ~.. ~~..~ ".~.~~~nn~~~.~.. ""~~"~""~~~~~".~~~.~~."~ ..~.".." I Comunicazioni: Annunzio. di risposte scritte ad interroga~ RUMOR, Presidente del Consiglio dei nu. zioni . Pago 2794 nistri . .. Pago 2761 PETIZIONI Discussione sulle comunicazioni: Annunzio . 2786 BERTHET 2793 GIRAUDO 2786 REGOLAZIONE DEI CORSI D'ACQUA Annunzio di relazione. 2785 MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERRO- GAZIONI Annunzio di interpellanze 2795 Annunzio di interrogazioni . 2797 ALLEGATO AL RESOCONTO. Risposte Annunzio di mozioni . 2794 scritte ad interrogazioni 2833 Senato della Repubblica ~ 2759 ~~ V Legislatura 48a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 16 DICEMBRE 1968 Presidenza del Presidente FANFANI P RES I D E N T E. -

Aldo Moro E L'apertura a Sinistra: Dalla Crisi Del Centrismo Al Centro-Sinistra
1 Dipartimento di Scienze Politiche Cattedra di Teoria e Storia dei Partiti e dei Movimenti Politici ALDO MORO E L’APERTURA A SINISTRA: DALLA CRISI DEL CENTRISMO AL CENTRO-SINISTRA ORGANICO RELATORE CANDIDATO Prof. Andrea Ungari Mirko Tursi Matr. 079232 ANNO ACCADEMICO 2017/18 2 3 INDICE INTRODUZIONE 4 CAPITOLO PRIMO LA CRISI DEL CENTRISMO E L’ASCESA DI MORO NEL PANORAMA POLITICO ITALIANO (1953-1959) 6 1.1 La presidenza del gruppo parlamentare della Dc e la prima apertura ai socialisti 6 1.2 L’elezione di Gronchi alla presidenza della RepubbliCa e la marCia di avvicinamento tra Dc e Psi 9 1.3 Le elezioni politiche del 1958 e l’elezione di Moro a segretario della DC 11 1.4 Il Congresso di Firenze e l’autonomia del partito dalle gerarchie ecclesiastiche 16 CAPITOLO SECONDO LA NASCITA DEL PRIMO GOVERNO DI CENTRO-SINISTRA ORGANICO (1960-1963) 23 2.1 L’ultimo governo di centro-destra e il passaggio al governo delle “convergenze parallele” 23 2.2 Le prime giunte di centro-sinistra e la difficile preparazione all’incontro ideologico tra cattolici e soCialisti 31 2.3 Il Congresso di Napoli ed il programma riformatore del quarto governo Fanfani 35 2.4 Le elezioni politiche del 1963 e la nascita del primo governo di centro-sinistra organico guidato da Moro 44 CAPITOLO TERZO IL DECLINO DELLA FORMULA DI CENTRO-SINISTRA (1964-1968) 53 3.1 La crisi politica del 1964 ed il tormentato avvio del II Governo Moro 53 3.2 L’elezione di Saragat alla presidenza della Repubblica e l’irreversibilità della formula di centro-sinistra 63 3.3 Il III Governo Moro e l’unificazione socialista 70 3.4 La tornata elettorale del 1968: fine dell’esperienza di centro-sinistra 76 CONCLUSIONE 83 ABSTRACT 86 BIBLIOGRAFIA 87 4 INTRODUZIONE Il periodo storiCo Che si estende dal 1953 al 1968 rappresenta un unicum all’interno della politiCa italiana e CostituisCe uno dei temi più affasCinanti della storia della Prima RepubbliCa. -
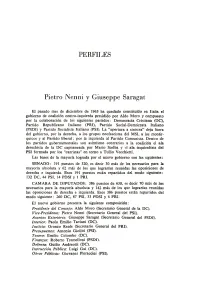
PERFIJ.,ES Pietro N Enni Y Giuseppe Saragat
PERFIJ.,ES Pietro N enni y Giuseppe Saragat El pasado mes de diciembre de 1963 ha quedado constituído en Italia el gobierno de coalición centro-izquierda presidido por Aldo Moro y compuesto por la colaboración de los siguientes partidos: Democracia Cristiana (DC), Partido Republicano Italiano (PRI), Partido Social-Demócrata Italiano (PSDI) y Partido Socialista Italiano (PSI). La "apertura a sinistra" deja fuera del gobierno, por la derecha, a los grupos neofascistas del MSI, a los monár quicos y al Partido liberal; por la izquierda al Partido Comunista. Dentro de los partidos gubernamentales son asimismo contrarios a la coalición el ala derechista de la DC capitaneada por Mario Scelba y el ala izquierdista del PSI formada por los "carristas" en tomo a Tullio Vecchietti. Las bases de la mayoría lograda por el nuevo gobierno son las siguientes: SENADO: 191 puestos de 320, es decir 30 más de los necesarios para la mayoría absoluta y 62 más de los que lograrían reunidas las oposiciones de derecha e izquierda. Esos 191 puestos están repartidos del modo siguiente: 132 DC, 44 PSI, 14 PDSI y 1 PRI. CAMARA DE DIPUTADOS: 386 puestos de 630, es decir 70 más de los necesarios para la mayoría absoluta y 142 más de los que lograrían reunidas las oposiciones de derecha e izquierda. Esos 386 puestos están repartidos del modo siguiente: 260 DC, 87 PSI, 33 PDSI y 6 PRI. El nuevo gobierno presenta la siguiente composición: Presidente del Consejo: Aldo Moro (Secretario General de la DC). Vice-Presidente: Pietro Nenni (Secretario General del PSI). Asuntos Exteriores: Giuseppe Saragat (Secretario General del PSDI). -

The Italian Communist Party and The
CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY DEPARTMENT OF HISTORY The Italian Communist Party and the Hungarian crisis of 1956 History one-year M. A. In partial fulfillment of the requirements for the degree of Masters of Arts Candidate: Aniello Verde Supervisor: Prof. Marsha Siefert Second reader: Prof. Alfred Rieber CEU eTD Collection June 4th, 2012 A. Y. 2011/2012 Budapest, Hungary Copyright in the text of this thesis rests with the Author. Copies by any process, either in full or part, may be made only in accordance with the instructions given by the Author and lodged in the Central European Library. Details may be obtained from the librarian. This page must form a part of any such copies made. Further copies made in accordance with such instructions may not be made without the written permission of the Author. CEU eTD Collection Acknowledgements I would like to express my frank gratitude to professors Marsha Siefert and Alfred Rieber for their indispensible support, guidance and corrections. Additionally, I would like to thank my Department staff. Particularly, I would like to thank Anikó Molnar for her continuous help and suggestions. CEU eTD Collection III ABSTRACT Despite a vast research about the impact of the Hungarian crisis of 1956 on the legacy of Communism in Italy, the controversial choices of the Italian Communist Party (PCI) have been often considered to be a sort of negative exception in the progressive path of Italian Communism toward modern European socialism. Instead, the main idea of this research is to reconstruct the PCI’s decision-making within the context of the enduring strategic patterns that shaped the political action of the party: can the communist reaction to the impact in Italy of the Hungarian uprising be interpreted as a coherent implication of the communist preexisting and persisting strategy? In order to answer this question, it is necessary to reconstruct how the news coming from Hungary left an imprint on the “permanent interests” of the PCI, and how the communist apparatus reacted to the crisis. -

Come Un Ministro Per La Cultura. Giulio Einaudi E Le Biblioteche Nel
Chiara Faggiolani Come un Ministro per la cultura Chiara Faggiolani Come un Ministro per la cultura Giulio Einaudi e le biblioteche nel sistema del libro FIRENZE PRESUNIVERSITYS Biblioteche & bibliotecari / Libraries & librarians ISSN 2612-7709 (PRINT) | ISSN 2704-5889 (ONLINE) – 4 – Biblioteche & bibliotecari / Libraries & librarians Editor-in-Chief Mauro Guerrini, University of Florence, Italy Scientific Board Carlo Bianchini, University of Pavia, Italy Andrea Capaccioni, University of Perugia, Italy Gianfranco Crupi, University of Rome La Sapienza, Italy Tom Delsey, University of Ottawa, Canada Graziano Ruffini, University of Florence, Italy Alberto Salarelli, University of Parma, Italy José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, Complutense University of Madrid, Spain Lucia Sardo, University of Bologna, Italy Giovanni Solimine, University of Rome La Sapienza, Italy La collana intende ospitare riflessioni sulla biblioteconomia e le discipline a essa connesse, studi sulla funzione delle biblioteche e sui suoi linguaggi e servizi, monografie sui rapporti fra la storia delle biblioteche, la storia della biblioteconomia e la storia della professione. L’attenzione sarà rivolta in particolare ai bibliotecari che hanno cambiato la storia delle biblioteche e alle biblioteche che hanno accolto e promosso le figure di grandi bibliotecari. The series intends to host reflections on librarianship and related disci- plines, essays on the function of libraries and its languages and services, monographs on the relationships between the history of libraries, the his- tory of library science and the history of the profession. The focus will be on librarians who have changed the history of libraries and libraries that have welcomed and promoted the figures of great librarians. Chiara Faggiolani Come un Ministro per la cultura Giulio Einaudi e le biblioteche nel sistema del libro FIRENZE UNIVERSITY PRESS 2020 Come un Ministro per la cultura : Giulio Einaudi e le biblioteche nel sistema del libro / Chiara Faggiolani. -

Antonio, Giolitti
Antonio, Giolitti G. (Roma 1915-ivi 2010), nipote di Giovanni Giolitti, compì i suoi studi a Roma, laureandosi in giurisprudenza. Allevato nell’atmosfera liberale e antifascista della sua famiglia, nel 1941 aderiva al PCI e diventava redattore nella sede romana della casa editrice Einaudi. Durante la guerra fu commissario politico della brigata partigiana Garibaldi, operante nella Valli di Lanzo in Piemonte. Nel 1945 era nominato membro della Consulta e nel 1946 entrava nell’Assemblea costituente nelle liste del Partito comunista. Dal 1948 fu membro del gruppo comunista della Camera dei deputati, eletto nel collegio di Cuneo-Asti-Alessandria. Rieletto nel 1953, nel 1958 si presentava nelle liste del PSI dove nuovamente conseguiva il seggio parlamentare, che avrebbe conservato fino alla sua nomina a Commissario europeo nel 1977. Nel 1956 G. aveva preso posizione contro l’intervento sovietico in Ungheria. Di qui un lungo confronto con gli organi dirigenti del PCI, a cui diede forma nel suo saggio, Riforme e rivoluzione (1957) e in un intervento all’ VIII Congresso del PCI nel 1958 a cui seguirono le sue dimissioni da quel partito. La sua formazione si era indirizzata verso l’economia politica, e di carattere economico furono gli incarichi direttivi assunti nell’ambito dell’organizzazione comunista e negli interventi della sua attività parlamentare. Divenne in seguito responsabile della sezione economica del PSI e tenne questo ruolo nei dibattiti che accompagnarono la formazione del centrosinistra. Si schierò con la corrente autonomista a fianco di Riccardo Lombardi. Con la formazione del primo governo organico di centrosinistra assunse la carica di ministro del Bilancio e della programmazione nel primo governo di Aldo Moro con il compito precipuo di formulare il piano economico del governo. -

From Delors to Guterres
3Holland_Template.qxd 13/09/2018 14:05 Page 7 7 From Delors For progressive economists Dani Rodrik is on the side of the angels. His Has to Guterres Globalization Gone Too Far? (1997) was Europe from prophetic. His insights into how the World Trade Organization not only has the Left institutionalised the postwar General Agreement on Tariffs and Trade, but has also been intrusive in insisting on rules concerning how governments should Stuart Holland manage their economies, have been significant. As has been his recognition that recent trade agreements have served vested interests rather than benefited peoples. While his more recent outspoken claim that globalisation has been “tearing societies apart” (Rodrik, 2018) rightly has resonated. It therefore is remarkable that his claim that, since the early 1980s, there was an intellectual abdication of the European Left (Rodrik, 2016) is a travesty of both people and recent history. As has been the claim of Sheri Berman (2017) that, since the 1970s, European “social democrats lacked well thought out plans for getting economies moving again or for using the democratic state to protect citizens from the changes brought by everevolving capitalism”. Both, and especially Dani, deserve a response. Thus in his Abdication of the Left Dani Stuart Holland’s long submits that: engagement in European economics and politics “The enthroning of free capital mobility … began in the 1960s. He is was spearheaded in the late 1980s and early a Visiting Professor in the 1990s not by freemarket ideologues, but by Faculty of Economics of French technocrats such as Jacques Delors at the University of Coimbra the European Commission who was closely associated with the Socialist Party in and a Senior Research France.” Fellow of the Institute for Advanced Studies Köszeg. -

Franco Archibugi Planning Heory from the Political Debate to the Methodological Reconstruction Franco Archibugi
Franco Archibugi Planning heory From the Political Debate to the Methodological Reconstruction Franco Archibugi Planning Theory From the Political Debate to the Methodological Reconstruction 123 Franco Archibugi c/o Planning Studies Centre Via Federico Cassitto 110 00134 Roma Italy [email protected] Library of Congress Control Number: 2007929930 ISBN 978-88-470-0695-9 Springer Milan Berlin Heidelberg New York hisworkissubjecttocopyright.Allrightsarereserved,whetherthewholeorpartofthematerialis concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broad- casting, reproduction on microfilm or in any other way, and storage in data banks. Duplication of this publication or parts thereof is only permitted under the provisions of the Italian Copyright Law in its current version, and permission for use must always be obtained from Springer-Verlag. Violations are liable for prosecution under the Italian Copyright Law. Springer is a part of Springer Science+Business Media springer.com © Springer-Verlag Italia 2008 Printed in Italy Cover design: Simona Colombo, Milano Typesetting: LE-TEX Jelonek, Schmidt & Vöckler GbR, Leipzig, Germany Printing and binding: Grafiche Porpora, Segrate (MI) Springer-Verlag Italia – Via Decembrio 28 – I-20137 Milano Printed on acid-free paper Preface his book has re-elaborated, in a unified and organic way, some of my contributions to the academic debates among European and American planning “theorists”. Such contributions were born in relation to my participation at a conference on planning theory promoted by Oxford Brookes University, in April . his con- ference gave me a very interesting opportunity to be among other scholars on the subject. On this occasion I had the opportunity to pour out, into the bosom of an abundant group of colleagues (to whom I am bound together by some years of sci- entific contact on the issues of the effectiveness and methods of planning), my con- cerns about the turns taken by the literature of planning theory over the last decade or more.