Salvatore Giuliano
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Guerilla Warfare a Sicilian Bandit
RIGHT An American Marine medic administers plasma to a wounded soldier behind the front line in the streets of San Agata, during the Allied invasion of Sicily. Guerilla Warfare With a small but extremely tough volunteer army, the movement for independence in Sicily—which represented a variation on the old and unattainable Mafi a dream of becoming a state—began its armed struggle in the autumn of 1944, partly as a reaction to the continual and arbitrary attacks carried out by the police forces against its offi ces and supporters. Their attempt to bring about a separatist insurrection gave rise to vehement resistance, leading to guerilla warfare. The Italian government was forced to send the army to Sicily to support the police and Carabinieri and to put down the revolt. On June 17, 1945, the commander and founder of the separatist army, Antonio Canepa, was killed in a gunfi ght with the Carabinieri. His death pro- voked many well-founded suspicions that the Mafi a was directly responsible. Given their antipathy to words such as “socialism” and “revolution,” they were no doubt keen to rid themselves of such a subversive combatant. A Sicilian Bandit Concetto Gallo became the new head of the separatist army and then entered into an alliance with the bandits hoping to achieve victory for the revolt. He proposed that the most famous and wanted bandit in all of Sicily, Salvatore Giuliano, should join the volunteer army for the movement for Sicilian independence. Giuliano accepted, and he and his band carried out a series of attacks on the police and Carabinieri as well as on the troops sent by Rome to halt the progress of the rebel- lion. -

Università Degli Studi Di Catania Catania E I Sindaci
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE TESI DI DOTTORATO DI RICERCA IN PENSIERO POLITICO E ISTITUZIONI NELLE SOCIETÀ MEDITERRANEE XXIV CICLO CARMELO LA ROCCA CATANIA E I SINDACI DEL SECONDO DOPOGUERRA PERCORSI POLITICI E AMMINISTRATIVI COORDINATORE E TUTOR CH.MO PROF . GIUSEPPE ASTUTO 0 INDICE INTRODUZIONE 1 Le Istituzioni e la politica 3 2 La ricerca e le fonti 11 1° CAPITOLO La fine della guerra 1.1 Lo sbarco degli alleati 16 1.2 Si ricomincia… 20 1.3 La rinascita dei partiti 25 1.4 Catania e le aspirazioni separatistiche del MIS 33 2° CAPITOLO Dal Podestà al Sindaco 2.1 Dal Sindaco dell’età liberale al Podestà 40 2.2 Gli ultimi Podestà di Catania 42 2.3 …il Sindaco 47 3° CAPITOLO Le elezioni del 1946 3.1 Si vota! 61 3.2 Le “amministrative” a Catania 68 3.3 Il nuovo Consiglio comunale 73 3.4 Le 136 preferenze di Pittari 76 3.5 Un monarchico liberale 82 3.6 La D.C. resta ancora a guardare 85 4° CAPITOLO Magrì e La Ferlita 4.1 La Democrazia Cristiana 90 4.2 Le elezioni del 25 maggio 1952 93 4.3 “La politica per Catania… 97 4.4 Un Sindaco per sette anni 104 4.5 La Ferlita… lascia 111 1 5° CAPITOLO Da Papale a Nino Drago 5.1 Novembre 1960 116 5.2 Il Piano Regolatore Generale 125 5.3 Lo scandalo edilizio 128 5.4 La sindacatura Drago 132 6° CAPITOLO I Sindaci di Drago 6.1 Giuseppe Gulli 140 6.2 Il Pigno ha sete 145 6.3 Tra politica e sport: Marcoccio 153 6.4 Le elezioni del 15 giugno 1975 160 6.5 Le nuove giunte Magrì 166 6.6 Le ultime amministrazioni Magrì 173 6.7 Salvatore Coco 176 6.8 Angelo Munzone 182 7° CAPITOLO Bianco… per caso 7.1 Il professore Mirone 187 7.2 Si scioglie il Consiglio 190 7.3 Bianco… per caso 195 7.4 Ritorna la D.C., ma… 200 7.5 Direttamente Bianco 204 Conclusioni 208 Bibliografia 214 2 INTRODUZIONE 1. -

Ragione Sociale Nome Dell'esercizio Partita IVA Sigla Denominazione Comune Denominazione Strada Civico CAP Regione Tip Chiusura Note AL.CA
Ragione sociale Nome dell'esercizio Partita IVA Sigla Denominazione Comune Denominazione Strada Civico CAP Regione Tip chiusura Note AL.CA. SRL R7 SUPERMERCATI CITY 02667500843 AG AGRIGENTO VIALE LEONARDO SCIASCIA 100 92100 SICILIA G MAI ALCA SRL FORUM BAR 02576870840 AG AGRIGENTO VIA GIUSEPPE MAZZINI 140 92100 SICILIA E DOMENICA ATENEA SNC DI RAGUCCIA SALVATORE & C. CAFE ATENEA BAR 02507540843 AG AGRIGENTO VIA ATENEA 301 92100 SICILIA F DOMENICA BAMBU' GERLANDA CASH AND CARRY DALLI CARDILLO GASTRONOMIA 01912040845 AG AGRIGENTO VIA PIERSANTI MATTARELLA 263 92100 SICILIA G MERCOLEDI' CAFFE' DEI FIORI 2 SRL CAFFE' DEI FIORI BAR 2 01912220843 AG AGRIGENTO CONTRADA CONSOLIDA SNC 92100 SICILIA F MAI C/O OSPEDALE SAN GIOVANNI COSTA GIUSEPPE COSTA BAR 01581350848 AG AGRIGENTO VIA DANTE ALIGHIERI 3 92100 SICILIA F DOMENICA CUCCHIARA FABIO ZANZI ... BAR 02512070844 AG AGRIGENTO VIA PIERSANTI MATTARELLA 345 92100 SICILIA F DOMENICA DALLI CARDILLO GIUSEPPE SAS BAR LA VELA 02311400846 AG AGRIGENTO PIAZZA ASTER 2 92100 SICILIA F MAI LOCALITA SAN LEONE DANILE ERNESTO BABY LUNA BAR 02297920841 AG AGRIGENTO VIA ALESSANDRO MANZONI 215 92100 SICILIA F MAI DET.AL DI MACALUSO MICHELINA SAS DI MEGLIO MARKET 01911330841 AG AGRIGENTO VIALE EMPORIUM 90 92100 SICILIA G MERCOLEDI' DI NOLFO GIOVANNI CHEZ JEAN 2 RISTORANTE PIZZERIA 02046980849 AG AGRIGENTO VIA CICERONE 23 92100 SICILIA E LUNEDI' DIVINAE SNC DI FERLISI E SODANO DIVINAE OPERA RISTORANTE PIZZERIA 02596100848 AG AGRIGENTO VIA ATENEA 239/241 92100 SICILIA E LUNEDI' F.LLI CAPOSTAGNO SAS DI CAPOSTAGNO MASSIMILIANO & C. CONAD 01906930845 AG AGRIGENTO VIALE DEI GIARDINI 52 92100 SICILIA G DOMENICA F.LLI NANTELE S. -

Who Was Partisan Canepa?
GLORY TO OUR COMRADE ANTONIO CANEPA and to the partisans of the Volunteer Army for the Independence of Sicily! NO to the hypocritical tricoloured Liberation Day and to the tainted May Day celebrations! World War II (1939-1945). After the facts were cleaned out by the ideologies, our very own Memory was "purified", what is left of the second WORLD WAR is a lethal confrontation between competing Powers, which turned into the division of the World in two parts, of a divided Europe, a divided Germany, a divided Berlin. And in the long-lasting withdrawal of the old colonialist European Empires, that had "won" the war, triggering India's independence, and most of all the foundation of Mao's People's Republic of China. In July 1943 - with Operation Husky - the "Allies" (supported by an efficient Resistance against Nazi- fascism) occupy Sicily. It was the beginning of the end of a Regime, but, as we will see, it was not what the Sicilian Partisans had fought for. The 24th October 1943, beyond the temporary AMGOT (Allied Military Government for Occupied Territories), was also the birthdate of Washington's "SICILY REGION 1" in the Mediterranean, which remains like an "unsaid" under this sky that is populated by foreign planes, assassin drones, dysfunctional saints and a G7 on a tourist trip. This Sicily is a fought-over island, played like a geopolitical card by Rome, the real mafia capital, and its strategic relation with the AmeriKan friend. A treasure island reduced to Europe's poorhouse, with its habitants being forced to emigrate. -

Riflessioni Sull™Enigmatica Strage Di Portella Delle
www.laltrasicilia.org RIFLESSIONI SULL’ENIGMATICA STRAGE DI PORTELLA DELLE GINESTRE Dott. Salvatore Riggio Scaduto Nel giugno del 1987 a Montelepre veniva pubblicato dalla casa editrice “La Rivalsa” un corposo libro di 342 pagine, avente inoltre un’appendice fotografica e documentale, intitolato “MIO FRATELLO SALVATORE GIULIANO” degli autori Marianna Giuliano e Giuseppe Sciortino Giuliano, rispettivamente sorella e nipote di Salvatore Giuliano. Dall’introduzione firmata solo dal secondo autore, figlio di Marianna Giuliano, apprendiamo, però, che il libro è stato scritto soltanto da questo, tanto è vero che a pag. 8 si legge che “Il merito maggiore va a mia madre....La sorella di Turiddu, che con lui condivise gli ideali e che lo affiancò nella lotta sia armata che politica. Senza di lei... Forse non sarei mai riuscito nel mio compito”. Il detto libro ha chiaramente e certamente finalità apologetiche e giustificative del personaggio che per circa sette anni tenne a scacco nell’immediato dopoguerra le forze dello Stato Italiano, ma è altrettanto certo che la sorella di Turiddu Giuliano, Marianna, coniugata con Pasquale Sciortino, fu la confidente prediletta del fratello e quindi la depositaria di tantissimi segreti. Uno storico attento e scrupoloso non può liquidare sic et simpliciter i fatti riportati nel detto libro come non veritieri perché di parte, ma deve saper sottoporre a vaglio critico tali fatti con le risultanze di altre fonti. Volendo anch’io strizzare qualche gocciolina della mia penna nel fiume impetuoso d’inchiostro versato sull’oscura strage di Portella delle Ginestre del 1° Maggio 1947, mi cimenterò con il presente scritto a fare alcune considerazioni tenendo anche presente “la verità” ammanitaci in proposito del detto libro da pag. -
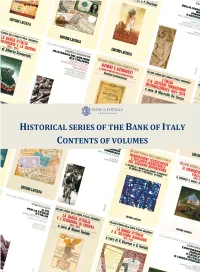
Contents Index
COLLANA STORICA DELLA BANCA D'ITALIA- DOCUMENTI L'ITALIA E IL SISTEMA FINANZIARIO INTERNAZIONALE 1861-1914 a cura di Marcello De Cecco EDITORI LATERZA CSBI – DOCUMENTS SERIES, I Italy and the International Financial System 1861-1914 edited by Marcello De Cecco CONTENTS Presentation by Carlo A. Ciampi VII Preface by Carlo M. Cipolla IX Abbreviations XVI Introduction 1 l. Italy in the International Monetary System 5 2. Italian Foreign Public Debt 22 2.1. The Big Loans of the First Half of 1960s, p. 23 - 2.2. The Loan for the Abolition of Non-convertibility 1881-1882, p. 32 - 2.3. The Conversion of Consols of 1906, p. 39 3. Problems with the Management of Foreign Exchange, Reserves and the Price of Consols Abroad 42 Conclusions 52 Appendix – Note on Sources 55 l. General Problems of Formulation of the Research 55 2. Archive Research 56 2.1. Italian Archives, p. 56 - 2.2. Foreign Archives, p. 59 3. Gaps of the Available Documentation 61 Documents 63 Biographies of the Main Characters Mentioned 963 Bibliography 979 Chronological Index and Document Summary 995 Index of Names 1019 Index of Institutions 1027 Analytical Index 1033 CSBI – DOCUMENTS SERIES, II Institutes of Issue in Italy. Attempts of Unification 1843-1892 edited by Renato De Mattia CONTENTS Presentation by Carlo A. Ciampi V Preface by Carlo M. Cipolla VII Abbreviations XIV Methodological Note XV Introduction 1 1. The Situation on the Eve of Political Unification 3 2. Features of the Monetary System and Payments Instruments before and after the Italian Unification 11 3. The Debate in the Most Ancient Period (1843-1853) 28 4. -

David Seymour’S Album on the Fight Against Illiteracy in Calabria As a Tool of Mediatization: Material Traces of Editing and Visual Storytelling 263
They Did Not Stop at Eboli / Au-delà d’Eboli Edited by / Éditrices Giovanna Hendel, Carole Naggar & Karin Priem Appearances – Studies in Visual Research Edited by Tim Allender, Inés Dussel, Ian Grosvenor, Karin Priem Vol. 1 They Did Not Stop at Eboli: UNESCO and the Campaign against Illiteracy in a Reportage by David “Chim” Seymour and Texts by Carlo Levi (1950) Au-delà d’Eboli : l’UNESCO et la campagne contre l’analphabétisme, dans un reportage de David « Chim » Seymour et des textes de Carlo Levi (1950) Edited by / Éditrices Giovanna Hendel, Carole Naggar & Karin Priem Published by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France, and Walter De Gruyter GmbH, Genthiner Strasse 13, D-10785 Berlin, Germany. © UNESCO and De Gruyter 2019 ISBN 978-3-11-065163-8 e-ISBN (PDF) 978-3-11-065559-9 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-065175-1 UNESCO ISBN 978-92-3-000084-4 Library of Congress Control Number: 2019951949 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. This publication is available in Open Access under the Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-NC-SA 3.0 IGO) license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/). By using the content of this publication, the users accept to be bound by the terms of use of the UNESCO Open Access Repository (www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbyncsa-en). -

Infoitaliaspagna 14 BIS.Indd
Infoitaliaspagna all’interno Rivista bimestrale gratuita n. quattordici anno 2 4 Camere di commercio italiane a Madrid web: www.infoitaliaspagna.com e Saragozza e-mail: [email protected] 6 Le nuove terminologie nella crisi dei mercati [email protected] finanziari Fax: + 34 –952 96 47 35 7 I piani adottati dai principali Governi europei mov. + 34 –670 46 35 04 8 Madrid come Milano per delinquenza giovanile Pubblicità: + 34 - 687 83 70 65 10 Intervista a Giuseppe Dossetti sul recupero Depósito legal MA -564 -2006 dei tossicodipendenti Impreso en los talleres Gráficas del Guadalhorce 14 Testimonianze da l’Europeo su chi tornava sconfitto dall’Argentina Direttore 17 Il rapporto 2008 sugli italiani nel mondo Patrizia Floder Reitter 18 Immagini del Vespucci in Spagna 23 Musica italiana in Andorra e a Santander Realizzazione grafica 24 Maschio e i suoi prodotti Prime Uve Graziella Tonucci 27 La Rubrica Legale 28 Valladolid e la medicina di Salerno 30 Arte e mostre 32 50 anni di Zecchino d’Oro 33 Il ponte di Calatrava a Venezia 34 Contatti utili in Spagna Se volete ricevere la rivista in abbonamento: + 34 –952 96 47 35 Foto Copertina: Ponte Santa Trinità a Firenze di Rita Kramer e Plaza de toros a Ronda di Ylebiann Cerchiamo collaboratori per la vendita Pag 12: Foto Gazzetta di Reggio di spazi pubblicitari. Pag 18 -19-20-21-22: Foto Domenico Recchia e Denis Maggi Per contatti: + 34 - 687 83 70 65 Pag. 23: Foto Dorte Passer Le altre foto: archivio Infoitaliaspagna e Internet l’editoriale di Patrizia Floder Reitter direttore La Borsa perde, il manager guadagna Quando una retribuzione diventa scandalosa. -

VIVERE IL PO Eventi E Incontri Sul Grande Fiume Poste Italiane S.P.A
- Euro 2,50 SETTEMBRE 2017 ANNO 37- N. 378- magazine VIVERE IL PO eventi e incontri sul Grande Fiume Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale 70% DCB Mantova Poste Italiane S.p.A. scatti d'autore La foto è stata scattata, navigando sul fiume Po, da Pasquale Padricelli che ha abitato il Chiavicone di Moglia di Sermide per molti anni. Come scrive Pasquale nella suo libro “Racconti del passato e del presente”, la chiavica risale al XVI secolo, quando Federico Gonzaga ne ordinò la costruzione, per bonificare le terre del destra Secchia. editoriale di chiara mora Sermidiana Magazine è un mensile di Sermidiana 2000 Sermidiana Aut. Tribunale di Padova del 15/12/2006 Iscrizione Registro Stampa: 2058 e i suoi amici Spedizione in A. P. - 70% Filiale di Mantova C.C. Postale: 1008176362 - Pub. inf. 50% È con grande piacere che annuncio la nascita dell’Associazione “Amici di Sermidiana”. La famiglia si allarga, in senso stretto e il senso lato. Dopo Sermidiana Edizioni, Sermidiana Web e Sermidiana Magazine abbiamo pensato di dare avvio ad un’altra esperienza: Sermidiana Associazione, che ci permetterà di promuovere ancora di più la cultura del nostro territorio attraverso Questo periodico è associato all'Unione Stampa Periodica Italiana il suo recupero storico, ma anche organizzando eventi e curando iniziative culturali a più ampio raggio. Direttore Responsabile Luigi Lui Giornalista Pubblicista n.138447 O.D.G.Lombardia La famiglia si allarga però anche accogliendo nuovi amici, che ci vorranno sostenere ed aiutare in questa nuova esperienza. Redazione Silvestro Bertarella · Imo Moi · La mia esperienza in Sermidiana è iniziata tredici anni fa, in un’aula scolastica condi- Chiara Mora · Marco Vallicelli visa con il Direttore. -

Elegance in the Sky: the Architecture of Rosario Candela at the Museum of the City of New York
For Immediate Release Elegance in the Sky: The Architecture of Rosario Candela at the Museum of the City of New York Samuel H. Gottscho, "960 Fifth Avenue. Dining room," 1930. Museum of the City of New York, Gottscho-Schleisner Collection, 88.1.1.1012 Exhibition Explores Renowned Architect Who Played a Major Role in Defining Luxury Living in Early 20th Century Manhattan On View: Thursday, May 17–Sunday, October 28, 2018 (New York, NY) On Thursday, May 17, 2018, the Museum of the City of New York will open Elegance in the Sky: The Architecture of Rosario Candela, an exhibition exploring the legacy of renowned architect Rosario Candela (1890–1953), who played a major role in transforming and shaping luxury living of 20th century Manhattan with the design of the distinctive “prewar” apartment buildings that define the cityscapes of iconic streets such as Park and Fifth Avenues and Sutton Place. Candela’s elegant yet understated high-rises, including 960 Fifth Avenue, 740 Park Avenue, and One Sutton Place South, featured set-back terraces and neo-Georgian and Art Deco ornament that created the look of New York urbanism between the World Wars. The exhibition is designed by Peter Pennoyer Architects. Graphic design is by Tsang Seymour. Elegance in the Sky tells the remarkable story of how Rosario Candela, an immigrant architect, made a permanent name for himself by becoming an influential force in transforming the way the wealthiest in New York City lived. Through photographs, ephemera, graphics, furnishings, and digital animation, the exhibition displays how Candela and his colleagues inspired some of the most prominent New Yorkers to move from their private homes to “luxury mansions in the sky,” thus changing the landscape of the city. -

Salvatore Giuliano (Analyse) Albert Fèche
Document généré le 26 sept. 2021 06:10 Séquences La revue de cinéma Salvatore Giuliano (analyse) Albert Fèche Cinéma et justice Numéro 42, octobre 1965 URI : https://id.erudit.org/iderudit/51794ac Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) La revue Séquences Inc. ISSN 0037-2412 (imprimé) 1923-5100 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Fèche, A. (1965). Salvatore Giuliano (analyse). Séquences, (42), 29–35. Tous droits réservés © La revue Séquences Inc., 1965 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ SALVATORE GIULIANO -Ar. aLJocutnentati 1. Générique dent du tribunal), Federico Zardi (l'avo Italien 1961. — Real. : Francesco Rosi. cat de la défense), Fernando Cicero, Co — Sein. : Francesco Rosi, Susi Cecchi d'A simo Torino, Sennuccio Benelli, Bruno Ek- mico, Enzo Provenzale, Franco Solinas. — mar, Max Cartier, Giuseppe Teti. — Prod. : Phot. : Gianni di Venanzo. — Mut. : Pie Lux/Vides/Galatea. (Franco Cristaldi). ro Piccioni. — Int. : Pietro Commarata Prix de la mise en scène (Ours d'argent) (Salvatore Giuliano), Frank Wolff (Gas au festival de Berlin 1962. Ditt. : J. A. pare Pisciotta), Salvo Randone (le prési Lapointe Films Inc. -

Florence February 2016 Piero Malvestiti
Florence February 2016 Piero Malvestiti © European University Institute - Historical Archives of the European Union, 1994-2016 Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged, save where otherwise stated. Where prior permission must be obtained for the reproduction or use of textual and multimedia information (sound, images, software, etc.), such permission shall cancel the abovementioned general permission and indicate clearly any restrictions on use. More informations about Terms and Conditions of Use Historical Archives of the European Union 2 Piero Malvestiti Table of contents Piero Malvestiti ______________________________________________________________________________________________5 Prima guerra mondiale, antifascismo e Resistenza ___________________________________________________________6 Esilio in Svizzera, Resistenza e Repubblica dell'Ossola _________________________________________________________7 Corrispondenza del periodo clandestino ______________________________________________________________ 10 Stampa del periodo clandestino _____________________________________________________________________ 11 Attività politica e pubblicistica del secondo dopoguerra _____________________________________________________ 12 Sottosegretario alle Finanze (governo De Gasperi IV) _______________________________________________________ 17 Sottosegretario al Tesoro (governi De Gasperi V e VI) _______________________________________________________ 17 Comitato IMI-ERP ________________________________________________________________________________