Download (492Kb)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

ROLLI DAYS Palazzi, Ville E Giardini Genova, 28 - 29 Maggio 2016
ROLLI DAYS palazzi, ville e giardini Genova, 28 - 29 maggio 2016 I Palazzi dei Rolli, Patrimonio dell’Umanità UNESCO IL SISTEMA DEI PALAZZI DEI ROLLI I PALAZZI DEI ROLLI Nel 2016 ricorre il decennale del riconoscimento da parte dell’UNESCO del sito “Le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli” , conferito nel 2006. Per celebrare l’anniversario, Genova propone tre edizioni dei Rolli Days: ) o c 2-3 Aprile, 28-29 maggio, 15-16 ottobre n a i B 2016 marks the tenth anniversary of UNESCO’s recognition of "The Strade Nuove and the o z system of the Palazzi dei Rolli" as a World Heritage Site in 2006. z a l To celebrate this anniversary, Genoa will be putting on three editions of the Rolli Days in 2016: a P ( i April 2-3, May 28-29 and October 15-16 d l a m i r G Il sito UNESCO “Genova, le Strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolli” conserva spazi urbani unitari di epoca a c u tardo-rinascimentale e barocca, fiancheggiati da oltre cento palazzi di famiglie nobiliari cittadine. Le maggiori L o dimore, varie per forma e distribuzione, erano sorteggiate in liste ufficiali (rolli) per ospitare le visite di Stato. I palazzi, z z a spesso eretti su suolo declive, articolati in sequenza atrio-cortile-scalone-giardino e ricchi di decorazioni interne, l a P esprimono una singolare identità sociale ed economica che inaugura l’architettura urbana di età moderna in Europa. i d L’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale conferma l’eccezionale valore universale di un sito culturale che o n i merita di essere protetto per il bene dell’umanità intera. -
© in This Web Service Cambridge University
Cambridge University Press 978-1-107-06236-8 - Imperial Ambition in the Early Modern Mediterranean: Genoese Merchants and the Spanish Crown Céline Dauverd Index More information Index Abulafia, David, x, 10, 13–14, 24, 26–28, Caffa, 28–29 36–37, 39, 67, 86, 111, 113–114, 116, Campanella, Tommaso, 55, 70–71, 79–80 120, 128, 256 Canny, Nicholas, 15 acculturation, of Genoese, in Kingdom of Capaccio, Giulio Cesare, 56–57, 61–62, Naples, 4 134, 188 Adorno family, 63–64 capitalism, 15, 249–250 Alba, Viceroy Duke of, 137, 141–143, 153 Caracciolo, Battistello, 193 alberghi (clans), 10 Caracciolo, Francesco, 144–145 Alcalá, Viceroy Duke of, 143, 156 Carafa, Count Diomede, 93 Alfonso I (king of Naples), 86 Castillians, rapprochement between Genoese Alfonso the Magnanimous (king), 170–171 and, 57–65 Alfonso V of Aragón (king), 59 Castro, Viceroy Francisco de, 51–52 Americas, Spanish trade with, 155 Catalans, Genoese and, in southern Italy, Annunziata, 222–224, 228–233 1300–1500, 113–127 asientos (short-term loans at high interest), 12–13 Cataponte, Marino di, 88–89 Catherine of Genoa, Saint, 224 Banco di San Giorgio, 61 Catlos, Brian, xi, 26, 258 banking Cavensi, Pietro, 88–89 Genoese and, 68–70, 238 Centurione family, 58, 61, 63 Barbarossa, Khayr al-Din (corsair), 33, 44 Centurione, Christoforo, 143 Bartlett, Robert, 17–18 Centurione, Don Carlo, 49 Battista Alberti, Leon, 217 Centurione, Giulio (Baron of Crispano), 78–79 Battista del Tufo, Giovanni, 181–182 Centurione, Ottavio, 154–155 Bâyezîd II (sultan), 30 Cerda, Viceroy Juan de la, 46 Benavente, -

05 Nada Zecevic.Vp
Zbornik radova Vizantolo{kog instituta HßÇÇ, 2005. Recueil des travaux de l’Institut d’etudes byzantines XßIÇ, 2005 UDC: 341.71(450.421)(093):929 Nada Ze~evi} THE GENOESE CITIZENSHIP OF CARLO I TOCCO OF DECEMBER 2, 1389 (II) The Genoese citizenship, granted to Carlo I Tocco and his regent mother Magda- lene by the authorities of the Republic of Genova (December 2, 1389) is a document the existence of which is widely accepted in the scholarly circles despite the fact that the details of its content have still remained largely unknown. Attempting to contribute to a better understanding of the circumstances under which the grant was issued, the first part of this paper brings the transcription of the entire document as well as an analysis of its political and legal context. The paper's second part deals with the docu- ment's paleographic, diplomatic, and sigillographic features, as well as with its prosopographic and topographic details. On December 2, 1389 Carlo I Tocco and his regent mother Magdalena were granted the citizenship of the Republic of Genoa. This act was, as pointed out in the first part of this paper, most probably a consequence of the Tocco need for protection from the Ottoman, Venetian, Navarese, and Albanian expansions in western Greece as well as of the Genoese aspirations towards the Ionian islands governed by this family.1 However, although at first sight this document seems an important demon- stration of a pragmatic political alliance, it never left the domain of protocol. Its im- plementation was never recorded by any of the parties; in fact, short time upon its ratification, the Tocco ruler was recorded as making alliances with the Genoa’srival, the Venetian Republic.2 1 For the text of the document and historical analysis of its contents see N. -

Niccolo Machiavelli
HISTORICAL, POLITICAL, AND DIPLOMATIC WRITINGS OF NICCOLO MACHIAVELLI TRANSLATED FROM THB ITALIAN BY CHRISTIAN E. DETMOLD IN FOUR VOLUMES VOL. I. BOSTON JAMES R. OSGOOD AND COMPANY I882 Copynghf, 1882, CHRISTIANE. DETMOLD. BY - All rights reserved. UNIVERSITYPRESS: JOHN WILSONAND SON, CAMBRIDGS. C 0 R RI G EN’D A. -----t VOLUMEI. Page 143, lines 9 and 10 from top, instead of “ state their wishes to the rioters,” read, “learn the wishes of the rioters.” VOLUME11. Page 52. ‘1 THE PRINCE?”chapter 16, 3d line, instead of the words, ‘1 indulged in so that you will no longer be feared, will prove injurious. For liberality worthily exercised, as it should he, will not be recognized,” read, ‘1 practised so that you are not repufed liberal, will injure you. For iibitralit’y worthily exercised, as it should he, will not be known ,’ ’ &c. * K0.m. * This erroneous translation resulted from a difference in the text of the Testine Edition (1550),which wah used by me in the translation of “The Prince.” Page 39, chap. 16, 2d and 3d lines, read “ Knndimnnco la liheralita usata in modo, ahe tu non sia tem~to,ti offeiitle.” It should be, ‘I che tu non sia tenato.” c. E. I). TRANSLATOR’S PREFACE. INoffering the present translation of Machiavelli’s principal historical, political, and diplomatic writings, my original object was simply to afford to the general reader the opportunity of judging for himself of the character of the man, and of those of his works upon which his reputation for good or for evil mainly depends. -

Dynamic Doorways: Overdoor Sculpture in Renaissance Genoa
DYNAMIC DOORWAYS: OVERDOOR SCULPTURE IN RENAISSANCE GENOA By ©2012 MADELINE ANN RISLOW Submitted to the graduate degree program in Art History and the Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. ________________________________ Chairperson Sally J. Cornelison, Ph.D. ________________________________ George L. Gorse, Ph.D. ________________________________ Steven A. Epstein, Ph.D. ________________________________ Stephen H. Goddard, Ph.D. ________________________________ Anthony Corbeill, Ph.D. Date Defended: 4/6/2012 The Dissertation Committee for Madeline Ann Rislow certifies that this is the approved version of the following dissertation: DYANAMIC DOORWAYS: OVERDOOR SCULPTURE IN RENAISSANCE GENOA ________________________________ Chairperson Sally J. Cornelison, Ph.D. Date approved: 4/6/2012 ii Abstract Soprapporte—rectangular, overdoor lintels sculpted from marble or slate—were a prominent feature of both private residential and ecclesiastic portals in the Ligurian region in northwest Italy, and in particular its capital city Genoa, during the second half of the fifteenth and early sixteenth centuries. Sculpted site- or city-specific religious narratives occupy the centers of most soprapporte, and are typically framed with the coats of arms or the initials of their patrons. As this study demonstrates, soprapporte were not merely ornamental, for they acted as devotional objects and protective devices while connecting the citizens who commissioned them to -

Dossier Pédagogique
U museu di Bastia Museum of Bastia Una via pedagogica An educational trail Fonte di risorse pedagogiche A source location of educational richness - 1 - Director of publication: Jean-Marie Panazol Academic director of Réseau Canopé Corse: Brigitte Réquier Project Manager: Vincent Andriuzzi Educational contribution: Marie-Elise Ucciani Jean-Marc Pellegri Sylvain Gregori Ariane Jurquet Associu U Pinziglione English translationr: Laura Caporossi © Réseau Canopé, 2019 (établissement p u b l i c à caractère administratif ) Téléport 1 Bât. @ 4 1, avenue du Futuroscope CS 80158 86961 Futuroscope Cedex © Crédits photos: Musée de Bastia; Canopé; Vincent Andriuzzi Tous droits de traduction, de reproduction et d’adap- tation réservés pour tous pays. Le Code de la pro- priété intellectuelle n’autorisant, aux termes des articles L.122-4 et L.122-5, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustra- tion, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ». Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français de l’exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris) constitueraient donc une contrefaçon sanctionnée. - 2 - Summary PRESENTATION AND ISSUES 5 Introduction 7 The Palace of the Governors: Historical Marks 19 Rencontre avec Sylvain Gregori, Directeur du musée de Bastia 21 Map of the Museum MUSEOGRAPHY ROOMS 24 The mezzanine floor 25 Le ground floor 27 The first floor CHOSEN PIECES 32 Rooms 1 to 5. -

Christine Shaw: the French Signoria Over Genoa, 1458-1461
Christine Shaw: The French Signoria over Genoa, 1458-1461 Schriftenreihe Ricerche dell'Istituto Storico Germanico di Roma Band 6 (2011) Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat der Creative- Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine Bearbeitung (CC BY-NC-ND 4.0) unterliegt. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode Christine Shaw The French Signoria over Genoa, 1458-1461 The brief period – less than three years, from May 1458 to March 1461 – during which the republic of Genoa came under the signoria of the King of France in the mid-fifteenth century, has attracted very little attention from his- torians. It was not only shorter, but also less dramatic, than the other periods of French signoria over Genoa at the beginning of the century, from 1396 to 1409, and at the end, from 1499 to 1512, which have been studied in some de- tail. But it does repay closer scrutiny, not least because of what can be learned from it about Genoese attitudes to the submission of their city and republic to a lord, and what they believed the nature of that signoria should be. Citing the arguments advanced by French jurists, Fabien Levy has sug- gested that from the first period of French rule over Genoa, the city was con- sidered by the French to be a ville de France, not just subject to the personal lordship of the king, but forming part of the dominion of the crown. -
General Index
Cambridge University Press 978-0-521-26021-3 — Medieval European Coinage William R. Day, Jr , Michael Matzke , Andrea Saccocci , General editor Elina Screen Index More Information GENERAL INDEX Ordinary type indicates pages, bold type catalogue entries. The index covers mainly personal names and place names together with exceptional denomina- tions (e.g. pegione, bagattino, etc.) and references to speciic issues of individual mints. It does not cover more generic references to denominations such as denaro and grosso except where such terms are explained. Personal and place names are given in the forms and spellings used in the text, with cross-references where Latin or other forms diverge appreciably from these. Persons of the same name are placed in the customary sequence of saints, popes, emperors, sovereigns in alphabetical order of the states they ruled, and others in whatever order seems best adapted for easy reference. Names of modern scholars, and names in the section ‘Collectors, dealers and donors’ that precedes the main catalogue,have not been indexed.Coin hoards and inds are indexed in alphabetical order by ind type under the heading coin inds. Aachen (Germany), Peace (812), 627; renewal (840), 628 Adige, river and/or valley,65, 554, 606, 607, 618, 631, 653 Abati, lords, 101 administrative reforms, early tenth century,35; early Abbiategrasso (Lombardy), 484, 501 fourteenth century,80 Abundus or Abundius, saint, patron of Como, 84, 87, 365, Adolph of Nassau, king of Germany,3, 208 368, 369, 370, 710 Adorno, family,of Genoa, 298, -
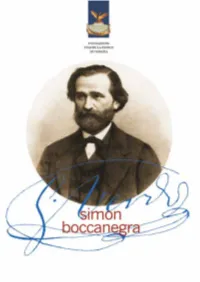
Simon Boccanegra
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA LA FENICE PER VERDI 2001 SIMON BOCCANEGRA Si ringrazia per la collaborazione Ritratto di Giuseppe Verdi. (1851). 2 FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA SIMON BOCCANEGRA musica di GIUSEPPE VERDI PALAFENICE AL TRONCHETTO versione Milano 1881 Venerdì 26 gennaio 2001, ore 20.00, turno A Domenica 28 gennaio 2001, ore 15.30, turno B Martedì 30 gennaio 2001, ore 20.00, turno D Giovedì 1 febbraio 2001, ore 20.00, turno E Sabato 3 febbraio 2001, ore 15.30, turno C versione Venezia, Teatro La Fenice 1857 Venerdì 2 febbraio 2001, ore 20.00, fuori abb. in forma di concerto 3 —————— Edizioni dell’Ufficio Stampa del TEATRO LA FENICE Responsabile Cristiano Chiarot Coordinamento musicologico e redazionale Carlida Steffan Hanno collaborato Pierangelo Conte, Giorgio Tommasi Ricerca iconografica Maria Teresa Muraro Copertina Tapiro Pubblicità In copertina AP srl Torino GIUSEPPE VERDI VeNet Venezia (Roncole di Bussetto, Parma 1813 - Milano 1901) 4 SOMMARIO 7 LA LOCANDINA 11 I LIBRETTI 70 SIMON BOCCANEGRA IN BREVE 73 STRUTTURA MUSICALE DELL’OPERA 76 ARGOMENTO - ARGUMENT - SYNOPSIS - HANDLUNG 95 MARCELLO CONATI UN’OPERA SOLA, DUE DRAMMI DIVERSI GENESI E VICENDE DEL SIMON BOCCANEGRA 135 DANIELA GOLDIN FOLENA SIMÓN BOCANEGRA DA VERDI A PIAVE A BOITO 145 MARCO BEGHELLI DA VENEZIA A MILANO IL LIFTING VOCALE DEI CINQUE PROTAGONISTI 155 HAROLD S. POWERS ANALIZZANDO SIMON BOCCANEGRA 175 LAURA MEGNA SIMONE BOCCANEGRA E IL DOGADO A GENOVA 185 CARMELO DI GENNARO INTERVISTA A ELIO DE CAPITANI 188 SIMON BOCCANEGRA ALLA FENICE 195 GIUSEPPE VERDI a cura di MIRKO SCHIPILLITI 219 BIBLIOGRAFIA PER IL CENTENARIO a cura di GILDO SALERNO 227 BIOGRAFIE 5 Carlo Sala, bozzetto per Simon Boccanegra. -

Grain Distribution and the Emergence of Popular Institutions in Medieval Genoa
GRANUM BONUM: GRAIN DISTRIBUTION AND THE EMERGENCE OF POPULAR INSTITUTIONS IN MEDIEVAL GENOA A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA BY JOHN ANDREW MANKE IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY ADVISOR, DR. KATHRYN REYERSON DECEMBER, 2019 Copyright Ó John Andrew Manke, December 2019 AcknowledgementS There are many people to thank for thiS diSSertation. First and foremost, I would like to take the opportunity to thank my adviSer, Dr. Kathryn Reyerson, whose tireleSS help waS invaluable. Without her advice, encouragement, and many editS, thiS diSSertation would not have been posSible. Many thanks to my committee: Dr. Giancarlo CaSale, Dr. Michael Lower, Dr. Oliver NicholSon, and Dr. JameS Tracy I would like to thank my parentS who Supported me throughout thiS experience in a number of ways. Of course, I mUSt thank the Staff at the Archivio di Stato for their patience with my broken Italian. I would have never been SucceSSful in my SearcheS without the guidance of Dr. Emily Sohmer-Tai and Dr. Antonio MUSarra, who provided me with advice and paleographic experience. For emotional Support, I thank my colleagueS in the graduate office, eSpecially WeSley LummUS, Brooke Depenbusch, Gabrielle Payne, and MeliSSa Hampton. I extend my SincereSt thanks to Anahita Mehta, who actually read thiS work and provided grammatical advice. And finally, thank you Luna, you have been a source of constant support. i Granum Bonum: Grain diStribution and the emergence of popular institutions -

ROLLI DAYS Palazzi, Ville E Giardini Genova, 28 - 29 Maggio 2016
ROLLI DAYS palazzi, ville e giardini Genova, 28 - 29 maggio 2016 I Palazzi dei Rolli, Patrimonio dell’Umanità UNESCO IL SISTEMA DEI PALAZZI DEI ROLLI I PALAZZI DEI ROLLI Nel 2016 ricorre il decennale del riconoscimento da parte dell’UNESCO del sito “Le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli” , conferito nel 2006. Per celebrare l’anniversario, Genova propone tre edizioni dei Rolli Days: ) o c 2-3 Aprile, 28-29 maggio, 15-16 ottobre n a i B 2016 marks the tenth anniversary of UNESCO’s recognition of "The Strade Nuove and the o z system of the Palazzi dei Rolli" as a World Heritage Site in 2006. z a l To celebrate this anniversary, Genoa will be putting on three editions of the Rolli Days in 2016: a P ( i April 2-3, May 28-29 and October 15-16 d l a m i r G Il sito UNESCO “Genova, le Strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolli” conserva spazi urbani unitari di epoca a c u tardo-rinascimentale e barocca, fiancheggiati da oltre cento palazzi di famiglie nobiliari cittadine. Le maggiori L o dimore, varie per forma e distribuzione, erano sorteggiate in liste ufficiali (rolli) per ospitare le visite di Stato. I palazzi, z z a spesso eretti su suolo declive, articolati in sequenza atrio-cortile-scalone-giardino e ricchi di decorazioni interne, l a P esprimono una singolare identità sociale ed economica che inaugura l’architettura urbana di età moderna in Europa. i d L’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale conferma l’eccezionale valore universale di un sito culturale che o n i merita di essere protetto per il bene dell’umanità intera. -

Genoese Economic Culture: from the Mediterranean Into the Spanish Atlantic
Genoese Economic Culture: from the Mediterranean into the Spanish Atlantic. Thesis submitted in accordance with the requirements of the University of Liverpool for the degree of Doctor in Philosophy by Matteo Salonia January 2015 Table of contents. Abstract………………………………………………………………………………………………..........ii Acknowledgements………………………………………………………………………………….......iii Introduction……………………………………………………………………………………………….iv Part I – Colonial Entrepreneurship and libertà 1. Culture, economy, and everyday life in late medieval Genoese colonies..……………………………………………………………………………………………………1 2. The business network of Giovanni da Pontremoli: diversified trade and movement of capital in the Genoese colonial system……………………………………………………………..42 3. Self-government and self-perception: anti-tyrannical institutions and the Genoese identity………………………………………………………………………………….............................59 Part II – Spain’s “Diabolical” Friends 4. Ferdinand the Catholic’s perception of the Genoese and of their role in his economic policy………………………………………………………………………………………………….…107 5. Rejecting the “Machiavellian” state. Genoa’s regimes from the French fury to the second Hispanic-Genoese alliance………………………………………………………...………………...124 6. Beginnings of a mimetic empire? Tracing the Genoese experience in sixteenth-century Spanish America……………………………………………………………………………..………..167 Conclusion……………………………………………………………………………………………...196 Bibliography…………………………………………………………………………………….……...202 Abstract. This thesis investigates the economic culture that fostered the constitutional history and