Archivio Storico La Calabria E La Lucania
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Essays on British Women Poets B Studi Di Letterature Moderne E Comparate Collana Diretta Da Claudia Corti E Arnaldo Pizzorusso 15
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Florence Research ESSAYS ON BRITISH WOMEN POETS B STUDI DI LETTERATURE MODERNE E COMPARATE COLLANA DIRETTA DA CLAUDIA CORTI E ARNALDO PIZZORUSSO 15 SUSAN PAYNE ESSAYS ON BRITISH WOMEN POETS © Copyright 2006 by Pacini Editore SpA ISBN 88-7781-771-2 Pubblicato con un contributo dai Fondi Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo di Firenze Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall’editore. to Jen B CONTENTS Introduction . pag. 7 Renaissance Women Poets and the Sonnet Tradition in England and Italy: Mary Wroth, Vittoria Colonna and Veronica Franco. » 11 The Poet and the Muse: Isabella Lickbarrow and Lakeland Romantic Poetry . » 35 “Stone Walls do not a Prison Make”: Two Poems by Alfred Tennyson and Emily Brontë . » 59 Elizabeth Barrett Browning: The Search for a Poetic Identity . » 77 “Love or Rhyme”: Wendy Cope and the Lightness of Thoughtfulness . » 99 Bibliography. » 121 Index. » 127 B INTRODUCTION 1. These five essays are the result of a series of coincidences rather than a carefully thought out plan of action, but, as is the case with many apparently haphazard choices, they reflect an ongoing interest which has lasted for the past ten years. -
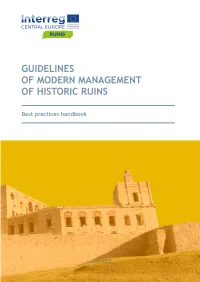
Guidelines of Modern Management of Historic Ruins : Best Practices
Institutions participating in the elaboration of the publication: Lublin University of Technology (Poland) Matej Bel University (Slovakia) The Institute of Theoretical and Applied Mechanics of The Czech Academy of Sciences (Czech Republic) Polish National Committee of The International Council on Monuments and Sites Icomos (Poland) City of Zadar (Croatia) Links Foundation – Leading Innovation and Knowledge for Society (Italy) Italian Association for The Council of Municipalities and Regions of Europe (Italy) Venetian Cluster (Italy) Municipality of Velenje (Slovenia) Zadar County Development Agency Zadra Nova (Croatia) Team of authors: Bugosław Szmygin (project coordinator) Maciej Trochonowicz Miloš Drdácký Alenka Rednjak Bartosz Szostak Jakub Novotný Marija Brložnik Andrzej Siwek Patrizia Borlizzi Rudi Vuzem Anna Fortuna-Marek Antonino Frenda Marko Vučina Beata Klimek Silvia Soldano Jernej Korelc Katarzyna Drobek Marco Valle Darja Plaznik Ivan Murin Raffaella Lioce Danijela Brišnik Dagmara Majerová Dario Bertocchi Breda Krajnc Jana Jaďuďová Camilla Ferri Urška Todorovska-Šmajdek Iveta Marková Daniele Sferra Milana Klemen Kamila Borseková Sergio Calò Lucija Čakš Orač Anna Vaňová Maurizio Malè Branka Gradišnik Dana Benčiková Eugenio Tamburrino Urška Gaberšek Ivan Souček Patricija Halilović Krasanka Majer Jurišić Martin Miňo Rok Poles Boris Mostarčić Jiří Bláha Marija Ževart Iva Papić Dita Machová Helena Knez Wei Zhang Drago Martinšek Publication within project “RUINS: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences”, supported by the Interreg CENTRAL EUROPE Programme funded under the European Regional Development Fund. GUIDELINES OF MODERN MANAGEMENT OF HISTORIC RUINS BEST PRACTICES HANDBOOK Guidelines for modern management of historic ruins. -

Lago Di Garda • Lake Garda • Gardasee
GARD MORE LAGO DI GARDA • LAKE GARDA • GARDASEE SALÒ LAZISE EVENTS ITINERARIES OF GARDA ISSN 2499-7730 ANNO 4 • N. 7 | PRIMAVERA 2019 | € 3,50 CIERRE GRAFICA “L’UNIONE FA LA FORZA” nei tempi moderni. OUR SERVICES - promozione d el territorio in - d epliant web - loc and ine - menu - app native - c artelline - - le a 360° info@ga rda -ma rketing.com LAKEGARDA Lago di Garda - Lake Garda www.pilandro.com PILANDRO WINE SHOP Degustazioni - Wine tasting - Wein proben Orari di apertura / Opening Hours / Öffnungszeiten Lunedì-Sabato / Monday-Saturday / Montag-Samstag 8.30-12.30/14.00-18.00 Domenica / Sunday / Sonntag 8.30-12.30 Località Pilandro, 1 - Desenzano del Garda (BS) (Uscita/Exit/Ausfahrt: A4 Sirmione) GPS: N 45° 44’ 10” E 10° 61’ 17” T. +39 030 991 0363 www.pilandro.com - [email protected] - [email protected] GARD MORE ADVERTISERS THANKS TO ANNO 4 • N. 7 | PRIMAVERA 2019 YEAR 4 • No. 7 | SPRING 2019 JAHRGANG 4 • Nr. 7 | FRÜHLING 2019 II Web, Print and Ideas Garda Marketing Semestrale di Territorio, Turismo, Cultura Registro Stampa n. 2073, Tribunale di Verona Wine tasting Direttore Responsabile Claudia Farina - 347 42 82 583 1 [email protected] Pilandro Redazione Alvaro Ioppi - 349 23 26 094 Collaboratori Shopping Francesca Gardenato, Stefano Ioppi, Elisa Turcato 6-7 Elnòs Shopping Progetto grafco e impaginazione Marco Castagna Traduzioni logoService - Brescia Stampa Cierre Grafca Fashion & Design Via Ciro Ferrari 5, Caselle di Sommacampagna (VR) 28-29 tel. 045 8580900 - www.cierrenet.it Pelletteria Charlotte Distributore per Verona e Lago di Garda Ag. Sidetra s.r.l. -

CASTELLAN MEETINGS 2010 San Colombano Al Lambro – March 21St, 2010 Piacenza – June 2Nd, 2010 Rovato – September 26Th, 2010 Vigoleno of Vernasca – October 10Th, 2010
Tansini.it – Historical research and divulgation CASTELLAN MEETINGS 2010 San Colombano al Lambro – March 21st, 2010 Piacenza – June 2nd, 2010 Rovato – September 26th, 2010 Vigoleno of Vernasca – October 10th, 2010 What: researches about Middle and Modern Ages fortifications. Where: San Colombano al Lambro (Milan), Piacenza, Rovato (Brescia), Vigoleno of Vernasca (Piacenza). How: informal meetings (Italian language). When: from March to October 2010. Info: mobile (+39) 349 2203693, e-mail [email protected]. A topic not much tackled in divulgation works concerning the fortified architecture’s its influence upon historical developments which led to our days’ reality. In facts, the explanations given to the public often confine themselves to examine some structure details or to exalt – if not ‘reinventing’ – some chronicle episodes; vice versa, they can result technical and sectorial, suitable only for ‘experts’. What Davide Tansini proposes with Castellan meetings [Incontri castellani] it’s a particular approach to castled architecture: well-contextualized and documented discussions, in a strongly interactive relation with the people who take part in. Simpleness, consistency and clearness are the ingredients of this communicative formula, which amalgamates a scrupulous historic-scientific method to a reserved and cordial conversation. The subject chosen for 2010 are the connections among some types of fortifications: borgo, castle, rocca, town walls and citadel. Title of this meetings series is …not to trust’s better! […non fidarsi è meglio!], which sums up the problematical cohabitation among the different elements which every day referred to the fortifications: civilian and military, social and environmental, economical and cultural. Four the localities chosen to outline thanks their ancient fortalices Castellan meeting’s tread. -

PDF Download
I I I t I '. i* .-*.Jß{ffrtllr' r 5'!'s€iE***i'*" I I -*[:,!$$FT I ,nL !81 I 1 ,\!r , '..,t ?ilt 10O% AfChäOlOgie SChWeiZ i00 der schönsten archäologischen objekte der schweiz: ein Führer 1OO% ArCh6OlOgie SUiSSe Les 100 plus beaux sites arch6ologiques de Suisse: un guide .i t: .. I ilF,r 100% AfCheOlOgia SViZzefa 100 fra i piü bei siti archeologici della Svizzera: una guida r ;p I ,. i, l, r Archäologie Schweiz - Arch6ologie Suisse - Archeologia Svizzera, Basel 2007 n n r-t Herausgegeben von Archäologie Schweiz l-1 rlr- 'l- ln Zusammenarbeit mit den kantonalen archäologischen Diensten \l- -l Projektleitung: Urs Niffeler, Catherine May Castella, r'1 Simonetta Biaggio Simona und Urs Leuzinger f-l Verfasst von zahlreichen Autorinnen und Autoren (s. S. 123) Entstanden dank der Mitarbeit vieler Beteiligter (s. S. 125) .{ {*^l Die Herstellung wurde unterstützt durch die {-- I Loterie Romande Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW Avec le soutien de la @ i1 lsBN 978-3-908006-69-5 O by Archäologie Schweiz - Arch6ologie Suisse - Archeologia Svizzera, Basel 2007 n n r f n n tl TT : t-r tl {l 1OO% AfChäOlOgie SChWeiZ 100 der schönsten archäotogischen objekte der schweiz: ein Führer C lOO% Afch6ologie Suisse Les 100 plus beaux sites archdologiques de Suisse: un guide {__, 1OO% AfCheOlOgia SVizzerä 100 fra i piü beisiti archeologicidetta Svizzera: una guida U U U L Archäologie Schweiz - Archdologie Suisse - Archeologia Svizzera, Basel 2007 Reiter, Hund und Pflanze. Bronzene SchildbeschläSteile (Sespiegelt) aus einem Langobardenkriegergrab in Stabio fl, Z lh. n.Chr. Höhe Pferd plus Reiter 8,2 cm. -

Dante's Inferno</H1>
Dante's Inferno Dante's Inferno The Divine Comedy of Dante Alighieri Translated by Henry Wadsworth Longfellow Volume 1 This is all of Longfellow's Dante translation of Inferno minus the illustrations. It includes the arguments prefixed to the Cantos by the Rev. Henry Frances Carey, M,.A., in his well-known version, and also his chronological view of the age of Dante under the title of What was happening in the World while Dante Lived. If you find any correctable errors please notify me. My email addresses for now are [email protected] and [email protected]. David Reed Editorial Note page 1 / 554 A lady who knew Italy and the Italian people well, some thirty years ago, once remarked to the writer that Longfellow must have lived in every city in that county for almost all the educated Italians "talk as if they owned him." And they have certainly a right to a sense of possessing him, to be proud of him, and to be grateful to him, for the work which he did for the spread of the knowledge of Italian Literature in the article in the tenth volume on Dante as a Translator. * * * * * The three volumes of "The Divine Comedy" were printed for private purposes, as will be described later, in 1865-1866 and 1877, but they were not actually given to the public until the year last named. Naturally enough, ever since Longfellow's first visit to Europe (1826-1829), and no doubt from an eariler date still, he had been interested in Dante's great work, but though the period of the incubation of his translation was a long one, the actual time engaged in it, was as he himself informs us, exactly two years. -

Dante Alighieri's Divine Comedy – Inferno
DIVINE COMEDY -INFERNO DANTE ALIGHIERI HENRY WADSWORTH LONGFELLOW ENGLISH TRANSLATION AND NOTES PAUL GUSTAVE DORE´ ILLUSTRATIONS JOSEF NYGRIN PDF PREPARATION AND TYPESETTING ENGLISH TRANSLATION AND NOTES Henry Wadsworth Longfellow ILLUSTRATIONS Paul Gustave Dor´e Released under Creative Commons Attribution-Noncommercial Licence. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ You are free: to share – to copy, distribute, display, and perform the work; to remix – to make derivative works. Under the following conditions: attribution – you must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work); noncommercial – you may not use this work for commercial purposes. Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. English translation and notes by H. W. Longfellow obtained from http://dante.ilt.columbia.edu/new/comedy/. Scans of illustrations by P. G. Dor´e obtained from http://www.danshort.com/dc/, scanned by Dan Short, used with permission. MIKTEXLATEX typesetting by Josef Nygrin, in Jan & Feb 2008. http://www.paskvil.com/ Some rights reserved c 2008 Josef Nygrin Contents Canto 1 1 Canto 2 9 Canto 3 16 Canto 4 23 Canto 5 30 Canto 6 38 Canto 7 44 Canto 8 51 Canto 9 58 Canto 10 65 Canto 11 71 Canto 12 77 Canto 13 85 Canto 14 93 Canto 15 99 Canto 16 104 Canto 17 110 Canto 18 116 Canto 19 124 Canto 20 131 Canto 21 136 Canto 22 143 Canto 23 150 Canto 24 158 Canto 25 164 Canto 26 171 Canto 27 177 Canto 28 183 Canto 29 192 Canto 30 200 Canto 31 207 Canto 32 215 Canto 33 222 Canto 34 231 Dante Alighieri 239 Henry Wadsworth Longfellow 245 Paul Gustave Dor´e 251 Some rights reserved c 2008 Josef Nygrin http://www.paskvil.com/ Inferno Figure 1: Midway upon the journey of our life I found myself within a forest dark.. -

The Vesuvius and the Other Volcanoes of Central Italy
Geological Field Trips Società Geologica Italiana 2017 Vol. 9 (1.1) I SPRA Dipartimento per il SERVIZSERVIZIOIO GGEOLOGICOEOLOGICO D’ITALIAD’ITALIA Organo Cartografico dello Stato (legge n°68 del 2-2-1960) ISSN: 2038-4947 The Vesuvius and the other volcanoes of Central Italy Goldschmidt Conference - Florence, 2013 DOI: 10.3301/GFT.2017.01 The Vesuvius and the other volcanoes of Central Italy R. Avanzinelli - R. Cioni - S. Conticelli - G. Giordano - R. Isaia - M. Mattei - L. Melluso - R. Sulpizio GFT - Geological Field Trips geological fieldtrips2017-9(1.1) Periodico semestrale del Servizio Geologico d'Italia - ISPRA e della Società Geologica Italiana Geol.F.Trips, Vol.9 No.1.1 (2017), 158 pp., 107 figs. (DOI 10.3301/GFT.2017.01) The Vesuvius and the other volcanoes of Central Italy Goldschmidt Conference, 2013 Riccardo Avanzinelli1, Raffaello Cioni1, Sandro Conticelli1, Guido Giordano2, Roberto Isaia3, Massimo Mattei2, Leone Melluso4, Roberto Sulpizio5 1. Università degli Studi di Firenze 2. Università degli Studi di Roma 3 3. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 4. Università degli Studi di Napoli “Federico II” 5. Università degli Studi di Bari Corresponding Authors e-mail addresses: [email protected] - [email protected] Responsible Director Claudio Campobasso (ISPRA-Roma) Editorial Board Editor in Chief M. Balini, G. Barrocu, C. Bartolini, 2 Gloria Ciarapica (SGI-Perugia) D. Bernoulli, F. Calamita, B. Capaccioni, Editorial Responsible W. Cavazza, F.L. Chiocci, Maria Letizia Pampaloni (ISPRA-Roma) R. Compagnoni, D. Cosentino, S. Critelli, G.V. Dal Piaz, C. D'Ambrogi, Technical Editor publishing group Mauro Roma (ISPRA-Roma) P. Di Stefano, C. -

Universi^ Micixsilms International
INFORMATION TO USERS This reproduction was made from a copy of a document sent to us for microfilming. While the most advanced technology has been used to photograph and reproduce this document, the quality of the reproduction is heavily dependent upon the quality of the material submitted. The following explanation of techniques is provided to help clarify markings or notations which may appear on this reproduction. 1. The sign or “target” for pages apparently lacking from the document photographed is “Missing Page(s)” . If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting through an image and duplicating adjacent pages to assure complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a round black mark, it is an indication of either blurred copy because of movement during exposure, duplicate copy, or copyrighted materials that should not have been filmed. For blurred pages, a good image of the page can be found in the adjacent frame. If copyrighted materials were deleted, a target note will appear listing the pages in the adjacent frame. 3. When a map, drawing or chart, etc., is part of the material being photographed, a definite method of “sectioning” the material has been followed. It is customary to begin filming at the upper left hand comer of a large sheet and to continue from left to right in equal sections with small overlaps. If necessary, sectioning is continued again-beginning below the first row and continuing on until complete. -

Typology 6: Military Structures
Typology 6: military structures Structures or environments for various purposes, strictly connected to wartime defence and offence. Although castles hold undeniable appeal, it was the collective notion of their ‘secret underground passages’ that first led to their exploration. Its very ‘genre’ is ascribable to the type of activity dealt with in speleology. For example, in relation to the position occupied by the ancient Praeneste, Strabone tells us that it not only had a natural defence but that it had underground walkways in all directions leading to the plains, which were both utilised as ‘secret passages’ and for the purposes of water supply. The point of the exploration is therefore to document other types of underground structures: wells, cisterns, warehouses, prisons, underground passages and connecting tunnels. Without of course calling off exploration and cognitive activity in those environments that only appear to be underground. Prior to the use of firearms, underground works inside the walls were not strictly necessary for defence purposes. Following their introduction, underground works immediately became a part of the fortification’s defence. In bastioned buildings, countermines and demolition installations generally constitute the most important defensive element. It should also be taken into account that over time and following partial destruction and burial or subsequent urban repairs, raised sections could end up below the level of adjacent ground. Defence works have been created almost everywhere, using different types of materials and sometimes using existing works. They can be used in the defence of houses, in territory control or in the defence of obligatory passages through valleys or along rivers. -

FROM DARKNESS to LIGHT WRITERS in MUSEUMS 1798-1898 Edited by Rosella Mamoli Zorzi and Katherine Manthorne
Mamoli Zorzi and Manthorne (eds.) FROM DARKNESS TO LIGHT WRITERS IN MUSEUMS 1798-1898 Edited by Rosella Mamoli Zorzi and Katherine Manthorne From Darkness to Light explores from a variety of angles the subject of museum ligh� ng in exhibi� on spaces in America, Japan, and Western Europe throughout the nineteenth and twen� eth centuries. Wri� en by an array of interna� onal experts, these collected essays gather perspec� ves from a diverse range of cultural sensibili� es. From sensi� ve discussions of Tintore� o’s unique approach to the play of light and darkness as exhibited in the Scuola Grande di San Rocco in Venice, to the development of museum ligh� ng as part of Japanese ar� s� c self-fashioning, via the story of an epic American pain� ng on tour, museum illumina� on in the work of Henry James, and ligh� ng altera� ons at Chatsworth, this book is a treasure trove of illumina� ng contribu� ons. FROM DARKNESS TO LIGHT FROM DARKNESS TO LIGHT The collec� on is at once a refreshing insight for the enthusias� c museum-goer, who is brought to an awareness of the exhibit in its immediate environment, and a wide-ranging scholarly compendium for the professional who seeks to WRITERS IN MUSEUMS 1798-1898 proceed in their academic or curatorial work with a more enlightened sense of the lighted space. As with all Open Book publica� ons, this en� re book is available to read for free on the publisher’s website. Printed and digital edi� ons, together with supplementary digital material, can also be found at www.openbookpublishers.com Cover image: -
Joseph Haydn's
PINCHGUT OPERA JOSEPH HAYDN’S L’ANIMA DEL FILOSOFO: DON’T LOOK BACK 1 Orpheus_programme.indd 1 25/11/10 11:16 AM L’ANIMA DEL FILOSOFO: ORPHEUS + EURYDICE MusiC Joseph Haydn Libretto Carlo Francesco Badini CAst euridice / genio In order of appearance Elena Xanthoudakis th of September 1755, 17 orfeo the foundation of Vacheron Constantin. Andrew Goodwin Creonte Derek Welton Pluto Patrimony Contemporaine Craig Everingham Chorus Cantillation Orchestra of the Antipodes ConduCtor Antony Walker direCtor Mark Gaal designers Brad Clark & Alexandra Sommer Lighting designer Bernie Tan-Hayes AssistAnt ConduCtor Erin Helyard 2, 4, 5 & 7 December 2010, City Recital Hall Angel Place. There will be one interval of 20 minutes at the conclusion of Act II. The performance will inish at approximately 10.10 pm on Wednesday, Saturday and Monday, and 7.40 pm on Sunday. L’anima del ilosofo was formally commissioned in 1791 by John Gallini for the King’s Theatre in the Haymarket, London but remained unperformed until 1951 when it was presented at the Teatro della Pergola, Florence, with Maria Callas and Boris Christoff, conducted by Erich Kleiber. L’anima del ilosofo is being recorded live for CD release on the Pinchgut Opera label, and is being broadcast live on ABC Classic FM on Sunday 5 December. Any microphones you observe are for recording and not ampliication. The performance materials of L’anima del ilosofo by Joseph Haydn are published by G. Henle Verlag München and Bärenreiter-Edition Kassel, in the Urtext edition by Helmut Wirth. Performed by arrangement with Faber Music Ltd, London. sPonsors www.vacheron-constantin.com HEROES OF PINCHGUT SYDNEY: J Farren-Price Jewellers 02 9231 3299 - Swiss Concept 02 9221 6288 - Shum’s Watches & Jewellery 02 9211 1887 MELBOURNE: Monards 03 9650 9288 - The Hour Glass 03 9650 6988 2 3 SERVICE CENTRE - Richemont Australia Pty.