3.3 Il Bacino Del Fiume Cavone
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Comune Di San Mauro Forte Provincia Di Matera
COMUNE DI SAN MAURO FORTE PROVINCIA DI MATERA STRADA DI COLLEGAMENTO SAN MAURO FORTE CAVONICA Progetto di completamento per l'adeguamento della ex Strada Comunale DATA: PROGETTO PRELIMINARE Ottobre 2020 TAVOLA N. H RELAZIONE PAESAGGISTICA SCALA STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE IL PROGETTISTA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Rosario RACANIELLO Ing. Domenico TERRANOVA PROVINCIA DI MATERA --------------------------------------------------------- Area Tecnica Strada di collegamento San Mauro Forte – Cavonica Progetto di completamento per l’adeguamento della ex Strada Comunale RELAZIONE PAESAGGISTICA 1. PREMESSA La presente relazione paesaggistica, redatta ai sensi del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” di cui al D.P.C.M. 12/12/2005, a corredo del progetto relativo al progetto denominato «Strada di collegamento San Mauro Forte – Cavonica- Progetto di completamento per l’adeguamento della ex Strada Comunale» e contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell’intervento, con riferimento ai contenuti dei piani paesaggistici ovvero dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici. A tal fine la relazione, dotata di specifica autonomia d’indagine, fa riferimento agli elaborati tecnici redatti per motivare ed evidenziare la qualità dell’intervento in relazione al suo contesto. 2. INQUADRAMENTO SOCIO – ECONOMICO DELL’OPERA NEL CONTESTO TERRITORIALE La strada in progetto consentirà di ridurre l’isolamento infrastrutturale di una parte del territorio montano della Provincia di Matera ed in particolare del comune di San Mauro Forte mettendolo in comunicazione con alcuni degli assi viari più importanti della regione (Bradanica, Basentana, Saurina e Fondovalle dell’Agri). Il tracciato di progetto si svilupperà nel territorio amministrativo del Comune di San Mauro Forte in provincia di Matera. -

Terzo Cavone: Non È Un Deposito Integro
Terzo Cavone: non è un deposito integro Il condizionamento della tettonica recente nella valle del Cavone sulla circolazione dei fl uidi nel sottosuolo e la possibilità di localizzazione di un deposito di rifi uti radioattivi INFORMATION FROM THE VARIOUS La revisione del decreto con il quale presentazione, in un workshop a Messi- BRANCHES OF THE EARTH SCIENCES veniva individuato nel territorio di Scan- na, del profi lo di erosione del basamen- HAVE CONTRIBUTED TO DETERMINE A zano Ionico il sito per la realizzazione to di argille sulla stessa costa che forni- MODEL OF THE RECENT GEOLOGICAL del deposito nazionale unico delle sco- sce informazioni sulla sua evoluzione al- EVOLUTION OF THE TERRITORY, WHICH rie radioattive non può che essere ac- timetrica negli ultimi 18.000 anni. I risul- colto con sollievo e soddisfazione anche tati, sotto questo punto di vista rientra- IS THE REAL MEANS FOR THE EVALUATION nel mondo scientifi co, per la disponibili- no nella normalità: in questo momen- AND DESCRIPTION OF A SITE. tà del Governo a reimpostare il proble- to, nella zona, l’unica componente atti- THIS IS WHAT PROF. GIUSEPPE ma sulla base di approfondite verifi che va del sollevamento relativo mare terra SPILOTRO, WHO HOLDS THE CHAIR conoscitive. Si tratta di una scelta obbli- è dell’ordine di grandezza di quella gla- OF APPLIED GEOLOGY AND APPLIED gata, in quanto la delicatezza del proble- cioeustatica (1-2 mm / anno), che ha li- HYDRO-GEOLOGY AT THE ENGINEERING ma non permette approcci emotivi o di mite superiore in 60 m . Ma quando il DEPARTMENT OF THE UNIVERSITY altro genere. -

SAN MAURO FORTE E SALANDRA (MT)
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO Comuni di SAN MAURO FORTE e SALANDRA (MT) Località Serre Alte e Serre d’olivo A. PROGETTO DEFINITIVO DELL’IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI OGGETTO Codice: SMF Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e D.Lgs 152/2006 N° Elaborato: Piano di Caratterizzazione Ambientale A.18 Tipo documento Data Progetto definitivo Luglio 2019 Progettazione Progettisti Ing. Vassalli Quirino Proponente ITW San Mauro Forte Srl Via del Gallitello 89 | 85100 Potenza (PZ) P.IVA 02053100760 Ing. Speranza Carmine Antonio Rappresentante legale Emmanuel Macqueron REVISIONI Rev. Data Descrizione Elaborato Controllato Approvato 00 Luglio 2019 Emissione AM QV/AS/DR Quadran Italia Srl SMF_A.18_ Piano di Caratterizzazione Ambientale.doc SMF_A.18_ Piano di Caratterizzazione Ambientale.pdf Il presente elaborato è di proprietà di ITW San Mauro Forte S.r.l. Non è consentito riprodurlo o comunque utilizzarlo senza autorizzazione di San Mauro Forte S.r.l. ITW San Mauro Forte S.r.l. • Via del Gallitello, 89 • 85100 Potenza (PZ)• Italia P.IVA 02053100760 • [email protected] • [as,qv][am] SMF_A18_Piano Caratterizzazione Ambientale.doc 190730 ____________________ INDICE PREMESSA ........................................................................................ 4 1. DATI GENERALI DEL PROGETTO ......................................................... 5 1.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA ............................................................ 5 1.2 UBICAZIONE DEI SITI D’INTERVENTO -

BASILICATA Thethe Ionian Coast and Itsion Hinterland Iabasilicatan Coast and Its Hinterland a Bespoke Tour for Explorers of Beauty
BASILICATA TheTHE Ionian Coast and itsION hinterland IABASILICATAN COAST and its hinterland A bespoke tour for explorers of beauty Itineraries and enchantment in the secret places of a land to be discovered 2 BASILICATA The Ionian Coast and its hinterland BASILICATA Credit ©2010 Basilicata Tourism Promotion Authority Via del Gallitello, 89 - 85100 POTENZA Concept and texts Vincenzo Petraglia Editorial project and management Maria Teresa Lotito Editorial assistance and support Annalisa Romeo Graphics and layout Vincenzo Petraglia in collaboration with Xela Art English translation of the Italian original STEP Language Services s.r.l. Discesa San Gerardo, 180 – Potenza Tel.: +39 349 840 1375 | e-mail: [email protected] Image research and selection Maria Teresa Lotito Photos Potenza Tourism Promotion Authority photographic archive Basilicata regional department for archaeological heritage photographic archive Our thanks to: Basilicata regional department for archaeological heritage, all the towns, associations, and local tourism offices who made available their photographic archive. Free distribution The APT – Tourism Promotion Authority publishes this information only for outreach purposes and it has been checked to the best of the APT’s ability. Nevertheless, the APT declines any responsibility for printing errors or unintentional omissions. Last update May 2015 3 BASILICATABASILICATA COSTA JONICA The Ionian Coast and its hinterland BASILICATA MATERA POTENZA BERNALDA PISTICCI Start Metaponto MONTALBANO SCANZANO the itinerary POLICORO ROTONDELLA -

Relazione Rev.01 TAV A.Pdf
1 COMUNE DI MONTALBANO JONICO Regione Basilicata PROVINCIA DI MATERA PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE RELAZIONE GENERALE INDICE INTRODUZIONE PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 1. LE COMPETENZE DI INDIRIZZO, DI PIANIFICAZIONE ED OPERATIVE 2. LE PROCEDURE DI EMERGENZA 3. IL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 3.1 LE COMPONENTI DEL SISTEMA 3.1.1 IL SINDACO 3.1.2 IL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE 3.2 STRUTTURA DI COORDINAMENTO LOCALE 3.3 L'ORGANIZZAZIONE IN FUNZIONI DI SUPPORTO 3.4 IL CENTRO OPERATIVO MISTO 3.5 LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PRESENTI SUL TERRITORIO 4. OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 4.1 IL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE - STRUTTURA 4.1.1 DATI DI BASE E SCENARI DI RISCHIO 4.1.1.1 ANALISI TERRITORIALE 4.1.1.2 GLI SCENARI DI RISCHIO 4.1.1.2.1 Valutazione degli scenari di Rischio Sismico 4.1.1.2.2 Valutazione degli scenari del Rischio Dighe 4.1.1.2.3 Valutazione degli scenari di Rischio Idraulico 4.1.1.2.4 Valutazione degli scenari di Rischio Idrogeologico 4.1.1.2.5 Sistema di allertamento per il rischio idrogeologico d idraulico 4.1.1.2.6 Valutazione degli scenari di Rischio Incendi Boschivi 4.1.2 Individuazione dell' evento calamitoso di progetto 4.1.3 Le aree destinate a scopi di protezione civile 4.2 MODELLO OPERATIVO DI INTERVENTO 4.3 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 4.3.1 Comunicazione propedeutica 4.3.2 Informazione preventiva 4.3.3 Informazione in emergenza 4.3.4 Programma scuole 4.3.5 Formazione del personale 5. -
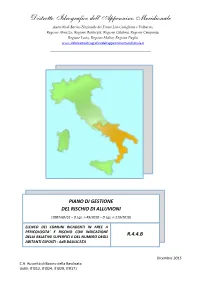
Elab. R 4 4 B
Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it __________________________________________________ PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (2007/60/CE – D.Lgs. n 49/2010 – D.Lgs. n.219/2010) ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN AREE A PERICOLOSITA’ E RISCHIO CON INDICAZIONE R.4.4.B DELLE RELATIVE SUPERFICI E DEL NUMERO DEGLI ABITANTI ESPOSTI - AdB BASILICATA Dicembre 2015 C.A. Autorità di Bacino della Basilicata UoM: ITI012, ITI024, ITI029, ITR171 ALLEGATO R.4.4.B DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO MERIDIONALE PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 49/2010, D.Lgs. 219/2010) RISULTATI NUMERICI SU BASE COMUNALE RICAVATI DALLE MAPPE DELLA PERICOLOSITA' E DALLE MAPPE DEL RISCHIO (*) feb-16 PERICOLOSITA' E RISCHIO DI ALLUVIONE FLUVIALE 2 2 AUTORITA' DI UoM BACINO ASTE INDAGATE HAZARD [m ] Estensione massima RISK [m ] Totale complessivo Numero abitanti Pr. COMUNE PROVINCIA REGIONE Totali progressivi NOTE BACINO principale (corsi d'acqua con aree a pericolosità e rischio) 2 2 P1 P2 P3 [m ] R1 R2 R3 R4 [m ] a rischio ITR171 1 Aliano MT BASILICATA Agri Agri 19040 333435 2865286 3217760 1888336 988882 103671 236870 3217760 20 BASENTO/CAVONE/AGRI ITR171 Armento PZ BASILICATA Agri Agri 494 432 1026653 1027580 246661 196003 9193 575723 1027580 52 BASENTO/CAVONE/AGRI 2 ITR171 3 Gallicchio -

Environmental Hazards and Society: Landsliding in Basilicata, Italy, with Specific Reference to Grassano
1 Environmental Hazards and Society: Landsliding in Basilicata, Italy, with Specific Reference to Grassano by Stuart Oliver A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at the The London School of Economics and Political Science May 1993 UMI Number: U091966 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U091966 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 POLITICAL \ JL> oo O oo N) CA 2 A b s tra c t This dissertation takes a realist approach to examine landsliding in the Basilicata region of Italy, with specific reference to the municipality of Grassano, in order to understand humankind’s role in contributing to environmental hazards. It concludes that environmental hazards such as landslides have partiy-social causes, which are characteristic of the societies they affect, and any real accommodation with environmental hazards must involve radical social change. The dissertation analyzes the differing explanations for environmental hazards given by previous schools of thought. Passing to the empirical material to be examined using these ideas, it describes the current pattern of landslides in Basilicata and discusses whether the reported landslide hazard has increased during the twentieth century. -

Unità Idrografica (08) BASENTO, CAVONE E MINORI
UNITA' IDROGRAFICA BASENTO, CAVONE E MINORI DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO MERIDIONALE PIANO DI GESTIONE I CARATTERIZZAZIONE I.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMMINISTRATIVO UNITA' IDROGRAFICA UNITA' COSTIERE ASSOCIATE COSTA IONICA LUCANA BASENTO, CAVONE E MINORI TARANTO REGIONI PROVINCE COMUNI MATERA BASILICATA 29 POTENZA CONSORZI DI MIGLIORAMENTO ATO CONSORZI DI BONIFICA COMUNITA' MONTANE FONDIARIO ATO UNICO BASILICATA BRADANO METAPONTO ---- ALTO BASENTO CAMASTRA ALTO SAURO COLLINA MATERANA MEDIO BASENTO MELANDRO Unità idrografica UI 08 BASENTO, CAVONE E MINORI_2.xls 2 DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO MERIDIONALE PIANO DI GESTIONE I CARATTERIZZAZIONE I.2 SOCIO-ECONOMICO POPOLAZIONE RESIDENTE 178.909 NUMERO ADDETTI ALL'INDUSTRIA E AI SERVIZI 46.139 Allevamenti avicoli Bovini Bufalini Caprini Conigli Equini Ovini Struzzi Suini ALLEVAMENTI Numero Capi Numero Capi Numero Capi Numero Capi Numero Capi Numero Capi Numero Capi Numero Capi Numero Capi 130.774 31.237 449 48.231 21.801 2.976 138.995 100 21.118 Unità idrografica UI 08 BASENTO, CAVONE E MINORI_2.xls 3 DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO MERIDIONALE PIANO DI GESTIONE I CARATTERIZZAZIONE I.3 INQUADRAMENTO FISIOGRAFICO SUPERFICIE PERIMETRO Lunghezza asta principale Densità di drenaggio QUOTA MEDIA PENDENZA Afflussi medi annui BACINI IDROGRAFICI PRINCIPALI km2 km km m s.l.m gradi mm BASENTO 1511,0 309,2 166,2 0,54 620 11 644 CAVONE 657,8 165,0 46,5 0,57 322 10 637 Totale unità idrografica 2292,8 316,6 0,54 501 11 636 tipologia (lago L, invaso LAGHI E INVASI ARTIFICIALI superficie -

Esperienze Di Partecipazione Del Cittadino Nella Lotta Contro La Desertificazione Il Caso Della Comunita’ Montana Collina Materana
per uno sviluppo locale sostenibile PROGETTO EUROPEO DESERT NET ESPERIENZE DI PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO NELLA LOTTA CONTRO LA DESERTIFICAZIONE IL CASO DELLA COMUNITA’ MONTANA COLLINA MATERANA MASSIMO IANNETTA ENEA , Unità Tecnico Scientifica BIOTEC Biotecnologie, Protezione della Salute e degli Ecosistemi Gruppo “Lotta alla Desertificazione” GAETANO BORRELLI, ORIETTA CASALI ENEA, Progetto Speciale Clima Globale Centro Ricerche Casaccia, Roma MASSIMO BASTIANI, FRANCESCO MAIORANO, VIRNA VENERUCCI ECOAZIONI, Gubbio (Perugia) Con la collaborazione di: Sara Bellusci Itala Portantieri Università della Basilicata, Potenza Francesca Martella Università “La Sapienza”, Roma OTTOBRE 2004 ESPERIENZE DI PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO NELLA LOTTA CONTRO LA DESERTIFICAZIONE IL CASO DELLA COMUNITA’ MONTANA DELLA COLLINA MATERANA M. BASTIANI, G. BORRELLI, O. CASALI, F. MAIORANO, M. IANNETTA, V. VENERUCCI Sommario Il presente rapporto contiene i risultati dell’EASW (European Awareness Scenario Workshop) sul tema della lotta contro la siccità e la desertificazione riguardante la Comunità Montana della Collina Materana, tenutosi a Stigliano il 17 luglio 2004. Le attività descritte sono state svolte nell’ambito del Progetto Europeo DesertNet al quale l’ENEA partecipa all’interno di una rete che coinvolge le principali istituzioni italiane esperte nel settore della lotta alla siccità e alla desertificazione. Il territorio della Comunità Montana della Collina Materana è stato scelto insieme ai responsabili della Regione Basilicata e dell’Università della Basilicata – Dipartimento di Economia Agraria e Gestione del Territorio – in quanto risulta essere sufficientemente rappresentativo per alcuni aspetti relativi al rischio di desertificazione della Regione Basilicata. Il Rapporto si compone di due parti. Nella prima parte, definita “Analisi del contesto”, viene analizzato il territorio della Comunità Montana dal punto di vista storico, socio-economico e ambientale. -

Environmental Aspects of the Reuse of Treated Wastewater: Impact on Water Quality in River Systems
Workshop Wastewater REUSE From the research to the technological transfer within the Mediterranean Potenza, April 29-30 2013 Environmental aspects of the reuse of treated wastewater: impact on water quality in river systems Donatella Caniani, Salvatore Masi, Ignazio M. Mancini, Carmen Lavinia Aridity affects large areas of the globe, i.e. 41% of the planet's land surface. Currently, dry regions are home to about 2.1 billion people. Recent studies show that by 2050, 2.3 billion more people than today are projected to live in river basins experiencing severe water stress (European Innovation Partnership Water, Strategic Implementation Plan). World map of aridity zones © CRU / UEA, UNEP / DEWA • Moreover, the Mediterranean Region, which comprises a transition between dry-sub-humid regions of northern croplands to hyper-arid southern desert (Saharan-Arabian deserts), is recognised among those most affected by drought that can speed up land degradation. Donatella Caniani, Environmental aspects of the reuse of treated wastewater: impact on water quality in river systems, Potenza 29-30 April 2013 • The consequences are rapid reduction of usable arable lands, quick decrease of the land productivity, widespread ecosystem degradation and, in turn, higher risk of desertification. • Desertification is a common threat to the Mediterranean basin. It is estimated that at least 11% of the EU population and 17% of its territory have been affected by water scarcity to date. • Moreover, as reflected by the Blueprint to safeguard Europe's water resources, almost half of Europe’s freshwaters are at risk of not achieving good ecological status, the main objective of the EU Water Framework Directive by 2015, with adverse effects on biodiversity and public health. -

REGIONE BASILICATA Comune Di ACCETTURA
REGIONE BASILICATA Comune di ACCETTURA (Provincia di MATERA) PIANO DI ASSESTAMENTO DELLA PROPRIETA’ SILVO-PASTORALE DEL COMUNE DI ACCETTURA (MT) (DECENNIO 2015-2024) STUDIO DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE Dicembre 2016 I TECNICI Dr. Agr. Domenico Montesano Ing. Gianluca Rospi SOMMARIO Premessa ........................................................................................................................................... 3 1 - DESCRIZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE ....................................... 5 1.1 – DIMENSIONI E AMBITO DI RIFERIMENTO.................................................................... 5 1.1.1 – Inquadramento territoriale e viabilità ................................................................................... 5 1.1.2 – Caratteristiche vegetazionali dei soprassuoli forestali ......................................................... 5 1.2 DIMENSIONI E/O TIPOLOGIE DI AZIONI........................................................................ 16 1.3 COMPLEMENTARIETA’ CON ALTRI PROGETTI E/O PIANI................................... 17 1.4 UTILIZZO DI RISORSE NATURALI.................................................................................... 21 1.5 PRODUZIONE DI RIFIUTI .................................................................................................... 22 1.6 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI.................................................................. 23 1.7 INCIDENTI DOVUTI A SOSTANZE E A TECNOLOGIE UTILIZZATE .......................... 24 2. VALUTAZIONE -

Torrente Salandrella - Garaguso (Mt) ______
Relazione Geologica e Analisi Idraulica Intervento di ripristino officiosità idraulica e pulizia alveo: TORRENTE SALANDRELLA - GARAGUSO (MT) ________________________________________________________________________________________ 1 Relazione Geologica e Analisi Idraulica Intervento di ripristino officiosità idraulica e pulizia alveo: TORRENTE SALANDRELLA - GARAGUSO (MT) ________________________________________________________________________________________ RELAZIONE GEOLOGICA E ANALISI IDRAULICA INDICE 1 – INTRODUZIONE pag.2 2 – COROGRAFIA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO pag.3 3 – VINCOLI E RISCHIO IDROGEOLOGICO pag.5 4 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELL’AREA pag.6 5 - LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI E IDROGEOLOGICI pag.8 6 - CRITICITA’ ED INTERVENTI DI RIPRISTINO pag.10 7 - FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO pag.12 8 – ANALISI IDRAULICA pag.13 9 – CONCLUSIONI pag.53 2 Relazione Geologica e Analisi Idraulica Intervento di ripristino officiosità idraulica e pulizia alveo: TORRENTE SALANDRELLA - GARAGUSO (MT) ________________________________________________________________________________________ 1 - INTRODUZIONE Il presente progetto pilota mira alla sistemazione e difesa idraulica del corso d’acqua del Torrente Salandrella in agro di Garaguso (MT) mediante “interventi di compensazione”. Tale sistema consiste nella realizzazione di interventi di ripristino e mantenimento dell'officiosità dei corsi d'acqua del demanio idrico regionale conseguenti a calamità naturali o diretti a prevenire situazioni di pericolo, tramite l’affidamento dei lavori a ditte specializzate,