Fra Tardogotico E Rinascimento: Messina Tra Sicilia E Il Continente
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Adriatic Odyssey
confluence of historic cultures. Under the billowing sails of this luxurious classical archaeologist who is a curator of Greek and Roman art at The Metropolitan Museum of Art. Starting in the lustrous canals of Venice, journey to Ravenna, former capital of the Western Roman Empire, to admire the 5th- and 6th-century mosaics of its early Christian churches and the elegant Mausoleum of Galla Placidia. Across the Adriatic in the former Roman province of Dalmatia, call at Split, Croatia, to explore the ruined 4th-century palace of the emperor Diocletian. Sail to the stunning walled city of Dubrovnik, where a highlight will be an exclusive concert in a 16th-century palace. Spartan town of Taranto, home to the exceptional National Archaeological Museum. Nearby, in the UNESCO World Heritage Site of Alberobello, discover hundreds of dome-shaped limestone dwellings called Spend a delightful day at sea and call in Reggio Calabria, where you will behold the 5th-century-B.C. , heroic nude statues of Greek warriors found in the sea nearly 50 years ago. After cruising the Strait of Messina, conclude in Palermo, Sicily, where you can stroll amid its UNESCO-listed Arab-Norman architecture on an optional postlude. On previous Adriatic tours aboard , cabins filled beautiful, richly historic coastlines. At the time of publication, the world Scott Gerloff for real-time information on how we’re working to keep you safe and healthy. You’re invited to savor the pleasures of Sicily by extending your exciting Adriatic Odyssey you can also join the following voyage, “ ” from September 24 to October 2, 2021, and receive $2,500 Venice to Palermo Aboard Sea Cloud II per person off the combined fare for the two trips. -

Antonello Da Messina's Dead Christ Supported by Angels in the Prado
1 David Freedberg The Necessity of Emotion: Antonello da Messina’s Dead Christ supported by Angels in the Prado* To look at Antonello da Messina’s painting of the Virgin in Palermo (fig. 1) is to ask three questions (at least): Is this the Virgin Annunciate, the Immaculate Mother of God about to receive the message that she will bear the Son of God? Or is it a portrait, perhaps even of someone we know or might know? Does it matter? No. What matters is that we respond to her as if she were human, not divine or transcendental—someone we might know, even in the best of our dreams. What matters is that she almost instantly engages our attention, that her hand seems to stop us in our passage, that we are drawn to her beautiful and mysterious face, that we recognize her as someone whose feelings we feel we might understand, someone whose emotional state is accessible to us. Immediately, upon first sight of her, we are involved in her; swiftly we notice the shadow across her left forehead and eye, and across the right half of her face, the slight turn of the mouth, sensual yet quizzical at the same time.1 What does all this portend? She has been reading; her hand is shown in the very act of being raised, as if she were asking for a pause, reflecting, no doubt on what she has just seen. There is no question about the degree of art invested in this holy image; but even before we think about the art in the picture, what matters is that we are involved in it, by * Originally given as a lecture sponsored by the Fondación Amigos Museo del Prado at the Museo del Prado on January 10, 2017, and published as “Necesidad de la emoción: El Cristo muerto sostenido por un ángel de Antonello de Messina,” in Los tesoros ocultos del Museo del Prado, Madrid: Fundación Amigos del Museo del Prado; Crítica/Círculo de Lectores, 2017, 123-150. -

YOU CAN DO Welcome to the Vibrant Palazzo Madama Overlooking Heart of the City That Has in Turin Piazza Castello
TURIN CITY GUIDE ® JULY 2021 WWW.WHEREITALIA.COM/TURIN ALL YOU CAN DO Welcome to the vibrant Palazzo Madama overlooking heart of the city that has IN Turin Piazza Castello. marked Italian history SIGHTSEEING | MUSEUMS | SHOPPING | DINING | ENTERTAINMENT | MAPS DISCOVER DISCOVER MORE Turin July 2021 Dear friends and readers, the tourism sector is Where tips in great difficulties all over the world. We must therefore thank 26 SHOPPING you who are reading us At Tonatto you can find now because you are In love home fragrances and nonetheless the hope of recovery as the world perfumes, or create BRENTATORE your scent. CORSO VERCELLI slowly overcomes the CORSO ALESSANDRIA pandemic.TANGENZIALE We ItaliansNORD TORINO VI A PAG ANE LLI Parrocchia Santa Gianna have experienced all CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 32 DINING CORSO GIULIO CESARE V I A L A N Z O S T R A D A D I D R U E N D O manner of crises and we ‘Le Vitel Étonné’ S T R A D A D I Dwith R U E N D O have always overcome STRADA DI DRUENDO VIA VERONESE restaurant serves 500 m them by trying not VIA V I A R E I S S R O M O L I BERGERA VENAR Piedmontese dishes, V IA A NDREA SANSOV IA to lose that smile of V I A R E I S S R O M O L I IN O VIA TRAVES CORSO GAETANO SCIREA Juventus Museum VIA VERONESE re-imagined to suit REBAUDENGO ELLA welcome that we once C V ST IA RADA DE Allianz Stadium GIOV LLA CONTI VI NESSA VIA REISS ROMOLI A AL contemporary tastes. -

Percorsi Etruschi "In Verità È Impressionante Constatare Che Per Due Volte, Nel VII Secolo A
2 Prefazione "L’uomo che non è mai stato in Italia, è sempre cosciente di un’inferiorità." Samuel Johnson Perché possiamo parlare dell’Italia come Opera Unica? Certo è che in essa sono concentrati la maggior parte dei beni artistici esistenti sul pianeta Terra, questo senza tener conto delle enormi ricchezze che ci rappresentano in alcuni tra i musei più importanti del mondo come il Louvre a Parigi, l’Heritage a San Pietroburgo o la National Gallery a Londra, visto e considerato che, insieme all’Egitto e alla Grecia, siamo tra i paesi più depauperati da un punto di vista patrimoniale, oltre che, da sempre, l’Arte Italiana fa scuola a studenti e artisti provenienti da ogni dove, talvolta diventati celeberrimi come Balthus, Picas- so e Turner, e che hanno affrontato i viaggi più avventurosi per studiare i no- stri capolavori i quali hanno influenzato visibilmente le loro opere. La famosa "Sindrome di Stendhal" prende nome proprio dalla reazione emo- tiva ansiogena che colse il famoso scrittore Francese e che egli racconta nel suo libro "Roma, Napoli e Firenze" descrivendola come una sintomatologia paralizzante dovuta all’improvvisa bellezza di un monumento e che lo colse uscendo dalla chiesa di Santa Croce, nel capoluogo toscano. Nel solo territorio Italiano contiamo cinquantacinque siti UNESCO a cui va aggiunto il Vaticano e senza tener conto che luoghi come Ercolano e Pompei sono considerati un unico sito. Trattasi di un numero pari a quello che può vantare la Cina, ma l’estensione dell’Italia, come si sa, è ben più ridotta. In sostanza, ovunque ci si trovi, nel nostro bel paese, si rischia di essere colpiti dalla stessa Sindrome che colse Stendhal. -

Debora Magno
ARCHIVIO STORICO MESSINESE Periodico fondato nel Millenovecento SOCIETÀ MESSINESE DI STORIA PATRIA ARCHIVIO STORICO MESSINESE - 83 - MESSINA 2002 BENEDETTO ROCCO IL GIUDEO-ARABO IN SICILIA NEI SECOLI XI-XV* 1. Che gli Ebrei dimoranti in Sicilia nel periodo chiamato “della dominazione musulmana” parlassero in arabo, è cosa risaputa: ne fanno fede – se ce ne fosse bisogno – anche le lettere ritrovate, e in parte pubblicate e tradotte, nella Geni- zah del Cairo (lingua araba in caratteri ebraici). Che la con- tinuassero a parlare nel periodo normanno (sec. XI-XII) si poteva arguire dal fatto che moltissimi musulmani erano rimasti nell’Isola sotto i due Ruggeri di Altavilla e i due Guglielmi, loro successori nel regno. La documentazione coeva dice senza dubbio che ai musulmani era concesso redigere i loro atti in arabo, come ai greco-bizantini di redi- gerli in greco, e ai siculo-normanni in latino. Per il giudeo- arabo rimangono a testimoniarlo due documenti redatti in tale lingua, l'uno a Palermo, l'altro a Siracusa, rispettiva- mente del 1149 e del 1187; l’uno in lapide quadrilingue (lati- no, greco, arabo in caratteri arabi, arabo in caratteri ebraici)1 l'altro monolingue su pergamena2. La tolleranza nell'espres- * Su presentazione del socio prof. Federico Martino, l’Archivio Storico Messinese pubblica questo inedito contributo dell’eminente semitista mons. Benedetto Rocco, la cui redazione è precedente al 2001. 1 Cfr. M. AMARI, Le epigrafi arabiche di Sicilia, trascritte, tradotte e illu- strate a cura di Francesco Gabrieli, Palermo 1971, N. XXVII, pp. 201-212. 2 Cfr. J. WANSBROUGH, A Judaeo-Arabic Document from Sicily, in “Bulletin 6 BENEDETTO ROCCO sione linguistica era accompagnata alla tolleranza nell’e- sperienza religiosa. -

Enrico Mauceri (1869-1966) Storico Dell’Arte Tra Connoisseurship E Conservazione
ENRICO MAUCERI (1869-1966) STORICO DELL’ARTE TRA CONNOISSEURSHIP E CONSERVAZIONE Atti del Convegno Internazionale di Studi a cura di Simonetta La Barbera FLACCOVIO EDITORE Stampato con il contributo MIUR ex 60% della prof. Simonetta La Barbera e con il contributo dell’Uni- versità degli Studi di Palermo. Enrico Mauceri (1869-1966). Storico dell’arte tra connoisseurship e conservazione Convegno Internazionale di Studi Palermo, 27-29 settembre 2007 Atti a cura di Simonetta La Barbera FLACCOVIO EDITORE Comitato Scientifico Antonino Buttitta, Maurizio Calvesi, Rosanna Cioffi, Maria Concetta Di Natale, Salvatore Fodale, Gaetano Gullo, Filippo Guttuso, Simonetta La Barbera, Giovanni Ruffino, Gianni Carlo Sciolla, Renato Tomasino. Coordinamento Scientifico Simonetta La Barbera Progetto grafico ed editing Vincenzo Brai Elaborazione delle immagini Nicoletta Di Bella Coordinamento organizzativo Marcella Russo Segreteria organizzativa Roberta Cinà Contatti con i convegnisti Nicoletta Di Bella, Roberta Santoro, Valentina Sarri Facoltà di Lettere, Dipartimento di Studi Storici e Artistici. Viale Delle Scienze. Edificio 12. 90128 Palermo Tel. 0916560265, 0916560333; Fax 0916560310; e-mail: [email protected] Enrico Mauceri (1869-1966) : storico dell’arte tra connoisseurship e conservazione : Convegno internazionale di studi, Palermo 27-29 settembre 2007 / atti a cura di Simonetta La Barbera. – Palermo : Flaccovio, 2009. ISBN 978-88-7804-466-1 1. Mauceri, Enrico – Congressi – Palermo – 2007. I. La Barbera, Simonetta. 700.92 CDD-21 SBN Pal0221869 CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” Proprietà artistica e letteraria riservata all’Editore a norma della Legge 22 aprile 1941, n. 633. È vie- tata qualsiasi riproduzione totale o parziale anche a mezzo di fotoriproduzione, Legge 22 maggio 1993, n. -

Current Brochure
ITALIAN The Art of Intelligent Travel Organising ITALIAN Borgo Santo Pietro, Tuscany THE ART OF INTELLIGENT TRAVEL ORGANISING AT EXPRESSIONS WE MARRY THE ART of intelligent travel organising and a passion, love and knowledge of Italy. The result is that we can bring you the true flavour of Italy and its captivating charm. Holidays and travel experiences to Italy are all about an appreciation of things Italian: the way of life, the culture, the art, the design, the landscape, the food and the wine. The Italian countryside exudes a classical harmony that is all but imprinted in the Western psyche and the charm and humour of the Italian people creates an endearing sense of well- being. As true Italian specialists we know how to share with you the passion that is Italy and its true flavour. Our clients have taken comfort in recent times in the fact that we have been in business for 28 years now and obviously have confidence in what we do. Over these years not only have we grown in experience but we have also developed excellent relationships with our suppliers. You gain from these relationships as they give us numerous benefits that we pass on to you such as early booking offers, free room upgrades etc. Sometimes we're not even aware of the small but important gestures they make to our clients behind the scenes but they do tell us quite readily that they enjoy having our clients as guests in their hotel. We are proud to be a specialist organiser of bespoke holidays and travel experiences to a destination as rich as Italy. -
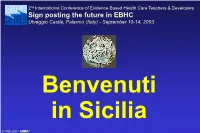
Presentazione Di Powerpoint
2nd International Conference of Evidence-Based Health Care Teachers & Developers Sign posting the future in EBHC Utveggio Castle, Palermo (Italy) - September 10-14, 2003 Benvenuti in Sicilia © 1996-2003 - GIMBE The power of Internet Evidence-Based Health Discussion List Subject: conference on teaching ebm/ websites/ sources of materials/ collaboration/ & CATs (or Pearls) From: Martin Dawes ([email protected]) Date: 22 May 2000 - 11:28 BST © 1996-2003 - GIMBE • Some time ago I invited comments about such a meeting. • I received 21 replies all of whom were positive - with some helpful suggestions. • How long was agreed at 2-3 days. • Some interesting ideas: - developing methods to evaluate teaching performance - developing criteria to evaluate effectiveness of workshops • I suggest March 2001 is about practical • I have the e-mails of the people who responded initially and I will approach them to make up an organising committee - anyone else who wants to help Please take one step forward Martin Dawes © 1996-2003 - GIMBE Where ? The question of where was determined by the origin of the sender © 1996-2003 - GIMBE At the time my proposal was… Possibly in Europe, ideally in Italy, it would be fantastic in Sicily! © 1996-2003 - GIMBE What is Evidence-based Medicine? • Paradigm • Reference • Dogma • Neologism • Philosophy • New orthodoxy •… © 1996-2003 - GIMBE Guyatt GH Evidence-based Medicine ACP Journal Club 1991;Mar-Apr:A-16 © 1996-2003 - GIMBE September 2001.Ten years later EBM was the occasion for the irresistible wish -

Filippo Juvarra, Dalle Rive Dello Stretto Al Mondo
L’editoriale del direttore 1 I sognatori non muoiono mai. Mauro Rostagno e Peppino Impastato nell’opera di Gaetano Porcasi Anno II - Numero 7 - Maggio 2021 di Roberto Sciarrone Cultura 5 Dr.Thom:The Story of the American Missionary in Ottoman Land by Murat Erdin DIRETTORE RESPONSABILE 8 Storie Messinesi: Filippo Juvarra, dalle rive dello Stretto al Mondo di Antonino Sarica ROBERTO SCIARRONE 11 Calabria: aspetti orfico-dionisiaci del sito di Castiglione di Paludi Dottore di Ricerca in Storia dell’Europa, Sapienza Università di Roma di Vincenzo Nadile 15 I Moti Risorgimentali in Abruzzo: associazioni rivoluzionarie e idee liberali di Marilisa Palazzone VICEDIRETTORE 18 Torbellinos en fase de colores DOMENICA PULEIO por Yuray Tolentino Hevia 20 Il 9 aprile di duecento anni fa nasceva il padre della poesia moderna: Baudelaire. L’innovazione Giornalista del linguaggio di Pierfranco Bruni 23 Gli anni Sessanta e l’arte povera, un nuovo movimento d’avanguardia artistica EDITORE di Bruno Di Pietro REGINA RESTA 26 Saffo, la poetessa per la quale nulla è più bello di ciò che si ama Presidente Verbumlandiart di Regina Resta 29 Un Viaggio nella Germania dei Monaci Irlandesi di Enzo Farinella VICEDIRETTORE EDITORIALE 31 Una voce che illumina il buio di Claudia Piccinno FIORELLA FRANCHINI Rubriche Giornalista 33 Bolle spaziali Puoi volar, puoi volar! di Martina Cardillo COLLABORATORI 38 From London to Rome ANNELLA PRISCO Music to improve quality of life di Barbara Panetta Scrittrice 41 Doppio clic, la rubrica! ANTONIETTA VAGLIO Comrad: ascolta l’EP -

Elenco Definitivo Delle Associazioni Sportive Dilettantistiche 2014 CODICE DENOMINAZIONE FISCALE INDIRIZZO COMUNE CAP PR ' U.S
Elenco definitivo delle Associazioni sportive dilettantistiche 2014 CODICE DENOMINAZIONE FISCALE INDIRIZZO COMUNE CAP PR ' U.S. CASTELLO ' ASSOCIAZIONE SPORTIVA 1 DILETTANTISTICA 02471790242 VIA POZZETTI 3 ARZIGNANO 36071 VI 2 " A.S.D. IL PICCOLO DRAGO " 93079790502 VIA CARLO PORTA 4 PISA 56123 PI " ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI DELLA 3 SCACCHIERA 93028870819 VIA LUCCA 19 ERICE 91016 TP " CIRCOLO TENNIS GORIZIA - ALDO ZACCARELLI - 4 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILET TANTISTICA " 80003400316 VIALE XX SETTEMBRE 3 GORIZIA 34170 GO " FELICEMENTE " ASSOCIAZIONE SPORTIVA 5 DILETTANTISTICA 90029570018 VIA CORDOVA 2 PAVAROLO 10020 TO " GIOCOSPORT " ASSOCIAZIONE SPORTIVA VIA PRIVATA BATTISTA DE 6 DILETTANTISTICA 97447840154 ROLANDI 7 MILANO 20156 MI VIA SALITA S BIAGIO C/O CASA 7 " POLISPORTIVA OTTATI " 91041400655 COMUNA OTTATI 84020 SA 8 "4J S.S.D. S.R.L." 01450670094 VIA VALLE 113 BORGIO VEREZZI 17022 SV 9 "A.S.D. "REAL SAN LUCIDO 96025030782 VIA F GILUIANI SN SAN LUCIDO 87038 CS 10 "A.S.D. BAIANO RUNNERS" 92072170647 VIA NICOLA LITTO BAIANO 83022 AV 11 "A.S.D. FITNESS AL FEMMINILE" 93412030723 VIA LUIGI RICCHIONI 32-34-36 BARI 70124 BA 12 "A.S.D. SPORT SAVONA ARTI MARZIALI" 92089840091 VIA BOVE 22/7 SAVONA 17100 SV 13 "A.S.D.CALCIO GIOVANILE S.PIETRO" 92024520790 VIA GIOVANI NICOTERA 103 SAN PIETRO A MAIDA 88025 CZ "ANTARTICA ASSOCIAZIONE ITALIANA SLEDDOG 14 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" 93074730669 S S 615 SNC L'AQUILA 67100 AQ "ASD CANTERA NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA 15 DILETTANTISTICA" 95153680632 VIA DUOMO 255 NAPOLI 80138 -

Elenco Permanente Degli Enti Iscritti 2020 Associazioni Sportive Dilettantistiche
Elenco permanente degli enti iscritti 2020 Associazioni Sportive Dilettantistiche Prog Denominazione Codice fiscale Indirizzo Comune Cap PR 1 A.S.D. VISPA VOLLEY 00000340281 VIA XI FEBBRAIO SAONARA 35020 PD 2 VOLLEY FRATTE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 00023810286 PIAZZA SAN GIACOMO N. 18 SANTA GIUSTINA IN COLLE 35010 PD 3 ASSOCIAZIONE CRISTIANA DEI GIOVANI YMCA 00117440800 VIA MARINA 7 SIDERNO 89048 RC 4 UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 00128330313 VIA GIOVANNI RISMONDO 2 GORIZIA 34170 GO 5 LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI BRINDISI 00138130745 VIA AMERIGO VESPUCCI N 2 BRINDISI 72100 BR 6 SCI CLUB GRESSONEY MONTE ROSA 00143120079 LOC VILLA MARGHERITA 1 GRESSONEY-SAINT-JEAN 11025 AO 7 A.S.D. VILLESSE CALCIO 00143120319 VIA TOMADINI N 4 VILLESSE 34070 GO 8 CIRCOLO NAUTICO DEL FINALE 00181500091 PORTICCIOLO CAPO SAN DONATO FINALE LIGURE 17024 SV 9 CRAL ENRICO MATTEI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 00201150398 VIA BAIONA 107 RAVENNA 48123 RA 10 ASDC ATLETICO NOVENTANA 00213800287 VIA NOVENTANA 136 NOVENTA PADOVANA 35027 PD 11 CIRCOLO TENNIS TERAMO ASD C. BERNARDINI 00220730675 VIA ROMUALDI N 1 TERAMO 64100 TE 12 SOCIETA' SPORTIVA SAN GIOVANNI 00227660321 VIA SAN CILINO 87 TRIESTE 34128 TS 13 YACHT CLUB IMPERIA ASSOC. SPORT. DILETT. 00230200081 VIA SCARINCIO 128 IMPERIA 18100 IM 14 CIRCOLO TENNIS IMPERIA ASD 00238530083 VIA SAN LAZZARO 70 IMPERIA 18100 IM 15 PALLACANESTRO LIMENA -ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA 00256840281 VIA VERDI 38 LIMENA 35010 PD 16 A.S.D. DOMIO 00258370329 MATTONAIA 610 SAN DORLIGO DELLA VALLE 34018 TS 17 U.S.ORBETELLO ASS.SP.DILETTANTISTICA 00269750535 VIA MARCONI 2 ORBETELLO 58015 GR 18 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA D.CAMPITELLO 00270240559 VIA ITALO FERRI 9 TERNI 05100 TR 19 PALLACANESTRO INTERCLUN MUGGIA 00273420323 P LE MENGUZZATO SN PAL AQUILINIA MUGGIA 34015 TS 20 C.R.A.L. -

N. 07-Venerdì 13 Febbraio 2015(PDF)
REPUBBLICA ITALIANA . Anno 69°S - Numero 7 . R . E GAZZETTA UFFICIALEU . N DELLA REGIONE SICILIANA G O I SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI’ PARTE PRIMA Palermo - Venerdì, 13 febbraio 2015 A Sped.Z in a.p., comma 20/c, art. 2, l. n. 662/96 - Filiale di Palermo L A DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940L Z - FAX 091/7074927 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) [email protected] E Z La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti Idegli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: http://gurs.regione.sicilia.it accessibile anche dal sitoD ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it L E SOMMARIO A L I LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI Assessorato delle attività produttive A C I DECRETO PRESIDENZIALE 16 gennaio 2015. DECRETO 7 gennaioR 2015. Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del AnnullamentoC E delle note relative all’autorizzazione al consiglio del comune di Mirto e nomina del commissario depositoI degli atti finali di liquidazione e al pagamento straordinario . pag. 3 del compenso finale, revoca dell’incarico conferito ai commissariF M liquidatori della cooperativa Prosperità e Flavoro, con sede in Marsala, e nomina del commissario liquidatore . pag. 11 DECRETO PRESIDENZIALE 16 gennaio 2015. M Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta delU comune di Nicosia e nomina del commissario straordina- ODECRETO 14 gennaio 2015. rio . pag. 3 O Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa C Bisaccia, con sede in Palermo, e nomina del commissario T liquidatore .