Studi Di Lessicografia Italiana
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tesi Chiara Bonaventura
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Padua@thesis UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente Tesi di laurea in Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione “Caffè, balsamo del cuore e dello spirito” Storia, cultura e scienza della bevanda più famosa al mondo Relatore: Prof. Danilo Gasparini Laureanda: Chiara Bonaventura Matricola n. 1000905 ANNO ACCADEMICO 2013-2014 La citazione del titolo è stata ripresa dalla citazione di Giuseppe Verdi (1813-1901). 2 Alla mia splendida Famiglia 3 INDICE Indice ………………………………………………………………………...………………4 Riassunto ……………………………………………………………………..……………6 Abstract ……………………………………………………………………..…………...…7 Introduzione ……………………………………………………………….……………...8 1. LE ORIGINI DEL CAFFÈ …………………..…………………………………10 2. DIFFUSIONE NEI NUOVI MONDI ……………………..…………….….…16 2.1 La scoperta portoghese …………………………….……………………16 2.2 Il regno olandese ……………………………………………………..……18 2.3 Supremazia francese ………………………………………………..……21 2.4 Gli intraprendenti portoghesi ………………………………..…..………25 2.5 Suolo, clima, condizione operaia ……………………………..……….26 2.6 Il prezzo ecologico ………………………………………….……...………27 2.7 Verso la libertà ……………………………………………..…………….…30 2.8 Il prezzo umano ………………………………………………………….…33 2.9 Forme alternative di mercato ……………………………..……….……33 2.10 Una singolare penitenza – Colombia …………………..…..………35 2.11 Centro America ……………………………………………….……..……35 2.12 Sfruttamento degli Indios …………………………….………..……….36 3. I CAFFÈ……………………………………………………………………………39 3.1 Vino -

Handpresso: from an Innovative Idea to an Alliance Portfolio
For the exclusive use of P. Sun, 2017. INS798 Handpresso: From an Innovative Idea to an Alliance Portfolio CONDENSED VERSION 09/2014-5903 This case was written by Anne-Marie Carrick, Research Associate, Henrich Greve, Professor of Entrepreneurship, and Manuel Sosa, Professor of Technology and Operations Management, all at INSEAD. It is a condensed version of the Handpresso case series #5841. It is intended to be used as a basis for class discussion rather than to illustrate either effective or ineffective handling of an administrative situation. The authors gratefully acknowledge the help of Nielsen Innovation in developing the case study. The case is dedicated to Henrik Nielsen, in memory. Additional material about INSEAD case studies (e.g., videos, spreadsheets, links) can be accessed at cases.insead.edu. Copyright © 2014 INSEAD COPIES MAY NOT BE MADE WITHOUT PERMISSION. NO PART OF THIS PUBLICATION MAY BE COPIED, STORED, TRANSMITTED, REPRODUCED OR DISTRIBUTED IN ANY FORM OR MEDIUM WHATSOEVER WITHOUT THE PERMISSION OF THE COPYRIGHT OWNER. This document is authorized for use only by Pang Sun in Competing in Technology Industries taught by H. Dennis Park, Drexel University from January 2017 to June 2017. For the exclusive use of P. Sun, 2017. Handpresso had gone from strength to strength since its creation in November 2006. Its pioneering handheld espresso machine had been successfully brought to market, with steady sales year on year. The auto espresso machine that had later been developed had generated much interest, leading to a partnership with a major Italian coffee roaster. This in turn had resulted in agreements with two large auto manufacturers. -

Country-Of-Origin Effect on Coffee Purchase by Italian Consumers
UNIVERSITY OF LJUBLJANA FACULTY OF ECONOMICS MASTER’S THESIS COUNTRY-OF-ORIGIN EFFECT ON COFFEE PURCHASE BY ITALIAN CONSUMERS Ljubljana, March 2016 COK ALENKA AUTHORSHIP STATEMENT The undersigned Alenka COK, a student at the University of Ljubljana, Faculty of Economics, (hereafter: FELU), declare that I am the author of the master’s thesis entitled CONSUMER BEHAVIOUR IN THE ITALIAN COFFEE MARKET: COO EFFECT ON CONSUMER PURCHASE INTENTIONS, written under supervision of full professor Tanja Dmitrović, PhD. In accordance with the Copyright and Related Rights Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, Nr. 21/1995 with changes and amendments) I allow the text of my master’s thesis to be published on the FELU website. I further declare that: the text of my master’s thesis to be based on the results of my own research; the text of my master’s thesis to be language-edited and technically in adherence with the FELU’s Technical Guidelines for Written Works which means that I o cited and / or quoted works and opinions of other authors in my master’s thesis in accordance with the FELU’s Technical Guidelines for Written Works and o obtained (and referred to in my master’s thesis) all the necessary permits to use the works of other authors which are entirely (in written or graphical form) used in my text; to be aware of the fact that plagiarism (in written or graphical form) is a criminal offence and can be prosecuted in accordance with the Criminal Code (Official Gazette of the Republic of Slovenia, Nr. -

Octubre 2.012
UNIVERSIDAD DE OVIEDO PROGRAMA DE DOCTORADO REINGENIERÍA DE ELEMENTOS INDIVIDUALES DESECHABLES PARA EROGACIÓN DE INFUSIONES OCTUBRE 2.012 Autor: David PECHARROMÁN CLEMENTE Director: Dr. José Manuel Mesa Fernández Director: Dr. Valeriano Álvarez Cabal “Son los problemas sin resolver, no los resueltos, los que mantienen activa la mente” Erwin Guido Kolbenheyer (1.878-1.962) AGRADECIMIENTOS A los profesores, técnicos y especialistas que prestaron su ayuda en el proceso de creatividad. A todas las personas que colaboraron en las catas. A Jesús Laine por enseñarme como funciona el complejo mundo de las patentes y guiarme a través de él. A Vicente Rodríguez por encauzarme en momentos claves del proceso. A Valeriano Álvarez y José Manuel Mesa, por dirigir mi tesis A Henar por la compañía en muchas tardes de trabajo. A Francisco Ortega, por volver a confiar en mí. A mis compañeros del Área que siempre me apoyaron. Por último a mi madre, que fue la primera en animarme a hacer esta tesis y no dudó en apartar otras prioridades para que pudiera llevarla a cabo. GLOSARIO Acidez: Sabor básico que se nota en la parte posterior de la lengua. Se presenta comúnmente en los granos tostados que no estaban maduros. Año cafetero: Es el período de un año comprendido entre cosecha y cosecha, que varía según el país y la zona de cultivo. Arábica: Variedad de café que se caracteriza por tener bastante cuerpo y un aroma afrutado. Se cultivan principalmente en Centroamérica y África. Beneficio: Proceso de extracción de los granos de café de las cerezas. Blend: Mezcla de distintas variedades de café verde. -

Rassegna Stampa Aprile 2020
Rassegna Stampa Aprile 2020 DATA TESTATA DIFFUSIONE* BRAND PRODOTTO/TEMA apr-20 Cotto e Mangiato 12.722 Bialetti Padella Saltapasta Donatello apr-20 Mela Verde n.d. Bialetti Apricapsule 07-apr-20 Elle.it 268.602 Aeternum Crepiere 07-apr-20 Elle.it 268.602 Bialetti Mini Crepiera Ghisa 09-apr-20 Golfegusto.it n.d. Bialetti Storia Moka 11-apr-20 Elle 113.193 Bialetti GCDS 16-apr-20 Twnews.it n.d. Bialetti Opera 17-apr-20 Nssmag.com 23.935 Bialetti Moka Supreme 19-apr-20 Focus-online.it 2.594 Aeternum Petrasana 24-apr-20 Today.it 28.148 Bialetti Modelli Moka *Dati certificati Mensile Data 04-2020 S, Pagina 93 ~máñgiátol Foglio 1 LA PADELLA SUPER RESISTENTE La padella sottoposta della linea Donatello di Bialetti ha Il fondo ad alto spessore, adatto anche all'induzione, che garantisce la distribu$ione ottimale del calore per esaltare il gusto di ogni ingrediente. La vernice esterna è ideale per le alte temperature CALORE SENZA FILI e resiste in forno Fino a 230°C. Pratico e robusto . il bollitore cordless di Termozeta per Cotto e mangiato ha la caraffa in uetro termoresistente da 1,5 litri e l'illuminazione interna a led. blu che consente di controllare costan- temente il liuella dall'acqua. La potenza è di 1850-2200W www.terrnozeta.cominegozio/ FRULLATORE PROFESSIONALE Il nuouo Frullatore K400 di KitchenAid è dotato di un motore da 1,5 caualli SBATTE E IMPASTA e di una lama asimmetrica in acciaio inox, da Termozeto per Cotto Prodotta e mangiato, che frullo do 4 angoli diuersi per un risultato la macchina Sbatte e, impasta è utilissima L'IDEA FURBA ottimale con ogni ingrediente. -

Pruebas De Acceso a Enseñanzas Universitarias Oficiales De Grado
Pruebas de acceso a enseñanzas EJERCICIO universitarias oficiales de grado ITALIANO Castilla y León Nº Páginas: 2 OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA. OPCIÓN A L'arte del caffè In Italia non ci stanchiamo mai di ripeterlo: il caffè è un' arte. Da nord a sud, a qualsiasi ora del giorno, c'è sempre un buon motivo per prendere un caffè. È davvero sorprendente come alcune persone riescano a prenderne anche cinque o sei nell'arco di una giornata, ognuno per un motivo diverso. Bere un caffè è diventato infatti sinonimo di pausa e spesso invece di invitare un amico a fare una chiacchierata, si preferisce invitarlo a bere un caffè. Ed è divertente notare che, quando si va a prendere un caffè con un amico o con un collega, si può rimanere anche ore a parlare del più e del meno, anche se l'espresso si beve in uno o due sorsi. Ma si sa, il caffè è un piacere e la fretta è proibita. La preparazione del caffè, a prima vista così semplice, ha alle spalle in realtà una grande tradizione. Inizialmente lo si beveva solo al bar, finché negli anni '30 Alfonso Bialetti inventa la Moka, ormai simbolo di italianità, e il caffè diventa qualcosa di veramente quotidiano per tutti, qualcosa a cui difficilmente si può rinunciare. Ma perché consideriamo il caffè un'arte? Il fatto è che andare al bancone di un bar e chiedere un caffè può non essere sufficiente. Esistono, infatti, diversi tipi di caffè: ristretto, lungo, corto, macchiato (con l'aggiunta di un po’di latte), corretto (si aggiunge un liquore), oppure decaffeinato (senza caffeina). -
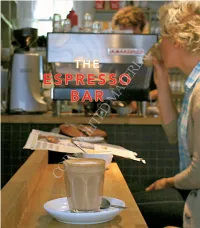
Espressos P R E S S O Bbara R
TTHEH E EESPRESSOS P R E S S O BBARA R COPYRIGHTED MATERIAL Espresso For the Love of Coffee and Crema HE FIRST TASTE OF ESPRESSO is like “enveloping the tongue T in velvet pajamas,” according to David Schomer of Seattle’s Espresso Vivace, or having “our tongues painted with many little droplets of oil,” in the words of Marino Petraco, a senior re- search scientist at illycaffè and a lecturer at the Università del Caffè in Trieste, Italy. That’s how two coffee authorities from two coffee capitals describe the silky coating left on the taste buds by the fi rst deposit of espresso crema. Espresso, Ital- ian for “express,” can be explained as “fast coffee.” The word is also associated with espressamenta, meaning “expressly” (as in a coffee “expressly for you”). What- ever the interpretation, espresso indicates the high-pressure extraction of coffee. And the thick surface layer of reddish- brown crema is the hallmark of a well- prepared cup. No espresso machine can extract desir- able aromas—caramel, chocolate, fl oral, fruity, smoky, earthy—not already pres- ent in the coffee. Not the fi rst espresso machine, a steam-driven cylindrical pro- totype patented in 1901 by Italian engi- neer Luigi Bezzera. Not the piston-driven 16 mechanism fi rst manufactured in the late theater with tasting tables, video confer- 1940s by Achille Gaggia, nor the pump- encing, and up to four interpreters sitting driven models developed since. But the behind glass booths, translating Petraco’s macchina is one of the four m’s—the oth- Italian poetry into various languages. -
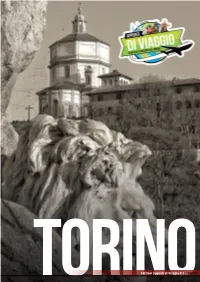
Guida PDF Torino
TORINOEdizioni Appunti di Viaggio # 4 . TORINO indice EDITORIALE INTRODUZIONE STORIA EVENTI CURIOSITA’ TRASPORTI MAPPA IN PRIMO PIANO LUOGHI D’INTERESSE PIAZZE MUSEI PARCHI QUARTIERI DINTORNI FOOD & DRINK DA NON I CLASSICI PERDERE THANKS TO CHI SIAMO STAFF PARTNERS SIMONA MAC INDICE Edizioni Appunti di Viaggio # 4 . TORINO 2 editoriale TORINO PIEMONTE ANTICHE IMMAGINI Non ci aspettavamo un risultato del genere! Dopo Roma, Londra e New York i download dei nostri #appunti hanno superato quota 100 e, nel nostro piccolo, riteniamo che sia un grande risultato per questo nuovo e grande progetto fatto unicamente di passione ed amicizia. Abbiamo cercato di capire le vostre esigenze, senza copiare altre guide ed altri lavori nel tentativo di creare qualcosa di semplice ma unico. Di diverso. Se ci siamo riusciti, sta a voi giu- dicarlo, ma grazie al lavoro di Max, Elisa, Anna Lisa, Chiara, Gaja e Simona credo che il risultato sia stato raggiunto. Ognuno, con le sue competenze e la sua esperienza, ha dedicato gran parte del suo tempo libero per la redazione delle prime uscite. Ma la sfida continua e riparte da Torino, antica capitale d’Italia e centro nevralgico di quello che fu il Regno Sabaudo. Ormai l’avrete capito: per ogni sessione di #appunti, inseriamo una fetta d’Italia. Sì. Perchè l’Italia, prima al mondo per patrimonio artistico, viene a volte mes- sa in secondo piano a discapito di Paesi esotici che, pur presenti nei sogni di ognuno di noi, nella reatà dei fatti nemmeno competono con il Bel Paese. Un piccolo inciso, infine, su quanto accaduto negli ultimi mesi: purtroppo, al momento dell’uscita riguar- dante i nostri #appunti su Londra, la città del Big Ben è stata colpita dall’ennesimo attacco terroristico. -

Experimental Investigation of Steam Pressure Coffee Extraction in a Stove-Top Coffee Maker L
Experimental Investigation of Steam Pressure Coffee Extraction in a Stove-top Coffee Maker L. Navarini, E. Nobile, F. Pinto, A. Scheri, F. Suggi-Liverani To cite this version: L. Navarini, E. Nobile, F. Pinto, A. Scheri, F. Suggi-Liverani. Experimental Investigation of Steam Pressure Coffee Extraction in a Stove-top Coffee Maker. Applied Thermal Engineering, Elsevier, 2010, 29 (5-6), pp.998. 10.1016/j.applthermaleng.2008.05.014. hal-00618977 HAL Id: hal-00618977 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00618977 Submitted on 5 Sep 2011 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Accepted Manuscript Experimental Investigation of Steam Pressure Coffee Extraction in a Stove-top Coffee Maker L. Navarini, E. Nobile, F. Pinto, A. Scheri, F. Suggi-Liverani PII: S1359-4311(08)00229-9 DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2008.05.014 Reference: ATE 2515 To appear in: Applied Thermal Engineering Received Date: 20 December 2007 Revised Date: 16 April 2008 Accepted Date: 13 May 2008 Please cite this article as: L. Navarini, E. Nobile, F. Pinto, A. Scheri, F. Suggi-Liverani, Experimental Investigation of Steam Pressure Coffee Extraction in a Stove-top Coffee Maker, Applied Thermal Engineering (2008), doi: 10.1016/j.applthermaleng.2008.05.014 This is a PDF file of an unedited manuscript that has been accepted for publication. -

April 2019 (364.9Kb)
STRATHMORE INSTITUTE DIPLOMA IN ENTREPRENEURSHIP END OF SEMESTER EXAMINATION DE 1103: INNOVATION AND TECHNOLOGY IN ENTREPRENEURSHIP DATE: 8th April 2019 Time: 2 Hours Instructions 1. This examination consists of THREE questions. 2. Answer Question ONE (COMPULSORY) and any other TWO questions. QUESTION ONE – COMPULSORY QUESTION (30 marks) Maboflo recently completed a course in entrepreneurship and has decided to join the family business, which has been in operation for the past 15 years, with the intention of applying his newly acquired knowledge to improve the business, reduce the time the parents spend working and over time expand it. The business consists of 3 bakeries, WaKASrice Bakeries, TumboFill Caterers & MarkJane Enterprises, they make and sell an assorted range of breads, cakes and pastries. Currently each location is operated as an independent entity with all activities done on location with the parents spending two days a week at each location mainly reconciling accounts and sorting out personnel and supplier issues. A major personnel issue is the need to regularly recruit new baking staff and also the high turnover of cashiers mainly due to loss of money. This always results in major disruptions of the business, most times, forcing one of the parents to take over until a replacement is found and trained. Initially the business did not sell any drinks but when a competitor opened next door and started selling sodas and juices together with their cakes, your parents decided to compete by offering the same and went one better by also selling tea & coffee which are currently served in ceramic mugs. With Waboflo’s decision to join the family business the parents have decided to let him run one of the locations on a full-time basis as they concentrate on the other two with the expectation that over time he will take over the running of all the 3 locations. -
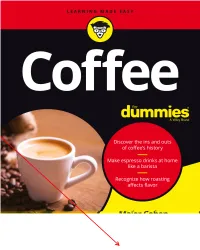
The Lowdown on Roasting Coffee
Coffee by Major Cohen Coffee For Dummies® Published by: John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030-5774, www.wiley.com Copyright © 2021 by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Published simultaneously in Canada No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, except as permitted under Sections 107 or 108 of the 1976 United States Copyright Act, without the prior written permission of the Publisher. Requests to the Publisher for permission should be addressed to the Permissions Department, John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030, (201) 748-6011, fax (201) 748-6008, or online at http://www.wiley.com/go/permissions. Trademarks: Wiley, For Dummies, the Dummies Man logo, Dummies.com, Making Everything Easier, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc., and may not be used without written permission. All other trademarks are the property of their respective owners. John Wiley & Sons, Inc., is not associated with any product or vendor mentioned in this book. LIMIT OF LIABILITY/DISCLAIMER OF WARRANTY: THE PUBLISHER AND THE AUTHOR MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES WITH RESPECT TO THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE CONTENTS OF THIS WORK AND SPECIFICALLY DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. NO WARRANTY MAY BE CREATED OR EXTENDED BY SALES OR PROMOTIONAL MATERIALS. THE ADVICE AND STRATEGIES CONTAINED HEREIN MAY NOT BE SUITABLE FOR EVERY SITUATION. THIS WORK IS SOLD WITH THE UNDERSTANDING THAT THE PUBLISHER IS NOT ENGAGED IN RENDERING LEGAL, ACCOUNTING, OR OTHER PROFESSIONAL SERVICES. -

Viveresebastiano LO MONACO
3 Alla buona tavola dell’oste Puntano molto sull’enoturismo le Cantine Nicosia di Trecastagni Danila Giaquinta a pag. II / L’astronave Cambiando Strada di Genovese Il pittore catanese si ispira alla magia delle stelle Agata Patrizia Saccone a pag. II / Week end: Valguarnera Per Santa Lucia Un disco - Pop - e un tour teatrale per i Fratelli La Strada: quella dei il borgo si accende col “Pagghiuolo” Arcangelo Santamaria a pag. III / Tra cibo e devozione Le varie tradizioni siciliane della cuccìa Rosalba busker non è più la strada maestra? Gianni Nicola Caracoglia alle pagg. II-III Cannavò a pag. III / Parole a tinta unita I love coffee Alessandra Dammone e Mariella Caruso alle pagg. IV-V / Cartellone a pag. VI € 0,26 Spedizione A.P. comma 20b Art. 2 legge 662/96 - Fil. CT 808 settimanale di società, cultura e tempo libero 10 dicembre 2015 vivere [email protected] Anno XX - n. SEBASTIANO LO MONACO di Michele Nania SMSicilians Un, due, Trump «La guerra e abbiamo avute e ne abbiamo eccome, di persone sbagliate al posto è una pazzia, Nsbagliato che sulla scena internazionale sono stati capaci solo di far «Il mio Ulisse fare una pessima figura al Paese e sul fronte interno non ne parliamo. Ora questo il messaggio però mister Donald Trump rischia di oscurare e far dimenticare tutti i suoi poco illustri predecessori. Non ritiene un’offesa il paragone con Hitler dell’eroe greco» (quindi per esclusione per lui è un complimento), non si vergogna di fare il verso ad un giornalista disabile e per vincere la guerra al terrorismo vor- L’attore siracusano rebbe il bavaglio a Internet e frontiere bloccate per i musulmani.