Report Per Apt 2016 190916
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
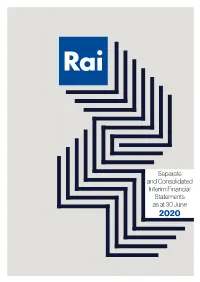
Separate and Consolidated Interim Financial Statements As at 30 June 2020
Separate and Consolidated Interim Financial Statements as at 30 June 2020 Separate and Consolidated Interim Financial Statements as at 30 June 2020 Contents 7 Introduction 17 Report on Operations 171 Interim Separate Financial Statements as at 30 June 2020 239 Interim Consolidated Financial Statements as at 30 June 2020 303 Corporate Directory 4 Contents Introduction 7 Corporate Officers 8 Organisational Structure 9 Introduction from the Chairman of the Board of Directors 11 Financial Highlights 12 Report on Operations 17 Mission 18 Market scenario 18 The Rai Group 24 Television 41 Radio 97 RaiPlay and Digital 107 Public broadcasting service function 116 TV production 119 Technological activities 120 Transmission and distribution activities 129 Sales activities 130 Other activities 135 Changes in the regulatory framework 143 Corporate governance 148 Corporate Governance Report - the Rai Control Governance Model and the Internal Control and Risk Management System (SCIGR) 150 Other information 155 Human Resources and Organisation 155 Safety & Security 159 Intercompany Relations 161 Significant events occurring after 30 June 2020 168 Outlook of operations 168 5 Interim Separate Financial Statements as at 30 June 2020 171 Analysis of the results and performance of operating results, financial position and cash flows for the first half of 2020 172 Financial Statements of Rai SpA 186 Notes to the Interim Separate Financial Statements as at 30 June 2020 191 Certification pursuant to article 154-bis of Italian Legislative Decree 58/98 235 Independent -

Reports and Financials As at 31 December 2015
Financials Rai 2015 Reports and financials 2015 December 31 at as Financials Rai 2015 Reports and financials as at 31 December 2015 2015. A year with Rai. with A year 2015. Reports and financials as at 31 December 2015 Table of Contents Introduction 5 Rai Separate Financial Statements as at 31 December 2015 13 Consolidated Financial Statements as at 31 December 2015 207 Corporate Directory 314 Rai Financial Consolidated Financial Introduction Statements Statements 5 Introduction Corporate Bodies 6 Organisational Structure 7 Letter to Shareholders from the Chairman of the Board of Directors 8 Rai Financial Consolidated Financial Introduction 6 Statements Statements Corporate Bodies Board of Directors until 4 August 2015 from 5 August 2015 Chairman Anna Maria Tarantola Monica Maggioni Directors Gherardo Colombo Rita Borioni Rodolfo de Laurentiis Arturo Diaconale Antonio Pilati Marco Fortis Marco Pinto Carlo Freccero Guglielmo Rositani Guelfo Guelfi Benedetta Tobagi Giancarlo Mazzuca Antonio Verro Paolo Messa Franco Siddi Secretary Nicola Claudio Board of Statutory Auditors Chairman Carlo Cesare Gatto Statutory Auditors Domenico Mastroianni Maria Giovanna Basile Alternate Statutory Pietro Floriddia Auditors Marina Protopapa General Manager until 5 August 2015 from 6 August 2015 Luigi Gubitosi Antonio Campo Dall’Orto Independent Auditor PricewaterhouseCoopers Rai Financial Consolidated Financial Introduction Statements Statements 7 Organisational Structure (chart) Board of Directors Chairman of the Board of Directors Internal Supervisory -

Bilancio Rai 2020
Relazione e bilanci al 31 dicembre 2020 Relazione e bilanci al 31 dicembre 2020 Indice 7 Introduzione 19 Relazione sulla gestione 201 Bilancio separato al 31 dicembre 2020 309 Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 413 Deliberazioni dell'Assemblea 417 Corporate directory 4 Indice Introduzione 7 Organi sociali 8 Struttura organizzativa 9 Lettera agli Azionisti del Presidente del Consiglio di Amministrazione 11 Principali dati finanziari 14 Relazione sulla gestione 19 La missione 20 Lo scenario di mercato 20 Il Gruppo Rai 27 La televisione 45 La radio 110 RaiPlay e Digital 122 Produzione televisiva 134 Attività tecnologiche 135 Attività trasmissiva e diffusiva 144 Attività commerciali 146 Altre attività 151 L’evoluzione del quadro normativo e regolamentare 164 Corporate governance 175 Relazione sul governo societario - Modello di Control Governance di Rai e Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR) 176 Altre informazioni 182 Risorse Umane e Organizzazione 182 Asset immobiliari 188 Safety & Security 189 Rapporti intersocietari 191 Informazioni supplementari 191 Fatti di rilievo occorsi successivamente al 31 dicembre 2020 198 Prevedibile evoluzione della gestione 199 5 Bilancio separato al 31 dicembre 2020 201 Analisi dei risultati e dell’andamento della gestione economica-patrimoniale e finanziaria dell’esercizio 2020 202 Prospetti contabili di Rai SpA 218 Note illustrative al Bilancio separato al 31 dicembre 2020 223 Attestazione ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs. 58/98 295 Relazione del Collegio Sindacale 296 Relazione della Società di Revisione 302 Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 309 Analisi dei risultati e dell’andamento della gestione economica-patrimoniale e finanziaria consolidata dell’esercizio 2020 310 Prospetti contabili del Gruppo Rai 325 Note illustrative al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 330 Attestazione ai sensi dell’art. -

RAI GROUP Reports and Financial Statements 2008 N Iaca Statements Financial and Reports GROUP RAI 2008
2008 Reports and financial statements RAI GROUP Reports and financial statements 2008 RAI GROUP Reports and financial statements at 31.12.2008 General contents 3 Corporate Bodies 5 Organizational Structure 7 Report on operations 13 Rai 23 Rai’s offering 31 TV Division 59 Radio Division 69 New Media & DTT Division 77 Commercial Division 85 Broadcasting Division 89 Parent Company’s financial and earnings position 105 Additional information 115 Recommendation to Shareholders 117 Rai SpA financial statements at 31 December 2008 185 Shareholders’ Meeting 187 Consolidated financial statements of the Rai Group at 31 December 2008 267 Financial statements of Subsidiaries 323 Corporate Directory 2 Corporate Bodies Corporate Bodies 3 Board of Directors (until 25 March 2009) (from 26 March 2009) Chairman Claudio Petruccioli Paolo Garimberti Directors Giovanna Bianchi Clerici Giovanna Bianchi Clerici Sandro Curzi (1) Rodolfo De Laurentiis Gennaro Malgieri (2) Alessio Gorla Angelo Maria Petroni Angelo Maria Petroni Nino Rizzo Nervo Nino Rizzo Nervo Carlo Rognoni Guglielmo Rositani Marco Staderini Giorgio Van Straten Giuliano Urbani Antonio Verro (until 31 December 2008) (from 1 January 2009) Secretary Franco Di Loreto Nicola Claudio Statutory Auditors Chairman Domenico Tudini Regular auditors Paolo Germani Gennaro Ferrara Alternate auditors Rosa Grimaccia Domenico Mastroianni (until 1 April 2009) (from 2 April 2009) General Manager Claudio Cappon Mauro Masi Independent auditors PricewaterhouseCoopers (3) (1) In office until 22 November 2008. (2) In -

Atti Parlamentari
Deputati – 193 – Senato del r !•! !!.'r!LATURA - DISEG>..rr n»>CUMENTI - DOC. Introduzione Bilancio Civilistico Bilancio Consolidato 29 L’attività della Rai La televisione 30 Canali generalisti 30 Canali semi-generalisti e canali tematici 33 Informazione 38 Cinema 40 Fiction 42 Teche 43 La radio 44 Canali 44 Canali di Pubblica Utilità 46 Attività commerciali 47 Pubblicità 47 Commerciale 48 Altre attività 49 Attività trasmissiva 49 Deputati – 194 – Senato del r !•! !!.'r!LATURA - DISEG>..rr n»>CUMENTI - DOC. 30 Introduzione Bilancio Civilistico Bilancio Consolidato Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione/ L’attività della Rai di ascolto di 9,7 milioni di spettatori e uno share Ascolto del 35,9%, e la ction Braccialetti Rossi, tratta intera dall’omonimo best seller spagnolo. giornata Rai 1 17,3% Importanti anche le conferme di programmi (canali generalisti) storici della Rai che ogni anno caratterizzano il palinsesto della rete. Tra questi, primo fra tutti, la 64° edizione del Festival di Sanremo, condotta da Fabio Fazio con la collaborazione di Luciana Rai 2 6,6% Littizzetto, edizione dedicata alla bellezza in tutte le sue declinazioni. La media delle cinque serate ha superato gli 8,7 milioni di spettatori pari al 39,3% di share. Rai 3 Il 2014, inoltre, è stato arricchito anche da altri 6,7% programmi evento. In ambito sportivo, impossibile non citare i Mondiali di Calcio in chiaro e in HD, con gli incontri e le rubriche di approfondimento, e la Ascolto Partita della Pace, prima partita interreligiosa per prima la pace che ha visto l’impegno di campioni di tutto il mondo e di tutte le religioni giocare insieme per serata Rai 1 benecenza. -

CURRICOLI)M VITAE VALERIO FIORESPINO Dati Anagrafici
CURRICOLI)M VITAE DI VALERIO FIORESPINO Dati anagrafici nato a :. il Residente a ', Recapiti telefonici Studi Maturità classica Liceo Giulio Cesare (1981) Laurea in Giurisprudenza (110/110) Università "La Sapienza" di Roma (1986) Lingue Inglese buono scritto e orale Esperienze Professionali 11/1986 Attività Segale presso lo Studio Delfìni (leasing e credito fondiario) 3/1988 Assunzione in RA1 presso la Direzione del Personale - Contenzioso del Lavoro. Quadro dal 1993, in qualità di responsabile delle cause promosse dai collaboratori esterni all'Azienda. 2/1994 Relazioni Sindacali. 1/1995 Responsabile delle Relazioni con ìi Sindacato Giornalisti (Usigrai), alla quale si aggiunge, dopo pochi mesi, la responsabilità della gestione de! personale giornalistico (assunzioni, promozioni, mobilità, politiche retributive). Dirigente dal 1997. 10/1998 Responsabile di Gestione e Sviluppo Risorse Chiave e Politiche del Personale, con competenza diretta nella selezione, sviluppo e gestione di dirigenti, quadri di livello elevato e giornalisti con qualifiche da caporedattore in su, nonché nel rilascio di linee guida e indirizzi per la gestione del restante personale, 1/2000 Direttore della Direzione Risorse Umane; si aggiungono a quelle sopra indicate le responsabilità di organizzazione, formazione, gestione diretta di tutte le risorse Corporate, ambiente, safety e securily. Gli dipendono funzionalmente tutte le funzioni personale delle Divisioni/Direzioni dell'Azienda, Membro del Comitato Direttivo della Scuola dì Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia. -

Braccialetti Rossi 2 Al
CINETVMANIA.TV (WEB) Data 16-02-2015 Pagina Foglio 1 / 3 Cinetvmania.it Tv News Oggi in Tv – Guida Tv | Dati Auditel – Ascolti Tv Programmi Tv Ascolti Tv Guida Tv Sport Soap Cinema Musica Cultura Vedere il Video Cinetvmania.it Blog Guarda il tuo Video su Cell, PC e Tablet. Tutti i tuoi Video Qui! Segui +1 Braccialetti Rossi 2: streaming prima puntata 15 febbraio + 1.355 – Video replica La replica della prima puntata di Braccialetti Rossi 2. Dopo l'ottimo successo della Trovaci su Facebook prima serie, i sei ragazzi in difficoltà, alle prese con la malattia, tornano a lanciare Cinetvmania.it un messaggio di speranza sulle reti Rai. Mi piace Mi piace Condividi 20 Postato il 15 febbraio 2015 da Sandro Spagnuolo. Ultima modifica 16 febbraio 2015 alle 09:24. Cinetvmania.it piace a 1.386 persone. Festival di Sanremo 2015 Le Ultime News Sul Festival Scopri Plug-in sociale di Facebook Tutto quello che non Sapevi! Tweet Segui UPDATE: Leo e Cris sono innamorati e la loro CineTVMania.it 32m storia d’amore continua, nonostante le cure che @CineTVMania ancora Leo deve fare. Dopo essere uscito dal Beautiful: trame puntate dal 16 al 21 febbraio coma, Rocco deve restare ancora un po’ in 2015 cinetvmania.it/?p=126811 pic.twitter.com/XRF2wbG9M3 ospedale. Tony ha iniziato di nuovo il lavoro in officina e sente molta nostalgia dei suoi amici “Braccialetti”. Vale affronterà con difficoltà la vita quotidiana, chiudendosi in se stesso e allontanando gli altri braccialetti rossi. Per chi avesse perso la visione, può vedere la puntata in streaming video (cliccando sull’immagine a fondo articolo) in replica sul sito web della Rai. -

Relazione Annuale 2016 Sull’Attività Svolta E Sui Programmi Di Lavoro
Relazione annuale 2016 sull’attività svolta e sui programmi di lavoro www.agcom.it www.agcom.it RELAZIONE ANNUALE 2016 sull’attività svolta e sui programmi di lavoro Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Presidente ANGELO MARCELLO CARDANI Componenti ANTONIO MARTUSCIELLO ANTONIO NICITA FRANCESCO POSTERARO ANTONIO PRETO Segretario generale RICCARDO CAPECCHI Vice segretari generali LAURA ARÌA ANTONIO PERRUCCI Capo di gabinetto del Presidente ANNALISA D’ORAZIO Indice Prefazione del Presidente . 7 CAPITOLO I CAPITOLO III L’operato dell’Autorità nel periodo 2015-2016 I risultati raggiunti, le strategie per il nelle principali aree di interesse . 9 prossimo anno e le attività programmatiche 119 1.1 Le attività regolamentari e di vigilanza nei 3.1 Le attività svolte in attuazione degli obiettivi mercati delle telecomunicazioni . 12 strategici pianificati . 122 1.2 I servizi “media”: analisi, regole e controlli . 18 3.2 I risultati del piano di monitoraggio . 134 1.3 Tutela e garanzia dei diritti nel sistema digitale . 22 3.3 Le priorità strategiche di intervento per il prossimo anno . 153 1.4 La regolamentazione e la vigilanza nel settore postale . 32 1.5 I rapporti con i consumatori e gli utenti . 35 1.6 La nuova generazione regolamentare: spettro radio per telecomunicazioni e servizi digitali 45 CAPITOLO IV 1.7 L’attività ispettiva ed il Registro degli operatori L’organizzazione dell’Autorità e le relazioni di comunicazione . 49 con le istituzioni . 167 CAPITOLO II 4.1 L’assetto organizzativo e la politica delle risorse umane . 169 L’assetto e le prospettive del settore delle comunicazioni in Italia . 53 4.2 Gli organismi strumentali e ausiliari . -

Stagione Televisiva - 2013/2014
1 2 Osservatorio Media del Moige Movimento Italiano Genitori coordinato da a cura di Elisabetta Scala Alessandra Caneva un anno di zapping guida critica ai programmi televisivi STAGIONE TELEVISIVA - 2013/2014 prefazione di Elisa Manna postfazione di Francesco Posteraro 3 4 indice Prefazione 7 Elisa Manna Introduzione 9 Maria Rita Munizzi, Elisabetta Scala Legenda dei simboli 11 Schede di analisi critica dei programmi 13 Postfazione 205 Francesco Posteraro Indice dei programmi 206 Glossario dei termini tecnici 213 un anno Note professionali degli autori 215 di zapping 5 6 prefazione La nostra è un’epoca in cui proliferano i riti collettivi: tra questi, uno dei più rivelatori riguarda il rapporto tra i media e i minori. Totalmente trascurato nella quotidianità da istituzioni e leader d’opinione, balza prepotentemen- te all’attenzione di tutti quando un doloroso fatto di cronaca fa sospetta- re una qualche infl uenza negativa della televisione o dei videogiochi sui comportamenti devianti di un ragazzo o una ragazza. Per qualche giorno non si parla d’altro: gli esperti vengono bersagliati di richieste d’interviste da giornali e trasmissioni televisive che scompongono il fatto mille volte per capire se i contenuti nocivi di cui i media traboccano possono aver infl uenzato o meno il comportamento deviante in questione (recentemen- te, le baby prostitute in cerca di guadagni facili per acquistare oggetti di consumo di lusso). Come sempre si formano subito due schieramenti: quelli che vedono nei media l’origine di ogni male, quelli che invece tendono a minimizzare e rimpallano comunque le responsabilità sui genitori. In pratica, non si riesce a fare un discorso serio. -

Ci Vuole RISPETTO Invito Alla Lettura
RADIOCORRIERE TV SETTIMANALE DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA numero 43 - anno 85 31 ottobre 2016 Amore Criminale Reg. Trib. n. 673 del 16 dicembre 1997 Asia Argento ci vuole RISPETTO Invito alla lettura 2 TV RADIOCORRIERE 3 Con tutta franchezza, i jeans strappati non li tollero. Capisco la moda, a volte cerco a fatica di comprenderla, ma simili pantaloni non riesco proprio a digerirli. E la cosa che maggiormente non sopporto è il costo: un jeans strappato, o meglio "lavorato" come dicono gli esperti del settore, costa ben più di uno normale. La scorsa settimana ho accompagnato mia figlia ad acquistare un paio di jeans e la commessa ci ha da strada Vita mostrato una serie di modelli: aderenti, elasticizzati, a cinque tasche e poi quello con gli strappi "ad hoc"… Ho chiesto che cosa fossero questi strappi "ad hoc" e ho avuto modo di constatare che il pantalone è semplicemente un pretesto per ospitare giganteschi buchi. Un capo ridotto a brandelli che sembrava uscito da un disastro aereo, nemmeno i punk avrebbero mai osato sceglierlo. La commessa ha spiegato a mia figlia che per indossare quel modello bisognava acquistare un paio di calze che mettessero in risalto quel tipo di lavorazione del tessuto, o meglio - mi è venuto da pensare - quel che restava di quel denim con cui originariamente era stato realizzato il jeans. Poteva un'adolescente non rimanerne affascinata? Inutile dire che la scelta si è direzionata proprio su quel modello. E, nonostante sia arrivato ad offrire due pantaloni veri al posto di uno a forma di gruviera, mia figlia è stata irremovibile. -

From Parenthood to Tutto Può Succedere
volume 9 issue 17/2020 FROM PARENTHOOD TO TUTTO PUÒ SUCCEDERE READY-MADE ELEMENTS AND CULTURAL TRANSLATION Stefania Antonioni Università di Urbino [email protected] Chiara Checcaglini Università di Udine [email protected] Abstract: In our article we propose an analysis of the Italian TV series Tutto Può Succedere (2015-2018), a remake of the American TV series Parenthood (2010-2015). The Italian remake precisely reproduces some Parenthood’s ready-made elements: the two series share the main plot, many storylines and characters’ personalities, dealing with the ups and downs of a large family, formed of four siblings, their parents and their children. We will focus on the differences and similarities of the two shows from several perspectives, such as formal and content divergences, and their cultural, social and production implications. On the one hand, the Italian remake loses the distinguishing style and the faster pace of the original series to adjust to Rai’s more basic aesthetics; on the other hand, Rai chooses to focus on specific plots and characters that match its own purposes. Indeed, we can assume that the youngest characters are the means by which Raiuno tries to connect with younger viewers, and the same function is assumed by the role played by music in the series and by the on-screen presence of young Italian musicians. Keywords: cultural translation, remake, adaptation, serial narratives, Parenthood, Tutto Può Succedere 1 Introduction: Format Remake, Format Adaptation, Format Translation and the Amount of Ready-Made Our article analyses the Italian TV series Tutto Può Succedere (2015-2018), which is an outstanding case in the Italian television panorama, being the first remake by the Italian Public Broadcasting Service of anAmerican TV show, Parenthood. -

Rai Fiction Giacomo Campiotti
RAI FICTION presenta REGIA DI GIACOMO CAMPIOTTI SCENEGGIATURA SANDRO PETRAGLIA GIACOMO CAMPIOTTI CON AURORA RUFFINO CARMINE BUSCHINI BRANDO PACITTO MIRKO TROVATO PIO PISCICELLI LORENZO GUIDI E CON MICHELA CESCON LAURA CHIATTI CARLOTTA NATOLI SIMONETTA SOLDER GIORGIO COLANGELI UNA CO-PRODUZIONE RAI FICTION - PALOMAR IN COLLABORAZIONE CON BIG BANG MEDIA S.L. PRODOTTO DA CARLO DEGLI ESPOSTI e NICOLA SERRA con MAX GUSBERTI BASATO SULLA serie di TV 3 TELEVISIO DE CATALUNYA “POLSERES VERMELLES” creata da ALBERT ESPINOSA e PAU FREIXAS e prodotta da FILMAX ENTERTAINMENT per TV 3 CON IL SOSTEGNO DI APULIA FILM COMMISSION SERIE TV - 6 EPISODI da 100’ in onda su RAIUNO da domenica 19 gennaio 2014 UFFICIO STAMPA Marzia Milanesi - Comunicazione per il Cinema via L. Reverberi, 26 – 25128 Brescia Tel./Fax: + 39 030 398767 / Mobile: +39 348 31 44 360 Email: [email protected] MATERIALI STAMPA DISPONIBILI SU WWW.MARZIAMILANESI.EU SCHEDA TECNICA Regia GIACOMO CAMPIOTTI Sceneggiatura SANDRO PETRAGLIA GIACOMO CAMPIOTTI Fotografia STEFANO RICCIOTTI Montaggio ROBERTO MISSIROLI STEFANO CHIERCHIE’ Ideazione scene PAOLA BIZZARRI Scenografia SABRINA BALESTRA Costumi CRISTINA FRANCIONI Suono GLAUCO POLETTI Trucco NADIA FERRARI Acconciature AURORA GAMBELLI Regia seconda unità GISELLA GOBBI Aiuto regia TIZIANA GAGNOR Supervisione brani editi e canzoni originali NICCOLÒ AGLIARDI Musiche originali STEFANO LENTINI Edizioni musicali CURCI - PALOMAR - RAI Edizione GIANNI MONCIOTTI Direttore di produzione ROBERTO GILIBERTO Produttore esecutivo GUIDO SIMONETTI produttori