Nuova Antologia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

“Dalla Banca Mista Alla Banca Universale – Gli Effetti Sul Sistema Economico Italiano”
Dipartimento di Impresa e Management Cattedra Storia dell’Economia e dell’Impresa “Dalla banca mista alla banca universale – gli effetti sul sistema economico italiano” RELATORE Prof. Vittoria Ferrandino CANDIDATO Andrea Pasquale Rosa Matr. 197121 ANNO ACCADEMICO 2018/2019 Indice Introduzione Pag. 3 Capitolo primo: L’economia italiana in età Pag. 5 giolittiana § 1 Giovanni Giolitti e il quadro politico Pag. 5 § 2 Giovanni Giolitti e il quadro economico Pag. 11 sociale § 3 Il Biennio rosso e l’ultimo governo Pag. 17 Giolitti Capitolo secondo: Lo Scandalo della Banca Pag. 22 Romana § 1 Lo scandalo, origini e cause Pag. 22 § 2 Dallo scandalo della Banca Romana alla Pag. 28 Banca d’Italia Capitolo terzo: Il periodo tra le due guerre e il Pag. 32 regime fascista § 1 La politica sociale del fascismo Pag. 32 § 2 La riforma bancaria del 1926 e il ruolo Pag. 37 della Banca d’Italia § 3 Il crollo di Wall Street e le sue Pag. 39 ripercussioni in Europa § 4 La riforma del 1936 Pag. 44 Capitolo quarto: Pag. 47 § 1 La ricostruzione e il ruolo della Banca Pag. 47 d’Italia § 2 Dagli anni Ottanta a Maastricht Pag. 54 § 3 La “riforma Amato” Pag. 58 Conclusioni Pag. 61 Bibliografia Pag. 63 Sitografia Pag. 64 Introduzione In via generale le banche esercitano una attività volta a raccogliere il risparmio di diversi soggetti e a finanziare, a determinate condizioni, imprese o privati cittadini per soddisfare specifiche esigenze economiche. Le entrate delle banche sono sostanzialmente costituite dai costi dei servizi offerti alla clientela, ivi compresi gli interessi pagati dai debitori sulle somme ad essi erogate1. -

The Corporatism of Fascist Italy Between Words and Reality
CORPORATIVISMO HISTÓRICO NO BRASIL E NA EUROPA http://dx.doi.org/10.15448/1980-864X.2016.2.22336 The corporatism of Fascist Italy between words and reality O corporativismo da Itália fascista entre palavras e realidade El corporativismo de la Italia fascista entre las palabras y la realidad Alessio Gagliardi* Translated by Sergio Knipe Abstract: It is common knowledge that State intervention in Italy in the Twenties and the Thirties developed outside of corporative institutions. The history of Fascist corporatism, however, is not only an unsuccessful story. Despite the failure of the “corporatist revolution” and “Fascist third way”, Fascist corporatism since the mid- Twenties helped the progressive development of a new political system to regulate relationship between State and private interests. The paper examines not only the institutional framework (the systems of formal laws, regulations, and procedures, and informal norms) but also their acts and real activities. It dwells upon internal debates, political and institutional importance acquired by corporative institutions in Fascist regime and behaviours of entrepreneurial organizations and labour unions. In this way, the paper aims to point out the “real” consequences of Fascist corporatism, different from the ideological ones. Keywords: corporatism; Fascism; Italy Resumo: É de conhecimento geral que intervenções estatais na Itália nas décadas de 1920 e 1930 se desenvolveram fora de instituições corporativas. A história do corporativismo fascista, no entanto, não é totalmente sem sucessos. Apesar da falha da “revolução corporativista” e da “terceira via fascista”, o corporativismo fascista, desde meados dos anos 1920, ajudou no desenvolvimento progressivo de um novo sistema político para regular a relação entre o Estado e interesses privados. -

L'opera Del Premio Nobel Giulio Natta Fra Le Attività
L’opera del premio Nobel Giulio Natta fra le attività della Società Italiana per il Progresso delle Scienze (SIPS) e della Società Chimica Italiana (SCI): alcune note ed osservazioni storico-critiche Giuseppe Iurato To cite this version: Giuseppe Iurato. L’opera del premio Nobel Giulio Natta fra le attività della Società Italiana per il Progresso delle Scienze (SIPS) e della Società Chimica Italiana (SCI): alcune note ed osservazioni storico-critiche. Quaderni di Ricerca in Didattica (Science), 2013, 5 (5), pp.31-85. hal-00868764 HAL Id: hal-00868764 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00868764 Submitted on 2 Oct 2013 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. L’opera del premio Nobel Giulio Natta fra le attività della So- cietà Italiana per il Progresso delle Scienze (SIPS) e della So- cietà Chimica Italiana (SCI): alcune note ed osservazioni stori- co-critiche Giuseppe Iurato University of Palermo, IT E-mail: [email protected] Sunto. Nonostante la sua grande portata storica e socio-istituzionale, la Società Italiana per il Progresso delle Scienze (SIPS) non ha tuttora quella notorietà storica che essa meriterebbe. Questo lavoro vuole solo cercare di contribuire a delineare uno schematico resoconto storico- critico che possa fornire una coerente prospettiva diacronica in cui inquadrare tale istituzione, evidenziando il rilevante peso che essa ha avuto nello sviluppo culturale, scientifico e tecnolo- gico dell’Italia post-risorgimentale. -

Delpaese E Le Forze Armate
L’ITALIA 1945-1955 LA RICOSTRUZIONE DEL PAESE STATO MAGGIORE DELLA DIFESA UFFICIO STORICO E LE Commissione E LE FORZE ARMATE Italiana Storia Militare MINISTERO DELLA DIFESA CONGRESSOCONGRESSO DIDI STUDISTUDI STORICISTORICI INTERNAZIONALIINTERNAZIONALI CISM - Sapienza Università di Roma ROMA, 20-21 NOVEMBRE 2012 Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) Palazzo Salviati ATTI DEL CONGRESSO PROPRIETÀ LETTERARIA tutti i diritti riservati: Vietata anche la riproduzione parziale senza autorizzazione © 2014 • Ministero della Difesa Ufficio Storico dello SMD Salita S. Nicola da Tolentino, 1/B - Roma [email protected] A cura di: Dott. Piero Crociani Dott.ssa Ada Fichera Dott. Paolo Formiconi Hanno contribuito alla realizzazione del Congresso di studi storici internazionali CISM Ten. Col. Cosimo SCHINAIA Capo Sezione Documentazione Storica e Coordinamento dell’Ufficio Storico dello SMD Ten. Col. Fabrizio RIZZI Capo Sezione Archivio Storico dell’Ufficio Storico dello SMD CF. Fabio SERRA Addetto alla Sezione Documentazione Storica e Coordinamento dell’Ufficio Storico dello SMD 1° Mar. Giuseppe TRINCHESE Capo Segreteria dell’Ufficio Storico dello SMD Mar. Ca. Francesco D’AURIA Addetto alla Sezione Archivio Storico dell’Ufficio Storico dello SMD Mar. Ca. Giovanni BOMBA Addetto alla Sezione Documentazione Storica e Coordinamento dell’Ufficio Storico dello SMD ISBN: 978-88-98185-09-2 3 Presentazione Col. Matteo PAESANO1 Italia 1945-1955 la ricostruzione del Paese el 1945 il Paese è un cumulo di macerie con una bassissima produzione industriale -
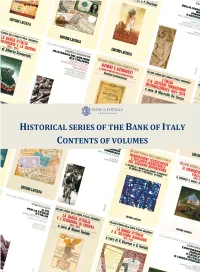
Contents Index
COLLANA STORICA DELLA BANCA D'ITALIA- DOCUMENTI L'ITALIA E IL SISTEMA FINANZIARIO INTERNAZIONALE 1861-1914 a cura di Marcello De Cecco EDITORI LATERZA CSBI – DOCUMENTS SERIES, I Italy and the International Financial System 1861-1914 edited by Marcello De Cecco CONTENTS Presentation by Carlo A. Ciampi VII Preface by Carlo M. Cipolla IX Abbreviations XVI Introduction 1 l. Italy in the International Monetary System 5 2. Italian Foreign Public Debt 22 2.1. The Big Loans of the First Half of 1960s, p. 23 - 2.2. The Loan for the Abolition of Non-convertibility 1881-1882, p. 32 - 2.3. The Conversion of Consols of 1906, p. 39 3. Problems with the Management of Foreign Exchange, Reserves and the Price of Consols Abroad 42 Conclusions 52 Appendix – Note on Sources 55 l. General Problems of Formulation of the Research 55 2. Archive Research 56 2.1. Italian Archives, p. 56 - 2.2. Foreign Archives, p. 59 3. Gaps of the Available Documentation 61 Documents 63 Biographies of the Main Characters Mentioned 963 Bibliography 979 Chronological Index and Document Summary 995 Index of Names 1019 Index of Institutions 1027 Analytical Index 1033 CSBI – DOCUMENTS SERIES, II Institutes of Issue in Italy. Attempts of Unification 1843-1892 edited by Renato De Mattia CONTENTS Presentation by Carlo A. Ciampi V Preface by Carlo M. Cipolla VII Abbreviations XIV Methodological Note XV Introduction 1 1. The Situation on the Eve of Political Unification 3 2. Features of the Monetary System and Payments Instruments before and after the Italian Unification 11 3. The Debate in the Most Ancient Period (1843-1853) 28 4. -

The Interjurisdictional Migration of European Authors of Liberty, 1660 – 1961: a Quantitative Analysis1
1 January 12, 2016 THE INTERJURISDICTIONAL MIGRATION OF EUROPEAN AUTHORS OF LIBERTY, 1660 – 1961: A QUANTITATIVE ANALYSIS1 Niklas Potrafke2 Roland Vaubel3 Abstract Hume, Montesquieu and Kant were the first to suggest that the rise of liberty in Europe and the West has been due to political fragmentation and competition among rulers because the creative elites had the option of leaving the country in response to political repression. In this paper we estimate the extent to which emigrating authors of liberty actually reacted to such political and economic factors. We distinguish four types of repressive political events: restoration of an authoritarian monarchy, suppression of liberal protests, takeover by a totalitarian regime and occupation by a foreign repressive power. We test for additional explanations of emigration. Our sample of well-known authors of liberty includes 401 persons from twenty European countries in 1660 to 1961. Our logistic regressions yield the following main results. The repressive events did have significant and large effects on emigration with lags of up to five years. Emigration was also influenced by the author’s occupation and interjurisdictional income differentials. The probability of emigration was larger if the author was of middle age and lived in a small country but these effects were numerically small. The decision to emigrate was not affected by the author’s education. JEL classifications: F22, N33, Z18 _______________ 1 Acknowledgements: The authors thank Daniel Mannfeld, Felix Weber, Georg Arndt and Justina Fischer for tabulating the data and Justina Fischer and Jonathan Seiler for retrieving some of the data. We received helpful comments from Dennis Snower, David Stadelmann, Bengt-Arne Wickström and the participants of the World Public Choice Society Meetings 2012, the Silvaplana Workshop on Political Economy 2013, the CESifo Political Economy Workshop 2013 and two anonymous referees. -

Introduzione
Introduzione Il primo profilo che incontriamo in questo libro è quello di Silvio Pellico (Saluzzo, Cuneo, 25 giugno 1789 - Torino, 31 gennaio 1854), e Vittorio Badini Confalonieri lo traccia a partire da un’importante let- tera inedita a Giulietta di Barolo del 17 aprile 1837 che trascrive e pubblica nell’ottobre 1954, in occasione del centenario della morte dello scrittore. Quarantenne deputato liberale del collegio Cuneo-A- sti-Alessandria (era a nato a Torino, il 14 marzo 1914), da settembre sottosegretario agli Affari esteri nel governo Scelba (incarico che manterrà anche nel successivo governo Segni, fino al maggio 1957), Badini Confalonieri sottolinea in queste pagine la « coerente fedeltà » di Pellico « all’idea liberale » e allo stesso tempo la sua profonda reli- giosità. Cita una lettera al Boglino, in cui lo scrittore afferma che « I princípi anche più giusti in sé medesimi diventano iniqui per i loro effetti, allorché sono professati da anime violente, superbe, vendicati- ve . No, il progresso sociale non verrà mai dalle fazioni irate, impa- zienti e calunniatrici; verrà con le virtù domestiche e con la carità civile oppure non verrà in nessun tempo », per insistere sull’impor- tanza appunto della “carità”, di un « generoso amore verso Dio e ver- so gli uomini », sulla capacità di perdonare anche i propri « nemici e torturatori ». Non era passato molto tempo da quando lo stesso Badi- ni aveva perdonato, permettendone la riabilitazione, il responsabile della prigionia e delle torture subite nei primi mesi del 1945 nella fa- migerata caserma di via Asti, a Torino. In conclusione, il giovane sottosegretario rivolge abilmente a Pellico le parole che lo scrittore aveva dedicato a Pietro Maroncelli: « Un grande amore per la giu- stizia, una grande tolleranza, una grande fiducia nelle virtù umane e negli aiuti della Provvidenza, un sentimento vivissimo del bello in tutte le arti, una fantasia ricca di poesia », dicendo che tale « è la defi- nizione che a lui meglio si addice e che lo rende e lo renderà sempre a noi caro, all’Italia esemplarmente prezioso ». -

La Marcia Su Roma
MARIO BUSSONI Mattioli 1885 Mattioli LA MARCIA SU ROMA VIAGGI NELLA STORIA ® 978-88-6261-236-4 Mattioli 1885 LA MARCIA SU ROMA | BUSSONI • INTRODUZIONE STORICA • BIOGRAFIE DEI PERSONAGGI • ITINERARI STORICO-TURISTICI • INDIRIZZI UTILI LA MARCIA SU ROMA di Mario Bussoni www.viaggiestoria.com viaggi nella storia ® by www.viagginellastoria.it B Mattioli 1885 Milano Cremona Perugia Monterotondo Civitavecchia Mentana Santa Marinella Tivoli ROMA Comando Centri di Raccolta Città importante In un quadro del pittore Giacomo Balla: l'ingresso a Roma. Mentana Tivoli abc 4 La Marcia su Roma La Marcia su Roma prima edizione Aprile 2012 © Mattioli 1885 srl - Strada della Lodesana, 649/sx, Loc. Vaio, 43036 Fidenza (Parma) tel. 0524.892111 - www.mattioli1885.com Grafica e Impaginazione Officine Grafiche Multimediali Via del Torrione, 27 - 43122 Parma Viaggi nella storia ® by www.viagginellastoria.it www.viaggiestoria.com Testi: Mario Bussoni Editing: Riccardo Baudinelli Coordinamento collana: Marcello Calzolari Foto di copertina: "L'Azione", statua del Vittoriano, Roma Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, non è consentita senza la preventiva autorizzazione scritta dell’editore. Viaggi nella Storia 5 PRESENTAZIONE Celebrata dal Regime come l’epilogo della Rivoluzione fascista, cosa è stata realmente la Marcia su Roma: una semplice manifestazione di piazza, sostanzialmente sopravvalutata, un vero e proprio colpo di stato o piuttosto una manifestazione violenta, un azzardo, fortunosamente andato a buon fine? Nelle pagine che seguono ne abbiamo ricostruito con precisione la dinamica, partendo dal 24 ottobre 1922, quando, nel corso del raduno delle camicie nere a Napoli, Benito Mussolini afferma sicuro: “O ci daranno il governo o lo prenderemo calando a Roma”. -

Politiche Scientifiche E Strategie D'impresa: Le
(a cura di) Giuliana Gemelli POLITICHE SCIENTIFICHE E STRATEGIE D’IMPRESA: LE CULTURE OLIVETTIANE ED I LORO CONTESTI Fondazione Adriano Olivetti Quaderni della Fondazione Adriano Olivetti 51 Politiche scientifiche e strategie d’impresa: le culture olivettiane ed i loro contesti a cura di Giuliana Gemelli © 2005 Fondazione Adriano Olivetti Il testo può essere liberamente riprodotto purché si citi la presente edizione. INDICE Prefazione 7 Giuliana Gemelli Riforme istituzionali, sviluppo economico e scienze sociali: un confronto Italia-Francia (1950-1970) 15 Carlo Olmo Progettualità e urbanistica nella Ricostruzione 35 Paolo Scrivano Lo scambio inter-atlantico ed i suoi attori: il rapporto tra Stati Uniti e Italia in architettura e urbanistica e il ruolo di Adriano Olivetti 47 Alberto Pedrazzini Aspetti locali della vicenda post bellica bolognese: dall’emergenza alla ricerca della costruzione di una città per l’uomo 79 Paola Di Biagi Quartieri e città nell’Italia degli anni Cinquanta. Il piano INA Casa 1949-1963 115 Simone Misiani La scuola di Portici e la politica del mestiere. Una proposta interpretativa 131 Rosanna Scatamacchia Un laboratorio per la Ricostruzione: il Servizio Studi della Banca d’Italia 165 Marco Di Giovanni Ufficiali «comandanti» o tecnocrati? La formazione dei quadri della Marina militare italiana nel secondo dopoguerra. Tradizioni culturali, scienza e management nell’età della guerra tecnologica. Appunti e ipotesi per la ricerca 215 Giuliana Gemelli e Flaminio Squazzoni Informatica ed elettronica negli anni Sessanta. Il ruolo di Roberto Olivetti attraverso l’Archivio Storico della Società Olivetti 257 Deborah Bolognesi Le origini del Cepas: dalla «Scuola di Guido Calogero» al «gruppo di Angela Zucconi» 309 PREFAZIONE La lungimiranza cartesiana è inutile se non vi si aggiunge una saggezza che riguardi non più lo spirito puro, ma il composto di anima e corpo. -

DIE ANFÄNGE DER POLITISCHEN SÄUBERUNG in ITALIEN 1943-1945 Eine Analyse Des Office of Strategie Services
Dokumentation HANS WOLLER DIE ANFÄNGE DER POLITISCHEN SÄUBERUNG IN ITALIEN 1943-1945 Eine Analyse des Office of Strategie Services Der Epoche von Faschismus und Nationalsozialismus folgte in nicht wenigen euro päischen Staaten eine kurze Zeitspanne der politischen Säuberungen1. Überall dort, wo in der Zwischenkriegszeit und im Zweiten Weltkrieg aus eigener Kraft oder mit Hilfe von Faschismus und Nationalsozialismus totalitär bzw. autoritär verfaßte Dik taturen errichtet worden waren, wo faschistische oder wesensverwandte Bewegun gen mit deutschen und italienischen Besatzern kollaboriert hatten, unternahmen die neuen Eliten - sei es aus eigenem Antrieb, sei es auf Geheiß der alliierten Sieger mächte - den Versuch, die Aktivisten, Nutznießer und Steigbügelhalter der verbre cherischen Regime und Bewegungen aufzuspüren, vor Gericht bzw. justizähnlichen Einrichtungen zur Verantwortung zu ziehen und aus leitenden Positionen in Staat und Gesellschaft zu entfernen. Die Abrechnung begann in der Regel 1944/45 mit der militärischen Besetzung und Unterwerfung durch die Streitkräfte der Anti-Hit ler-Koalition, sie kulminierte in den oft bürgerkriegsähnlichen Wirren, die mit dem Zusammenbruch der deutschen Herrschaft über Europa einhergingen, und sie endete 1947/48 im Kalten Krieg, der den anfänglichen politischen und moralischen Rigorismus bei der Aufklärung und Ahndung von Verbrechen ebenso dämpfte wie die Entschlossenheit zur politischen Säuberung und einer allgemeinen Rehabilitie rung politisch Belasteter Vorschub leistete. Die Ereignisse -

Preserving Financial Stability in Times of Crisis. a Tale of Two Public Banks: Monte Dei Paschi Di Siena and Banco Di Sicilia, 1929-1940
01-asso_7_40.qxp_01-asso_7_40 16/07/18 12:22 Pagina 9 Preserving Financial Stability in Times of Crisis. A Tale of Two Public Banks: Monte dei Paschi di Siena and Banco di Sicilia, 1929-1940 Pier Francesco Asso University of Palermo Sebastiano Nerozzi* Catholic University of the Sacred Heart ABSTRACT In this paper, we investigate the contrasting business strategies and models adopted by two major Italian public banks in the 1930s. Monte dei Paschi di Siena and Banco di Sicilia are interesting case studies for a number of reasons: their strong regional connections; their prolonged struggle for political independence from the national monetary authorities; their common attempt to modify the scale and scope of their business with the creation of integrated banking groups; and their early internationalization of activities. We examine how the two banks were affected by (and involved in) the major fi- nancial and economic crisis of the 1930s and show how external shocks altered their banking strategies and models. We also recon- struct the role played by the banking authorities and other important stakeholders. 1. Introduction The interwar period saw the birth of modern banking regula- tion in Italy, as in many other countries. It was then that the struc- ture and functioning of Italy’s banking system was shaped along * Pier Francesco Asso, Università di Palermo, corresponding author, francesco.asso@uni - pa.it; Sebastiano Nerozzi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, [email protected]. We wish to thank Ivo Maes, Michele Alacevich, and two anonymous referees for their valuable comments on a previous version of this essay. -

Storia, Cronaca E Arte Nel CIMITERO URBANO E Nel CIMITERO ISRAELITICO Di Cuneo
Giovanni Cerutti Storia, cronaca e arte nel CIMITERO URBANO e nel CIMITERO ISRAELITICO di Cuneo Stamperia comunale, 2016 Le pagine di questo fascicolo hanno lo Un primo ampliamento del cimitero scopo di accompagnare la visita ad alcune tombe urbano di Cuneo fu realizzato nel 1836/1837, con storiche ed artistiche del cimitero urbano di la costruzione della cappella e del portico Cuneo. adiacente, che fungeva da ingresso. Questo cimitero esiste da oltre duecento Un secondo ampliamento fu eseguito nel anni, ed oggi non poche tombe sono in condizioni 1875, con la costruzione del nuovo ingresso al di estremo degrado, determinato dal passare del cimitero, che è quello esistente, sul quale vi è la tempo e soprattutto perché non ci sono più i scritta: “HEIC CIVIUM OSSA QUIESCUNT” (Qui discendenti dei defunti. Ci auguriamo che privati riposano le ossa dei cittadini). cittadini, Associazioni, Fondazioni bancarie e, nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative, anche l’Amministrazione comunale possano provvedere al restauro e alla manutenzione di queste tombe, che hanno un grande valore come memoria storica della città o un valore artistico. Ho riportato anche alcune notizie storiche sul Cimitero urbano, il Cimitero israelitico, il Monumento – ossario dei soldati della Grande Guerra morti in ospedale per malattie o ferite, il Sacrario dei Partigiani caduti per la Liberazione di Cuneo e il Famedio. Consapevoli del dovuto rispetto che questo luogo merita e richiede, il cimitero può anche essere pensato come un museo a cielo aperto, un ambiente ricco di storia, cronaca e arte degli ultimi due secoli della nostra città e meritevole, quindi, di una visita.