Relazione Archeologica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ambito Di Paesaggio N. 14 "Bassa Valle Del Fiume Tirso"
Ambito di Paesaggio PPR Nuova individuazione Ambito di Paesaggio n. 14 "Bassa Valle del Fiume Tirso" Cabras, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Villanova Truschedu, Zerfaliu ELEMENTI STRUTTURA PERCETTIVA SARDEGNA NUOVE IDEE TAVOLO 2 “IL PROGETTO DEI PAESAGGI” Ambiente Incontri preliminari quaderno di lavoro - la parte settentrionale del Golfo di Oristano, che si estende con un ampio arco ellittico, dalla foce dello stagno di Mardini, a nord, fino a quella di s’Ena Arrubia a sud. Il litorale è caratterizzato da costa bassa e prevalentemente sabbiosa nella quale si sviluppa la spiaggia di Torre Grande. La continuità del cordone litoraneo è interrotta dalla presenza AMBITO n. 14 “BASSA VALLE DEL FIUME TIRSO” della foce fluviale del Fiume Tirso e dai numerosi canali lagunari attraverso cui le acque marine del golfo si connettono col sistema umido di Santa COMUNI COINVOLTI DESCRIZIONE Giusta; Cabras, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamaggiore, L’Ambito comprende il Golfo di Oristano dalla foce dello stagno di - i versanti occidentali del Monte Arci, caratterizzati dalle falde pedemontane Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Villanova Truschedu, Zerfaliu Mardini a quella di S’Ena Arrubia. e segnati dall’articolata rete di canali drenanti naturali che alimentano i La sua struttura è articolata sul sistema idrografico del Tirso: tale INQUADRAMENTO TERRITORIALE corpi idrici superficiali e sotterranei della pianura di Oristano-Terralba; sistema, così definito, richiede necessariamente una gestione - la copertura vegetale delle aree non agricole, che è rappresentata da unitaria delle acque, da un punto di vista idraulico e qualitativo, il formazioni boschive, arbustive, a gariga, e in aree circoscritte, da biotopi controllo del loro utilizzo e prelievo per garantire gli apporti, la naturali, riscontrabili anche negli ambienti acquatici dei rii, degli stagni, gestione delle relazioni tra usi agricoli e risorse idriche. -

Distretto Sociosanitario Di Ales
COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU (Provincia di Oristano) (Provincia de Aristanis) DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA Provincia di Oristano, ATS Sardegna ASSL Oristano, Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde Allegato C) Al Servizio Sociale del Comune di ___________________________ OGGETTO: Domanda di accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare PLUS (ADI Plus). Il/La sottoscritto/a (se persona diversa dall’utente) Cognome Nome Data e luogo di nascita Tipo di relazione con l’utente Residenza Recapiti telefonici/email DATI BENEFICIARIO: Cognome Nome Sesso M □ F □ Data di nascita Comune di nascita C.F. Comune di residenza Indirizzo Telefono /Email Domicilio Indirizzo Telefono/Email Stato civile Condizione lavorativa Grado d’istruzione EVENTUALE PERSONA INCARICATA DI TUTELA GIURIDICA o FAMILIARE DI RIFERIMENTO Nome____________________ Cognome ______________________ Ruolo ________________________ Residenza ________________________________________________________________ Tel. ________________________ Email ________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Comune di Mogoro (OR) - 09095 – Via Leopardi n.10 – C.F. 00070400957 – www.comune.mogoro.or.it Ufficio di Piano – P.zza Giovanni -

Piano Urbanistico Intercomunale
COMUNE DI ABBASANTA COMUNE DI NORBELLO Provincia di Oristano PUI piano urbanistico intercomunale Abbasanta: Sindaco: Stefano Sanna Norbello: Sindaco: Matteo Manca Ufficio del piano intercomunale responsabile: Arch. Gianfranco Sedda coordinatore: Arch. Francesco Dettori progettisti: Dott.geol. Mario Nonne, geologia Prof. Ignazio Camarda, sistema ambientale Dott. agr. Antonello Brunu, sistema ambientale Ing. Fabio Cambula, idraulica e mobilità Ing. Alberto Vaquer VAS e GIS Arch. Maria D.F. Rosaria Manca, sistema insed. e beni cultur. Dott. Federico Nurra, beni archeologici Dott. Giuseppe Medda, analisi sociodemografiche Dott.ssa Daniela Madau, beni culturali ufficio interno: Ing. Alessandro Fadda, Geom. Graziano Piras Geom. Daniele Tola RELAZIONI E TABELLE ALLEGATO RELAZIONE GENERALE seconda parte - Quadro conoscitivo R01.b Scala __ APPROVAZIONI: DATE documento preliminare Dicembre 2014 adozione preliminare Settembre 2020 Comuni di Abbasanta e Norbello / PUI relazione generale parte seconda quadro conoscitivo Indice 1. Introduzione al quadro delle conoscenze .......................................................................................... 4 2. Analisi dell’assetto ambientale........................................................................................................... 5 2.1. Inquadramento geologico .................................................................................................................. 5 2.2. Elaborati ............................................................................................................................................ -

Orari E Percorsi Della Linea Bus
Orari e mappe della linea bus 537 537 Oristano Stazione Arst Visualizza In Una Pagina Web La linea bus 537 (Oristano Stazione Arst) ha 4 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Oristano Stazione Arst: 13:40 (2) Oristano Z.I.: 06:25 - 06:40 (3) Sorgono Fronte Piazza Vittoria-Chiesa: 07:45 - 19:10 (4) Sorgono Piazza Vittoria-Chiesa: 05:55 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 537 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 537 Direzione: Oristano Stazione Arst Orari della linea bus 537 30 fermate Orari di partenza verso Oristano Stazione Arst: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 13:40 martedì 13:40 Sorgono Piazza Vittoria-Chiesa Via Portico, Sorgono mercoledì 13:40 Sorgono Ospedale San Camillo giovedì 13:40 SS 128 Ponte Tittiri venerdì 13:40 sabato 13:40 Atzara Bivio Samugheo domenica Non in servizio Atzara Via Vittorio Emanuele Fr.27 37 Via Vittorio Emanuele, Atzara Atzara Bivio Samugheo Informazioni sulla linea bus 537 Atzara SP 61 Direzione: Oristano Stazione Arst Fermate: 30 SP 61 Grughe Durata del tragitto: 100 min La linea in sintesi: Sorgono Piazza Vittoria-Chiesa, SP 61 Km 5.500 Sorgono Ospedale San Camillo, SS 128 Ponte Tittiri, Atzara Bivio Samugheo, Atzara Via Vittorio SP 33 Km 27.800 Emanuele Fr.27, Atzara Bivio Samugheo, Atzara SP 61, SP 61 Grughe, SP 61 Km 5.500, SP 33 Km 27.800, SP 33 Ponti Ecciu, Samugheo Via Gramsci SP 33 Ponti Ecciu 168, Samugheo Via Gramsci 110, Samugheo Piazza Sedda, Samugheo Via Vittorio Emanuele 135, Allai Samugheo Via Gramsci 168 Via Vittorio Emanuele 46, Allai Via Ponte Nuovo 8 Scuole, Fordongianus Via Roma Fr. -

Su Postale.Pub
suPostaledesalimbasarda Su POSTALEDESALIMBASARDA estunuprogetudesaProvìntziade Aristanisede73Comunes,ins’àmbitudesasatividadesculturalesdesuprogetu Lim- basarda:limbades’identidade,limbadesumundu –annualidade2007,finanziadu daesaPresidèntziadesuConsìgiudesosMinistros–DipartimentuprososAfares Regionales,cunformaasaLegen.482/99“ Normasinmatèriademinoriaslinguìsti- casistòricas ”. Su POSTALEDESALIMBASARDA estunamostradidatticasubrasalim- basardaeas’istòriadesaSardignachiataarribareintotusasIscolasMèdiasdesos Comuneschiantaderiduasuprogetu. Su POSTALEDESALIMBASARDA estunuprogetudesaProvìntziadeAristanispariscun sosComunesdeAbbasanta,Aidomaggiore,Albagiara,Ales,Allai,Ardauli,Assolo,Asuni,Bara- dili,BaratiliS.P.,Baressa,Bauladu,Bidonì,Bonarcado,Busachi,Cabras,Cuglieri,Curcuris,Flus- sio,Ghilarza,Gonnoscodina,Gonnosnò,Laconi,Marrubiu,Masullas,Milis,Modolo,Mogorel- la,Mogoro,Montresta,Morgongiori,Narbolia,Neoneli,Norbello,NugheduS.V.,Nureci,Nu- rachi,Oristano,PalmasArborea,Pau,Paulilatino,Pompu,RiolaSardo,Ruinas,Sagama,Samu- gheo,S.Nicolòd’Arcidano,SantaGiusta,SantuLussurgiu,SanVeroMilis,ScanodiMontiferro, Seneghe,Senis,Siamaggiore,Simala,Sini,Soddì,Solarussa,Sorradile,Suni,Tadasuni,Terralba, Tinnura,Tramatza,Tresnuraghes,UlaTirso,Usellus,VillanovaTruschedu,VillaS.Antonio,Vil- laurbana,Villaverde,Zeddiani,Zerfaliu. IlprogettoèstatoideatodallaProvinciadiOristanoSettorepromozionedelTerritorio,dalDirigentePiero Dau,ilResponsabiledelServizioCulturaGiorgioZagoeglioperatoridell’UfficiodellaLinguasarda.Hanno collaborato,pergliallestimentil’architettoPierpaoloPerra,peritestidistoriailprofessorRaimondoZucca, perleillustrazionisullastoriagiudicaleEmanueleMureddu. Perinformazioni: ProvìntziadeAristanis AssessoraduasaCultura SetorePromotzionedesuTerritòriu ServìtziuCultura UfìtziudesaLimbaedesaCulturaSarda dott.ssaMarinellaMarras dott.SalvatoreCubeddu tel.0783/3683.203 fax.0783/3683.264. -

Comuni Di Villaurbana- Mogorella, Ruinas Provincia Di Oristano Ufficio Segreteria Comunale
COMUNI DI VILLAURBANA- MOGORELLA, RUINAS PROVINCIA DI ORISTANO UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE SERVIZI GENERALI CIRCOLARE INTERNA n. 14 del 27/11/2018 Al Responsabili del servizio finanziario Ai Responsabili dei servizi tecnici Ai responsabili dei servizi amministrativi A tutti i Responsabili di procedimento E P.C. Al Sig. Sindaco Al revisore dei Conti Al componente esterno del nucleo di valutazione OGGETTO: Attestazione annuale dell’Organismo di Valutazione sulla trasparenza - Anno 2018 Gentilissimi Vi rammento che anche quest’anno al 31 gennaio 2019 dovrà essere resa all’’autorità Anticorruzione, a cura del nucleo di valutazione, l’ attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista ai sensi dell’art. 14, co 4, lett) g. del D.Lgs. n. 33/2013 I responsabili di procedimento devono provvedere subito a una ricognizione della sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale e alla pronta implementazione delle sotto-sezioni che mostrino carenze, così da presentarsi preparati al meglio nel momento in cui il nucleo provvederà al controllo, alla compilazione della griglia e alla predisposizione dell’attestazione, che RAMMENTO in tutti e tre i comuni sarà eseguito entro i primi del mese di gennaio 2018. Pag. 1/2 - Ente: COMUNE DI OLLASTRA Anno: 2018 Numero: 5786 Tipo: I Data: 03.12.2018 Categoria: 1 Classe: 7 Vi rammento inoltre che il corretto inserimento dei dati di competenza a cura di ciascun Responsabile in tutte le sottosezioni di” Amministrazione Trasparente” è, oltre ad un adempimento imposto dalla legge con sanzioni di vario genere, un obiettivo di Performance Organizzativa 2018 in tutti e tre i Comuni il cui grado di attuazione sarà oggetto di verifica da parte del Nucleo di valutazione. -

Mobilitazione Degli Enti Locali Della
COPIA COMUNE DI ABBASANTA PROVINCIA DI ORISTANO Via Garibaldi, 144 – 09071 Abbasanta (OR) [email protected] | www.comune.abbasanta.or.it Tel: 0785/5616 | C.F. e P.IVA 00068600956 | Codice Univoco UF6RKN DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Atto n. 1 Oggetto: Mobilitazione degli Enti Locali della Sardegna e attivazioni di azioni contro l’ipotesi di del 21/01/2021 stoccaggio di scorie nucleari, anche in forma provvisoria, nei Comuni del territorio della Sardegna. L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 19:00 presso la Sala Agorà, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Straordinaria. Ruolo Nominativo Presente Assente Sindaca Carta Patrizia Si Consigliere Congiu Giuseppe Si Consigliere Manca Alessandra Si Consigliere Conversi Enrico Si Consigliere Fiori Sebastiano Si Consigliere Scanu Giulia Si Consigliere Serra Paola Giuseppina Si Consigliere Mureddu Giovanni Egidio Si Consigliere Demurtas Sabrina Si Consigliere Secci Giorgio Si Consigliere Carta Paola Si Consiglieri presenti: 10 Consiglieri assenti: 1 Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Falchi Gianfranco in qualità di Segretario Comunale. La seduta è Pubblica. Pag. 1 di 6 IL CONSIGLIO COMUNALE Il Sindaco illustra l’argomento. Premesso che: − è stata avviata la procedura per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico, ai sensi del Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31; − Sogin S.p.A, ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 del D.lgs. -

Guida All'ospitalità 31 Gennaio
GUIDA ALL’OSPITALITÀ IN PROVINCIA DI ORISTANO 2009 Le tariffe pubblicate nella guida sono quelle dichiarate dai gestori degli esercizi ricettivi per l’anno 2009 nche quest’anno, per un preciso dovere istituzionale e per non venir sostenibile che hanno come caratteristica il rispetto dell’ambiente e del Ameno ad una tradizione ampiamente consolidata che si rinnova da patrimonio naturale e culturale dei territori. Il turismo equestre, quello almeno due decenni, viene edita la guida all’ospitalità della Provincia di religioso e quello termale, l’ospitalità nei bed & breakfast e negli alberghi Oristano. diffusi, realtà ben consolidate nell’Oristanese. Forme di un turismo, Si tratta di un supporto di primaria importanza per il turista poiché offre insomma, che non si impone sul territorio ma che lo valorizza rispettandolo. informazioni complete e aggiornate sulla consistenza e sulle tariffe degli A ciò si aggiungono le forme più tradizionali di ospitalità con una presenza esercizi ricettivi esistenti nel territorio, nonché un elenco di indirizzi utili su sempre più ampia di strutture di fascia medio-alta che migliorano anche luoghi di interesse e servizi che aiuteranno il visitatore a trascorrere un sotto il profilo qualitativo il nostro patrimonio ricettivo. soggiorno migliore. Concludiamo con un augurio di buone vacanze a chi, anche grazie a questa La Provincia di Oristano sta concentrando le sue forze sullo sviluppo guida, sceglierà di visitare il nostro territorio, e un augurio di buon lavoro e di turistico ed in particolare su tutte quelle -

Analisi Dei Dati
Analisi dei dati Carta geologica Costruzione ed imp ortazione nel GIS La carta geologica fornita dal Dipartimento di Ingegneria del Territorio dellUniversitadi Cagliari in formato CAD e scala e stata elab orata con ArcInfo p er la correzione degli errori e successiva costruzione della top ologia In Fig e si rip ortano i risultati di tali elab orazioni ritagliati sullarea GIS e sullarea mo dello risp ettivamente cos come denite nel rapp orto In Fig si rip orta la legenda valida p er ambedue le mapp e Descrizione ed inquadramento geologico La piana di Oristano e imp ostata su un Grab en Movimenti crustali risalenti al Terziario crearono una zona di rifting tra il continente francoib erico e la placca sardocorsa La stessa si distacco e successivamente 0 rototrasloin senso anti orario di circa La fossa tettonica Sarda diretta NS rappresenta il braccio pi u orientale del rift Susseguentemente ad un intenso vulcanismo a carattere calcoalcalino ed al dep osito di sedimenti marini e continentali la fossa fu completamente colmata Il Grab en si formop er la riattivazione di alcune faglie della fossa tettonica Sarda risalente al PlioPleisto cene Per quanto riguarda dep ositi risalenti al p erio do Terziario si puo dire che nella zona studiata sono presenti aoramenti cenozoici rappresentati da vulcaniti andesitiche Queste si p ossono trovare anche lungo la strada statale tra il km e il km Sedimenti mio cenici marini aorano ai piedi del monte Palla Presso il nuraghe SArgara sono visibili facies marnosearenacee Questi sedimenti risalgono -
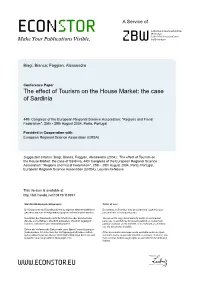
The Case of Sardinia
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra Conference Paper The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra (2004) : The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia, 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/116951 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus
Orari e mappe della linea bus 442 442 Laconi - Asuni - Ruinas - V.Urbana - Simaxis - Visualizza In Una Pagina Web Torregrande La linea bus 442 (Laconi - Asuni - Ruinas - V.Urbana - Simaxis - Torregrande) ha 2 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Laconi Corso Garibaldi Fr.Comune: 18:00 (2) Torregrande Spiaggia: 07:45 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 442 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 442 Direzione: Laconi Corso Garibaldi Fr.Comune Orari della linea bus 442 32 fermate Orari di partenza verso Laconi Corso Garibaldi VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA Fr.Comune: lunedì Non in servizio Torregrande Spiaggia martedì Non in servizio 89 Via Domenico Millelire, Oristano mercoledì Non in servizio Torregrande 21 Via Domenico Millelire, Oristano giovedì Non in servizio Torregrande Via Stella Maris 3 venerdì Non in servizio Piazza della Torre, Oristano sabato Non in servizio Simaxis Via San Simaco 5 domenica 18:00 40 Via Goffredo Mameli, Simaxis Simaxis 170 Via San Simaco, Simaxis Informazioni sulla linea bus 442 Simaxis Via San Simaco 311 Direzione: Laconi Corso Garibaldi Fr.Comune 334 Via San Simaco, Simaxis Fermate: 32 Durata del tragitto: 133 min Siamanna Via Sardegna 8 La linea in sintesi: Torregrande Spiaggia, Via A. Zucca, Siamanna Torregrande, Torregrande Via Stella Maris 3, Simaxis Via San Simaco 5, Simaxis, Simaxis Via San Simaco Siapiccia 311, Siamanna Via Sardegna 8, Siapiccia, Siamanna 2 Via Antonio Gramsci, Siamanna Via Sardegna 68, Siamanna Via Sardegna 116, Villaurbana -

Comune Di Oristano
TURNI DELLE FARMACIE DEL MESE DI GENNAIO 2014 ALLEGATO N. 2 1 MER URAS NUGHEDU S.V. SAMUGHEO TRAMATZA GONNOSNO' BOSA-SOLINAS / FLUSSIO SANNA 2 GIO TERRALBA-ANNIS NEONELI- S.LUSSURGIU OLLASTRA NARBOLIA SIMALA - LACONI MAGOMADAS S.CROCE 3 VEN ARBOREA GHILARZA-CALAMIDA SIAMANNA SENEGHE BARESSA TINNURA LODDO 4 SAB MOGORO /SANT'ANNA PAULILATINO-TADASUNI VILLAURBANA NURACHI SENIS BOSA-SOLINAS / CUGLIERI CHESSA 5 DOM ARCIDANO ABBASANTA PALMAS ARBOREA RIOLA SARDO VILLAVERDE BOSA-SOLINAS / S.CATERINA CHESSA 6 LUN MARRUBIU SORRADILE FORDONGIANUS BARATILI S.P. CURCURIS BOSA SARDU/ MONTR. /S.CATERINA BRESCIANI 7 MAR TERRALBA-LANICCA SEDILO- BORONEDDU ALLAI ZEDDIANI GONNOSCODINA BOSA-SOLINAS SAN CARLO 8 MER SANTA GIUSTA AIDOMAGGIORE BUSACHI SILI' GENONI-PAU BOSA-SARDU PIRAS 9 GIO URAS ARDAULI SOLARUSSA CABRAS - CONCAS MORGONG./ MOGORELLA TRESNURAGHES SANNA 10 VEN TERRALBA-ANNIS NORBELLO SIMAXIS-ORTUERI SIAMAGGIORE GONNOSTR.- LACONI SUNI S.CROCE 11 SAB ARBOREA GHILARZA-S.PALMERIO ZERFALIU MILIS MASULLAS BOSA SARDU / MAGOMADAS LODDO 12 DOM MOGORO /SANT'ANNA NUGHEDU S.V. SAMUGHEO SAN VERO MILIS ALES BOSA SARDU / FLUSSIO LODDO 13 LUN ARCIDANO NEONELI- S.LUSSURGIU OLLASTRA CABRAS - CHESSA RUINAS- SINI TINNURA BRESCIANI 14 MAR TERRALBA- LANICCA GHILARZA-CALAMIDA SIAMANNA BONARCADO VILLA S. ANTONIO CUGLIERI CHESSA 15 MER MARRUBIU PAULILATINO-TADASUNI VILLAURBANA BAULADU USELLUS SCANOMONTIFERRO SAN CARLO 16 GIO SANTA GIUSTA SORRADILE FORDONGIANUS TRAMATZA GONNOSNO' TRESNURAGHES PIRAS 17 VEN URAS ABBASANTA PALMAS ARBOREA NARBOLIA SIMALA BOSA-SARDU SANNA 18 SAB TERRALBA-ANNIS SEDILO- BORONEDDU ALLAI SENEGHE BARESSA- LACONI BOSA-SOLINAS S.CROCE 19 DOM ARBOREA AIDOMAGGIORE BUSACHI NURACHI SENIS BOSA-SOLINAS / MONTR./ SCANOMONT. S.CROCE 20 LUN MOGORO /SANT'ANNA ARDAULI SOLARUSSA RIOLA SARDO VILLAVERDE SUNI LODDO 21 MAR ARCIDANO NORBELLO SIMAXIS-ORTUERI BARATILI S.P.