Piano Urbanistico Intercomunale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ambito Di Paesaggio N. 16 "Montiferru"
Ambito di Paesaggio PPR Nuova individuazione Ambito di Paesaggio n. 16 "Montiferru" Cuglieri, Narbolia, Santu Lussurgiu, Scano Montiferro, Seneghe, Sennariolo ELEMENTI STRUTTURA PERCETTIVA SARDEGNA NUOVE IDEE TAVOLO 2 “IL PROGETTO DEI PAESAGGI” Ambiente Incontri preliminari quaderno di lavoro - L’articolato sistema costiero delle baie di Santa Caterina di Pittinurri e di s’Archittu, delimitato dallo sviluppo irregolare di archi rocciosi, falesie e scogliere scolpite su arenarie e calcareniti biancastre del terziario; AMBITO n. 16 “MONTIFERRU” - il complesso orografico vulcanico del Montiferru e le formazioni boschive che caratterizzano i versanti che si presentano in un mosaico di comunità COMUNI COINVOLTI DESCRIZIONE vegetali diverse, rappresentate da una maestosa foresta composta da Cuglieri, Narbolia, Santu Lussurgiu, Scano Montiferro, Seneghe, Sennariolo La struttura dell'Ambito è definita dalla dominante ambientale del lecci, querce caducifoglie, tasso, agrifoglio, acero minore e la copertura massiccio del Montiferru. La denominazione è derivante dal che doveva caratterizzare anche i versanti che, dopo i tagli e gli incendi, INQUADRAMENTO TERRITORIALE filone di ferro presente presso il Monte alle spalle della piana di sono stati trasformati parzialmente in aree di pascolo; Cornus. L'Ambito corrisponde all'esteso territorio che incorpora il - la valle del Rio S'Abba Lughida, nel versante occidentale, regno della fitta profilo del cono vulcanico del Montiferru, con la maggiore lecceta associata all'agrifoglio, alla roverella e al corbezzolo; -

Orari E Percorsi Della Linea Bus
Orari e mappe della linea bus 537 537 Oristano Stazione Arst Visualizza In Una Pagina Web La linea bus 537 (Oristano Stazione Arst) ha 4 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Oristano Stazione Arst: 13:40 (2) Oristano Z.I.: 06:25 - 06:40 (3) Sorgono Fronte Piazza Vittoria-Chiesa: 07:45 - 19:10 (4) Sorgono Piazza Vittoria-Chiesa: 05:55 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 537 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 537 Direzione: Oristano Stazione Arst Orari della linea bus 537 30 fermate Orari di partenza verso Oristano Stazione Arst: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 13:40 martedì 13:40 Sorgono Piazza Vittoria-Chiesa Via Portico, Sorgono mercoledì 13:40 Sorgono Ospedale San Camillo giovedì 13:40 SS 128 Ponte Tittiri venerdì 13:40 sabato 13:40 Atzara Bivio Samugheo domenica Non in servizio Atzara Via Vittorio Emanuele Fr.27 37 Via Vittorio Emanuele, Atzara Atzara Bivio Samugheo Informazioni sulla linea bus 537 Atzara SP 61 Direzione: Oristano Stazione Arst Fermate: 30 SP 61 Grughe Durata del tragitto: 100 min La linea in sintesi: Sorgono Piazza Vittoria-Chiesa, SP 61 Km 5.500 Sorgono Ospedale San Camillo, SS 128 Ponte Tittiri, Atzara Bivio Samugheo, Atzara Via Vittorio SP 33 Km 27.800 Emanuele Fr.27, Atzara Bivio Samugheo, Atzara SP 61, SP 61 Grughe, SP 61 Km 5.500, SP 33 Km 27.800, SP 33 Ponti Ecciu, Samugheo Via Gramsci SP 33 Ponti Ecciu 168, Samugheo Via Gramsci 110, Samugheo Piazza Sedda, Samugheo Via Vittorio Emanuele 135, Allai Samugheo Via Gramsci 168 Via Vittorio Emanuele 46, Allai Via Ponte Nuovo 8 Scuole, Fordongianus Via Roma Fr. -

Mobilitazione Degli Enti Locali Della
COPIA COMUNE DI ABBASANTA PROVINCIA DI ORISTANO Via Garibaldi, 144 – 09071 Abbasanta (OR) [email protected] | www.comune.abbasanta.or.it Tel: 0785/5616 | C.F. e P.IVA 00068600956 | Codice Univoco UF6RKN DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Atto n. 1 Oggetto: Mobilitazione degli Enti Locali della Sardegna e attivazioni di azioni contro l’ipotesi di del 21/01/2021 stoccaggio di scorie nucleari, anche in forma provvisoria, nei Comuni del territorio della Sardegna. L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 19:00 presso la Sala Agorà, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Straordinaria. Ruolo Nominativo Presente Assente Sindaca Carta Patrizia Si Consigliere Congiu Giuseppe Si Consigliere Manca Alessandra Si Consigliere Conversi Enrico Si Consigliere Fiori Sebastiano Si Consigliere Scanu Giulia Si Consigliere Serra Paola Giuseppina Si Consigliere Mureddu Giovanni Egidio Si Consigliere Demurtas Sabrina Si Consigliere Secci Giorgio Si Consigliere Carta Paola Si Consiglieri presenti: 10 Consiglieri assenti: 1 Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Falchi Gianfranco in qualità di Segretario Comunale. La seduta è Pubblica. Pag. 1 di 6 IL CONSIGLIO COMUNALE Il Sindaco illustra l’argomento. Premesso che: − è stata avviata la procedura per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico, ai sensi del Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31; − Sogin S.p.A, ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 del D.lgs. -

Relazione Archeologica
Relazione Archeologica Sindaco Felice Atzori Assessore Ambiente, Agricoltura e Foreste Pierpaolo Casu Coordinamento Ufficio di Piano angelica sedda - ingegnere ignazio melis - geometra Eleborazione VAS tiziano simbula - ingegnere fausto alessandro pani - geologo Urbanistica e pianificazione tiziano simbula - ingegnere gianni porcu - ingegnere Agronomia massimo cau - agronomo Geologia, geomorfologia e PAI giovanna frau - geologo matteo pintore - ingegnere Archeologia e Paesaggio carla delvais - archeologa pietro francesco serreli archeologo Data dicembre 2015 INDICE INTRODUZIONE pag. 2 I METODOLOGIA “ 3 II IL TERRITORIO IN ETÀ PREISTORICA E PROTOSTORICA “ 6 III IL TERRITORIO IN ETÀ PUNICA E ROMANA “ 13 III.1 L’ETÀ PUNICA “ 13 III.2 L’ETÀ ROMANA, TARDOANTICA E ALTO-MEDIEVALE “ 14 III.2.1 INSEDIAMENTI “ 14 III.2.2 NECROPOLI “ 20 IV LA VIABILITÀ STORICA “ 22 IV.1 STRUTTURE “23 IV.2 ASSI VIARI “24 V IL TERRITORIO DALL’ETÀ MEDIEVALE ALL’ETÀ CONTEMPORANEA “ 32 BIBLIOGRAFIA “ 39 COMUNE DI USELLUS PIANO URBANISTICO COMUNALE INTRODUZIONE Il territorio comunale di Usellus conosce una frequentazione intensa e ininterrotta a partire dalla preistoria e fino ad età odierna, nota attraverso le fonti storiche, d’archivio e archeologiche; deve tuttavia osservarsi che le profonde trasformazioni che il territorio ha subito principalmente nel corso del Novecento hanno reso assai complessa l’individuazione di nuovi siti e anche di una parte di quelli già noti in letteratura. La particolare conformazione del territorio comunale, che si estende e penetra, attraverso il valico di Genna Entu, nelle valli interne dell’Alto Flumendosa fino al nodo del Gennargentu, ha determinato, nelle diverse epoche, una frequentazione antropica funzionale allo sfruttamento delle risorse dei diversi areali. -

Analisi Dei Dati
Analisi dei dati Carta geologica Costruzione ed imp ortazione nel GIS La carta geologica fornita dal Dipartimento di Ingegneria del Territorio dellUniversitadi Cagliari in formato CAD e scala e stata elab orata con ArcInfo p er la correzione degli errori e successiva costruzione della top ologia In Fig e si rip ortano i risultati di tali elab orazioni ritagliati sullarea GIS e sullarea mo dello risp ettivamente cos come denite nel rapp orto In Fig si rip orta la legenda valida p er ambedue le mapp e Descrizione ed inquadramento geologico La piana di Oristano e imp ostata su un Grab en Movimenti crustali risalenti al Terziario crearono una zona di rifting tra il continente francoib erico e la placca sardocorsa La stessa si distacco e successivamente 0 rototrasloin senso anti orario di circa La fossa tettonica Sarda diretta NS rappresenta il braccio pi u orientale del rift Susseguentemente ad un intenso vulcanismo a carattere calcoalcalino ed al dep osito di sedimenti marini e continentali la fossa fu completamente colmata Il Grab en si formop er la riattivazione di alcune faglie della fossa tettonica Sarda risalente al PlioPleisto cene Per quanto riguarda dep ositi risalenti al p erio do Terziario si puo dire che nella zona studiata sono presenti aoramenti cenozoici rappresentati da vulcaniti andesitiche Queste si p ossono trovare anche lungo la strada statale tra il km e il km Sedimenti mio cenici marini aorano ai piedi del monte Palla Presso il nuraghe SArgara sono visibili facies marnosearenacee Questi sedimenti risalgono -

Elenco Amministratori Aventi Diritto Al Voto Alla Data Del 31 Dicembre 2020
ELENCO AMMINISTRATORI AVENTI DIRITTO AL VOTO ALLA DATA DEL 26/12/2020 - DATI AGGIORNATI ALLE ORE 14,00 DEL 31/12/2020 Numero N. Comune Cognome Nome Carica ricoperta Consiglieri 1 1 ABBASANTA CARTA PATRIZIA SINDACO 2 ABBASANTA CONGIU GIUSEPPE VICE SINDACO 3 ABBASANTA CONVERSI ENRICO ASSESSORE 4 ABBASANTA MANCA ALESSANDRA ASSESSORE 5 ABBASANTA CARTA PAOLA CONSIGLIERE 6 ABBASANTA DEMURTAS SABRINA CONSIGLIERE 7 ABBASANTA FIORI SEBASTIANO CONSIGLIERE 8 ABBASANTA MUREDDU GIOVANNI EGIDIO CONSIGLIERE 9 ABBASANTA SCANU GIULIA CONSIGLIERE 10 ABBASANTA SECCI GIORGIO CONSIGLIERE 11 ABBASANTA SERRA PAOLA GIUSEPPINA CONSIGLIERE 2 1 AIDOMAGGIORE SALARIS MARIANO Sindaco 2 AIDOMAGGIORE ATZORI GIOVANNI Consigliere 3 AIDOMAGGIORE BARRANCA ANTONELLA Assessore 4 AIDOMAGGIORE CARBONI MARIO Consigliere 5 AIDOMAGGIORE MARRAS MASSIMO Consigliere 6 AIDOMAGGIORE MASIA MARIA LUSSORIA Consigliere AIDOMAGGIORE PALA MARIA LOURDES 29/12/2020 (Dimissioni) 7 AIDOMAGGIORE VIRDIS SIMONE Consigliere 8 AIDOMAGGIORE ZIULU RAFFAELE Consigliere 3 1 ALBAGIARA MARROCU MARCO SINDACO 2 ALBAGIARA DEDONI FABRIZIO VICE SINDACO 3 ALBAGIARA MALLOCI ARDUINO ASSESSORE 4 ALBAGIARA MALLOCI MAURIZIO ASSESSORE 5 ALBAGIARA CAULI PIETRO CONSIGLIERE 6 ALBAGIARA PIANU MAURO CONSIGLIERE 7 ALBAGIARA MALLOCI MASSIMO CONSIGLIERE 8 ALBAGIARA SERRA IGNAZIO CONSIGLIERE 9 ALBAGIARA CABONI MARIA LUISA CONSIGLIERE 10 ALBAGIARA MALLOCI ROBERTO CONSIGLIERE 11 ALBAGIARA SERRA EFISIO CONSIGLIERE 4 1 ALES MEREU FRANCESCO SINDACO 2 ALES TRUDU EMANUELE CONSIGLIERE/VICESINDACO 3 ALES COLLU FABRIZIO CONSIGLIERE/ASSESSORE -

PR COMUNE OR Abbasanta SS Aggius SS Aglientu OR
allegato a determinazione N. ______ del_____________ ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTIAS E URBANISTICA ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA Servizio degli Enti Locali FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI ANNO 2020 - IMPEGNO - 2^° TRIMESTRE - ASSEGNAZIONI STATALI PR COMUNE OR Abbasanta SS Aggius SS Aglientu OR Aidomaggiore SS Alà dei Sardi OR Albagiara OR Ales SS Alghero OR Allai SS Anela OR Arborea SU Arbus SS Ardara OR Ardauli NU Aritzo SU Armungia SS Arzachena NU Arzana CA Assemini OR Assolo OR Asuni NU Atzara NU Austis SS Badesi SU Ballao SS Banari OR Baradili OR Baratili San Pietro OR Baressa NU Bari Sardo SU Barrali SU Barumini OR Bauladu NU Baunei NU Belvì SS Benetutti SS Berchidda SS Bessude OR Bidonì NU Birori NU Bitti NU Bolotana OR Bonarcado SS Bonnanaro SS Bono SS Bonorva OR Boroneddu NU Borore NU Bortigali 1 allegato a determinazione N. ______ del_____________ ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTIAS E URBANISTICA ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA Servizio degli Enti Locali FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI ANNO 2020 - IMPEGNO - 2^° TRIMESTRE - ASSEGNAZIONI STATALI PR COMUNE SS Bortigiadas SS Borutta OR Bosa SS Bottidda SS Buddusò SS Budoni SU Buggerru SS Bultei SS Bulzi SU Burcei SS Burgos OR Busachi OR Cabras CA Cagliari SS Calangianus SU Calasetta CA Capoterra SU Carbonia NU Cardedu SS Cargeghe SU Carloforte SS Castelsardo SU Castiadas SS Cheremule SS Chiaramonti SS Codrongianos SU Collinas SS Cossoine OR Cuglieri OR Curcuris CA Decimomannu SU Decimoputzu NU Desulo SU Dolianova SU Domus de Maria SU Domusnovas SU Donori NU Dorgali NU Dualchi NU Elini CA Elmas SS Erula SU Escalaplano SU Escolca SS Esporlatu SU Esterzili SS Florinas SU Fluminimaggiore OR Flussio 2 allegato a determinazione N. -
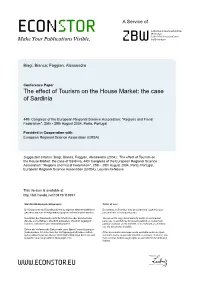
The Case of Sardinia
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra Conference Paper The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra (2004) : The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia, 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/116951 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. -

Comune Di Oristano
TURNI DELLE FARMACIE DEL MESE DI GENNAIO 2014 ALLEGATO N. 2 1 MER URAS NUGHEDU S.V. SAMUGHEO TRAMATZA GONNOSNO' BOSA-SOLINAS / FLUSSIO SANNA 2 GIO TERRALBA-ANNIS NEONELI- S.LUSSURGIU OLLASTRA NARBOLIA SIMALA - LACONI MAGOMADAS S.CROCE 3 VEN ARBOREA GHILARZA-CALAMIDA SIAMANNA SENEGHE BARESSA TINNURA LODDO 4 SAB MOGORO /SANT'ANNA PAULILATINO-TADASUNI VILLAURBANA NURACHI SENIS BOSA-SOLINAS / CUGLIERI CHESSA 5 DOM ARCIDANO ABBASANTA PALMAS ARBOREA RIOLA SARDO VILLAVERDE BOSA-SOLINAS / S.CATERINA CHESSA 6 LUN MARRUBIU SORRADILE FORDONGIANUS BARATILI S.P. CURCURIS BOSA SARDU/ MONTR. /S.CATERINA BRESCIANI 7 MAR TERRALBA-LANICCA SEDILO- BORONEDDU ALLAI ZEDDIANI GONNOSCODINA BOSA-SOLINAS SAN CARLO 8 MER SANTA GIUSTA AIDOMAGGIORE BUSACHI SILI' GENONI-PAU BOSA-SARDU PIRAS 9 GIO URAS ARDAULI SOLARUSSA CABRAS - CONCAS MORGONG./ MOGORELLA TRESNURAGHES SANNA 10 VEN TERRALBA-ANNIS NORBELLO SIMAXIS-ORTUERI SIAMAGGIORE GONNOSTR.- LACONI SUNI S.CROCE 11 SAB ARBOREA GHILARZA-S.PALMERIO ZERFALIU MILIS MASULLAS BOSA SARDU / MAGOMADAS LODDO 12 DOM MOGORO /SANT'ANNA NUGHEDU S.V. SAMUGHEO SAN VERO MILIS ALES BOSA SARDU / FLUSSIO LODDO 13 LUN ARCIDANO NEONELI- S.LUSSURGIU OLLASTRA CABRAS - CHESSA RUINAS- SINI TINNURA BRESCIANI 14 MAR TERRALBA- LANICCA GHILARZA-CALAMIDA SIAMANNA BONARCADO VILLA S. ANTONIO CUGLIERI CHESSA 15 MER MARRUBIU PAULILATINO-TADASUNI VILLAURBANA BAULADU USELLUS SCANOMONTIFERRO SAN CARLO 16 GIO SANTA GIUSTA SORRADILE FORDONGIANUS TRAMATZA GONNOSNO' TRESNURAGHES PIRAS 17 VEN URAS ABBASANTA PALMAS ARBOREA NARBOLIA SIMALA BOSA-SARDU SANNA 18 SAB TERRALBA-ANNIS SEDILO- BORONEDDU ALLAI SENEGHE BARESSA- LACONI BOSA-SOLINAS S.CROCE 19 DOM ARBOREA AIDOMAGGIORE BUSACHI NURACHI SENIS BOSA-SOLINAS / MONTR./ SCANOMONT. S.CROCE 20 LUN MOGORO /SANT'ANNA ARDAULI SOLARUSSA RIOLA SARDO VILLAVERDE SUNI LODDO 21 MAR ARCIDANO NORBELLO SIMAXIS-ORTUERI BARATILI S.P. -

Luogo E Memoria Fordongianus.Pdf
Margaret Caddeo LUOGO e MEMORIA Luogo e Memoria Pubblicazione finanziata da Comune di Fordongianus - Assessorato alla Cultura Ideazione progetto Margaret Caddeo Realizzazione progetto Assessorato alla Cultura Testi Margaret Caddeo Revisione testi in lingua sarda Alessandro Martometti Curatori Pubblicazione Margaret Caddeo Realizzazione interviste Margaret Caddeo, Alessandro Martometti, Giuseppe Molinu, Pietro Frongia In copertina: Antonica Pintore Coghe (1885 - 1977) mentre fila il lino, Fordongianus, 1953. Collezione Aldo Guiso. Referenze fotografiche La foto di copertina fa parte dell’archivio fotografico del sig. Aldo Guido Guiso. Tutte le fotografie storiche all’interno del libro fanno parte della collezione privata del sig. Raffaele Oppo, ad eccezione della foto del banditore nell’anno 1934, la quale fa parte della collezione di Jacopo Moggi, la fotografia fu scattata da Lidio Cipriani. Le foto degli intervistati sono di Margaret Caddeo. Indice Premessa 5 Prefazione 7 Introduzione 9 1917 11 Giovannina Caboni 15 1919 19 Giovanni Angius 21 Cladinoro Frau 25 1923 31 Annunziata Porcu 33 1924 39 Sebastiano Meloni 41 1925 45 Pietro Dessì 47 Zohra Aouichaoui 50 Luisa Frongia 53 Mario Pischedda 59 Lussoria Demartis 65 1927 69 Michelina Uda 73 Giuseppe Ghisu 79 5 1928 83 Francesco, Giuseppa e Domenica Pistis 87 1929 93 Beniamina Serra 95 1930 99 Giovanna Maria Murgia 103 Barbara e Lussoria Pintore 111 1932 117 Maria Grazia Camedda 121 Don Palmerio Fadda 127 1934 131 Giuditta Nughes 133 Antonina Murgia 139 1949 143 Lussorio Frongia 145 Bibliografia 157 Ringraziamenti 158 6 Comenti e Amministratzioni Come Amministrazione ab- eus crèfidu a sighiri custu tri- biamo scelto di realizzare que- ballu unu ca ddu carculaus im- sto lavoro perché lo riteniamo portanti e unu ca a idea nosta non solo importante ma anche non faiat prus a ddu trantziri. -

SERVIZIO TERRITORIALE ORISTANO Ufficio Tecnico
SERVIZIO TERRITORIALE ORISTANO Ufficio Tecnico Prot. Pos. Oristano, 28 Febbraio 2019 RAS - Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio di Valutazione Ambientale Strategica Via Roma n.80 – 09123 Cagliari PEC: [email protected] RAS - Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio Tutela del Suolo e Politiche Forestali Via Roma n.80 – 09123 Cagliari PEC: [email protected] RAS - Assessorato Enti locali, Finanze e Urbanistica Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Oristano Via Arquer n.12/14 - 09170 Oristano PEC: [email protected] RAS - Assessorato Enti locali, Finanze e Urbanistica Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio per la Provincia di Oristano Via Cagliari n.238 - 09170 Oristano PEC: [email protected] Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etno-antropologici delle Province di Cagliari e Oristano Via Cesare Battisti n.2 – 09123 Cagliari PEC: [email protected] RAS - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Oristano Via Donizetti n.15/A - 09170 Oristano PEC: [email protected] RAS - Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Oristano Via Donizetti n.15/A 09170 Oristano PEC: [email protected] Provincia di Oristano Via Enrico Carboni – 09170 Oristano PEC: [email protected] Comune di Allai Via Ponte Nuovo, 3 Allai (OR) PEC: [email protected] Comune di Busachi Piazza Italia, 1, 09082 Busachi, OR PEC: [email protected] Sede legale Sede Territoriale Viale Merello, 86 - 09123 Cagliari via Cagliari sede ex ISOLA - 09170 Oristano Codice Fiscale e Partita IVA: 03669190922 loc. -

SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE Guardie Mediche
Guardia medica di Marrubiu Tel. 0783 859202 Distretto di Oristano Via Deledda, 5 Guardia medica di Cabras Tel. 0783 290585 Guardia medica di Mogoro Tel. 0783 990539 Via Tharros, 17 Via Cagliari, 29 Guardia medica di Milis Tel. 0783 51257 Guardia medica di Terralba Tel. 0783 9111528 Via G, Deledda, 2 c/o RSA Viale Sardegna Guardia medica di Narbolia Tel. 0783 57549 Guardia medica di Uras Tel. 0783 89218 Via Principe Amedeo 1 Via Marconi Guardia medica di Oristano Tel. 0783 303373 Guardia medica di Usellus Tel. 0783 938087 SERVIZIO DI CONTINUITÀ Ospedale San Martino Viale Marconi, locali campo Sportivo, Escovedu ASSISTENZIALE Guardia medica Riola Sardo Tel. 0783 410147 Guardia medica di Villa S. Antonio Tel. 0783964075 Via Petrarca 1 Via Dritta Guardie Mediche Guardia medica di Samugheo Tel. 0783 64218 Distretto di Ghilarza-Bosa Via Della Pace, 1 Guardia medica di Simaxis Tel. 0783 405201 Guardia medica di Ardauli Tel. 0783 651339 Via Brancaleone Doria, 4 Via Nuoro Guardia medica di Solarussa Tel. 0783 374046 Guardia medica di Bosa Tel. 0785 225318 Via Garibaldi, 4 Ospedale via Pischedda Guardia medica di Villaurbana Tel. 0783 44011 Guardia medica di Cuglieri Tel. 0785 39599 Via Don Minzoni 1 Via Regina Margherita 1 Guardia medica di Fordongianus Tel. 0783 60193 Distretto di Ales-Terralba Vico Traiano, 2 Guardia medica di Ales Tel. 0783 9111340 Guardia medica di Ghilarza Tel. 0785 52537 Via IV Novembre c/o Poliambulatorio Ospedale Corso Umberto, 176 Guardia medica di Arborea Tel. 0783 800555 Guardia medica di Sedilo Tel. 0785 59305 Via Sardegna, 48 Vico Marini, 1 Guardia medica di Baressa Tel.