Eroi-Giovani-Belli Fulltext.L.1.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Giorgio De Chirico and Rafaello Giolli
345 GIORGIO DE CHIRICO AND RAFFAELLO GIOLLI: PAINTER AND CRITIC IN MILAN BETWEEN THE WARS AN UNPUBLISHED STORY Lorella Giudici Giorgio de Chirico and Rafaello Giolli: “one is a painter, the other a historian”,1 Giolli had pointed out to accentuate the diference, stung to the quick by statements (“just you try”2) and by the paintings that de Chirico had shown in Milan in early 1921, “pictures […] which”, the critic declared without mincing words, “are not to our taste”.3 Te artist had brought together 26 oils and 40 drawings, including juvenilia (1908- 1915) and his latest productions, for his frst solo show set up in the three small rooms of Galleria Arte,4 the basement of an electrical goods shop that Vincenzo Bucci5 more coherently and poetically rechristened the “hypogean gallery”6 and de Chirico, in a visionary manner, defned as “little underground Eden”.7 Over and above some examples of metaphysical painting, de Chirico had shown numerous copies of renaissance and classical works, mostly done at the Ufzi during his stays in Florence: a copy from Dosso Dossi and a head of Meleager (both since lost); Michelangelo’s Holy Family (“I spent six months on it, making sure to the extent of my abilities to render the aspect of Michelangelo’s work in its colour, its clear and dry impasto, in the complicated spirit of its lines and forms”8); a female fgure, in Giolli’s words “unscrupulously cut out of a Bronzino picture”,9 and a drawing with the head of Niobe, as well as his Beloved Young Lady, 1 R. -

Sarfatti and Venturi, Two Italian Art Critics in the Threads of Modern Argentinian Art
MODERNIDADE LATINA Os Italianos e os Centros do Modernismo Latino-americano Sarfatti and Venturi, Two Italian Art Critics in the Threads of Modern Argentinian Art Cristina Rossi Introduction Margherita Sarfatti and Lionello Venturi were two Italian critics who had an important role in the Argentinian art context by mid-20th Century. Venturi was only two years younger than Sarfatti and both died in 1961. In Italy, both of them promoted groups of modern artists, even though their aesthetic poetics were divergent, such as their opinions towards the official Mussolini´s politics. Our job will seek to redraw their action within the tension of the artistic field regarding the notion proposed by Pierre Bourdieu, i.e., taking into consider- ation the complex structure as a system of relations in a permanent state of dispute1. However, this paper will not review the performance of Sarfatti and Venturi towards the cultural policies in Italy, but its proposal is to reintegrate their figures – and their aesthetical and political positions – within the interplay of forces in the Argentinian rich cultural fabric, bearing in mind the strategies that were implemented by the local agents with those who they interacted with. Sarfatti and Venturi in Mussolini´s political environment Born into a Jewish Venetian family in 1883, Margherita Grassini got married to the lawyer Cesare Sarfatti and in 1909 moved to Milan, where she started her career as an art critic. Convinced that Milan could achieve a central role in the Italian culture – together with the Jewish gallerist Lino Pesaro – in 1922 Sarfatti promoted the group Novecento. -
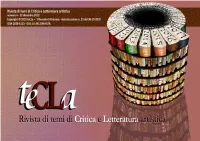
Numero6 Picello.Pdf
Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica numero 5 - 03 luglio 2012 Direttore responsabile: Giovanni La Barbera Direttore scientifico: Simonetta La Barbera Comitato Scientifico: Claire Barbillon, Franco Bernabei, Silvia Bordini, Claudia Cieri Via, Rosanna Cioffi, Maria Concetta Di Natale, Antonio Iacobini, César García Álvarez, Simonetta La Barbera, Donata Levi, François-René Martin, Emilio J. Morais Vallejo, Sophie Mouquin, Giuseppe Pucci, Massimiliano Rossi, Alessandro Rovetta, Gianni Carlo Sciolla, Philippe Sénéchal, Giuliana Tomasella. Redazione: Carmelo Bajamonte, Francesco Paolo Campione, Roberta Cinà, Nicoletta Di Bella, Roberta Priori, Roberta Santoro. Progetto grafico, editing ed elaborazione delle immagini: Nicoletta Di Bella e Roberta Priori. Università degli Studi di Palermo ISSN: 2038-6133 - DOI: 10.4413/RIVISTA Facoltà di Lettere e Filosofia Copyright © 2010 teCLa – Tribunale di Palermo – Autorizzazione n. 23 Dipartimento di Studi culturali del 06-10-2010 http://www.unipa.it/tecla Società Italiana di Storia della Critica d’Arte __________________________________________________________ © 2010 Università degli Studi di Palermo Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica numero 5 - 03 luglio 2012 4 Simonetta La Barbera L’ ‘apparire’ dell’opera d’arte 14 Diana Malignaggi Antiporte e frontespizi incisi in Sicilia dal Barocco al Neoclassico 30 Roberta Cinà «Sono ito come il cane dietro la traccia»: Paolo Giudice e la connoisseurship a Palermo nella prima metà dell’ Ottocento 40 Ivan Arlotta Charlot: eroe surrealista 58 Roberto Lai La faticosa affermazione del colore nel cinema Proprietà artistica e letteraria riservata all’Editore a norma della Legge 22 aprile 1941, n. 663. Gli articoli pubblicati impegnano unicamente la responsabilità degli autori. 74 Raffaella Picello La proprietà letteraria è riservata alla rivista. -

Italiani a Parigi
italiani a Parigi Da Severini a S a v i n i o Da De ChiriCo a CamPigli Birolli Boldini Bucci campigli de chirico de pisis levi magnelli m e n z i o m o d i g l i a n i p a r e s c e pirandello prampolini rossi savinio severini soffici Tozzi zandomeneghi ItalIanI a ParIgI D a S e v e r I n I a S AVI n IO Da De ChIrico a CaMPIGLI Bergamo, 10 - 30 maggio 2014 Palazzo Storico Credito Bergamasco Curatori Angelo Piazzoli Paola Silvia Ubiali Progetto grafico Drive Promotion Design Art Director Eleonora Valtolina Indicazioni cromatiche VERDE BLU ROSSO C100 M40 Y100 C100 M80 Y20 K40 C40 M100 Y100 PANTONE 349 PANTONE 281 PANTONE 187 R39 G105 B59 R32 G45 B80 R123 G45 B41 ItalIanI a ParIgI Da Severini a SAVINIO Da De Chirico a Campigli p r e C u r so r i e D e r e D i Opere da collezioni private Birolli, Boldini, Bucci Campigli, de Chirico de Pisis, Levi, Magnelli Menzio, Modigliani Paresce, Pirandello Prampolini, Rossi Savinio, Severini, Soffici Tozzi, Zandomeneghi 1 I g ri a P a P r e f a z I o n e SaggIo CrItICo I a n li a T I 2 P r e f a z I o n e SaggIo CrItICo 3 Italiani a Parigi: una scoperta affascinante Nelle ricognizioni compiute tra le raccolte private non abbiamo incluso invece chi si mosse dall’Italia del territorio, nell’intento di reperire le opere che soltanto per soggiorni turistici o per brevi comparse. -

Margherita Sarfatti: Una Donna Nuova Celata Dalla Storia
MARGHERITA SARFATTI: UNA DONNA NUOVA CELATA DALLA STORIA MOSTRE AL MUSEO DEL NOVECENTO A MILANO E AL MART DI ROVERETO Margherita Sarfatti donna del suo tempo, un’icona sfaccettata come appare nell’immagine simbolo della mostra che ne riassume la vita e i meriti culturali, è stata una figura che ha disegnato come imprenditrice culturale e critica d’arte nuovi ruoli per il genere femminile, proprio quando si stava delineando un sistema dell’arte moderno. Margherita vive in un momento storico caratterizzato da grandi rivolgimenti sociali e da uno sviluppo economico straordinario. Un’epoca di cambiamenti potremmo dire epocali come puo ben essere evidenziato, nei quadri degli artisti di quegli anni, dove vediamo come le innovazioni tecnologiche, dai tram agli aeroplani, trasformino il paesaggio non solo terrestre, ma anche la vista del cielo ostacolata ora anche dalle superfici estese degli edifici industriali, sempre più numerosi. Cambiano le città e i loro colori: i grigi e i marroni contrastano con il verde degli alberi, soprattutto a Milano dove vive e opera la protagonista delle due nuove mostre che si sono aperte, in questi giorni, al Museo del Novecento, nel capoluogo lombardo e al Mart di Rovereto. Esse costituiscono un’occasione per comprendere l’importanza di questa intellettuale, poco nota in rapporto al ruolo potremmo definire caleidoscopico svolto come giornalista, critica, curatrice di mostre d’arte e divulgatrice dell’arte italiana nel mondo. La sua notorieta come “l’amante del duce” l’ha condannata alla damnatio memoriae. La mostra nel capoluogo lombardo: Segni, colori e luci a Milano, curata da Anna Maria Montaldo, Danka Giacon e con la collaborazione di Antonello Negri, ha il merito di mettere in evidenza attraverso il percorso biografico della Sarfatti l’ambiente culturale dell’epoca e soprattutto fa conoscere in modo più ampio, grazie ai novanta quadri esposti, gli artisti del gruppo Novecento di cui Margherita era l’anima critica. -

Diapositiva 1
I 150 anni dell’Italia nell’arte A cura del Prof. CESARE ALPINI 1 2 Giovanni Fattore, Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta Gerolamo Induno, Garibaldi sulle alture di Sant’Angelo presso Capua Gerolamo Induno, La partenza dei coscritti nel 1866 Francesco Hayez, La Meditazione (L’Italia nel 1848) Ippolito Caffi, Bombardamento notturno a Marghera del 25 maggio 1849 Luigi Querena, Scoppio di una mina nell’isola San Giuliano Napoleone Nani, Daniele Manin e Nicolò Tommaseo liberati dal carcere e portati in trionfo in Piazza San Marco nel 1848 Giuseppe Molteni, Ritratto della marchesina Anna Pallavicina Trivulzio in abito patriottico Gerolamo Induno, Trasteverina colpita da una bomba Gerolamo Induno, Garibaldi al Vascello George Housman Thomas, Garibaldi all’assedio di Roma Pietro Bouvier, Garibaldi e il maggiore Leggero in fuga trasportano Anita morente Gerolamo Induno, La battaglia della Cernaja Gerolamo Induno, La Battaglia di Magenta Giovanni Fattori, L’assalto a Madonna della Scoperta Giovanni Fattori, La Battaglia di Montebello Angelo Inganni, Accampamento degli Zuavi sugli spalti di Brescia Angelo Trezzini, Morte di Ferdinando Cartellieri. Episodio del combattimento di San Fermo Giovanni Fattori, Soldati francesi del ‘59 Telemaco Signorini, L’artiglieria toscana a Montechiaro salutata dai francesi feriti a Solferino Silvestro Lega, Un’imboscata di bersaglieri in Lombardia Silvestro Lega, Bersaglieri che conducono prigionieri austriaci Federico Faruffini, La Battaglia di Varese Eleuterio Pagliano, La presa del cimitero di Solferino -

Italian Painting in Between the Wars at MAC USP
MODERNIDADE LATINA Os Italianos e os Centros do Modernismo Latino-americano Classicism, Realism, Avant-Garde: Italian Painting In Between The Wars At MAC USP Ana Gonçalves Magalhães This paper is an extended version of that1 presented during the seminar in April 2013 and aims to reevaluate certain points considered fundamental to the research conducted up to the moment on the highly significant collection of Italian painting from the 1920s/40s at MAC USP. First of all, we shall search to contextualize the relations between Italy and Brazil during the modernist period. Secondly, we will reassess the place Italian modern art occupied on the interna- tional scene between the wars and immediately after the World War II —when the collection in question was formed. Lastly, we will reconsider the works assem- bled by São Paulo’s first museum of modern art (which now belong to MAC USP). With this research we have taken up anew a front begun by the museum’s first director, Walter Zanini, who went on to publish the first systematic study on Brazilian art during the 1930s and 40s, in which he sought to draw out this relationship with the Italian artistic milieu. His book, published in 1993, came out at a time when Brazilian art historiography was in the middle of some important studies on modernism in Brazil and its relationship with the Italian artistic milieu, works such as Annateresa Fabris’ 1994 Futurismo Paulista, on how Futurism was received in Brazil, and Tadeu Chiarelli’s first articles on the relationship between the Italian Novecento and the São Paulo painters. -

Alberto Savinio and the "Years of Consent:" the Experience of "Colonna" (1933–34)
ITALIAN MODERN ART | ISSUE 2: Alberto Savinio ISSN 2640-8511 and the “Years of Consent:” The Experience of “Colonna” (1933–34) ALBERTO SAVINIO AND THE "YEARS OF CONSENT:" THE EXPERIENCE OF "COLONNA" (1933–34) italianmodernart.org/journal/articles/alberto-savinio-and-the-years-of-consent-the-experience- 0 of-colonna-1933-34 Lucilla Lijoi Alberto Savinio, Issue 2, July 2019 https://www.italianmodernart.org/journal/issues/alberto-savinio/----------------. - ---- Abstract This presentation considers the significant role Alberto Savinio played in the production and promotion of Italian culture during the early thirties, focusing specifically on Savinio’s founding and directing of the monthly review Colonna. Periodico di civiltà italiana. Although Colonna folded after only five issues, during its run the periodical served as a vehicle for Savinio to actively contribute to the revival of Italian culture as well as the movement around the “uomo nuovo italiano,” which was promoted by Fascism in the so-called “years of consent.” Crucial to confronting the delicate relationship of Alberto Savinio to fascism in the early thirties is the consideration of his decision to establish Colonna (figure 1), a monthly journal of art and culture that was partially in line with the cultural direction being promoted by Benito Mussolini. An important date in this history is 1933, the year in which Savinio moved to Italy with his family after several years in Paris. The Italy of the early thirties was very different from the country Savinio had left in 1926. In fact, Mussolini was pursuing the total “renovation” of the Italian people in his attempt to create “the new fascist man,” a protagonist for both the Mediterranean and Europe. -

Iê Museiê Delleê MARCHE GUIDAÊ ALLAÊ SCOPERTA
iÊ museiÊ delleÊ MARCHE GUIDAÊ ALLAÊ SCOPERTA marche musei I Musei delle Marche. Guida alla scoperta è un’iniziativa promossa da Regione Marche, Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura, Internazionalizzazzione, PF Cultura Dirigente: Raimondo Orsetti Coordinamento: Marta Paraventi Redazione: Sistemi Museali delle Province di Ancona e Macerata Bianca Giombetti e Marina Massa Il file in pdf è scaricabile da: www.turismo.marche.it www.musei.marche.it Immagini tratte dall’Archivio fotografico della Regione Marche Stampa: Arti Grafiche Stibu, Urbania COME ARRIVARE MAROTTA MONDOLFO AUTOSTRADA A 14 Bologna-Taranto www.autostrade.it STRADE SS 3 Flaminia - Roma-Fano (PU) URBANIA SS 4 Salaria - Roma-Porto d’Ascoli (AP) SS 16 Adriatica - Padova-Otranto (LE) SS 73 bis di Bocca Trabaria - San Giustino (AR)-Fano (PU) SS 76 Val d’Esino - Fossato di Vico (PG)-Falconara Alta (AN) SS 77 Val di Chienti - Foligno (PG)-Civitanova Marche (MC) ex SS 361 Septempedana - Ancona-Nocera Umbra (PG) ex SS 360 Arceviese - Senigallia (AN)-Scheggia-Pascelupo (PG) TRENO Linea Milano-Lecce: Milano, Bologna, Ancona, Lecce Linea Roma-Ancona: Roma, Falconara M., Ancona www.trenitalia.com - www.italotreno.it AUTOBUS Il sistema extraurbano di trasporto collega le Marche a 12 regioni italiane www.turismo.marche.it AEROPORTO Aereoporto delle Marche “Raffaello Sanzio” Ancona/Falconara M. Collegamenti nazionali ed internazionali www.marcheairport.com PORTO DI ANCONA Collegamenti con: Albania, Croazia, Grecia, Turchia, Montenegro www.doricaportservices.it PORTI TURISTICI -

Mexican Murals and Fascist Frescoes
Mexican Murals and Fascist Frescoes: Cultural Reinvention in 20th-Century Mexico and Italy An honors thesis for the Department of International Literary and Visual Studies Maya Sussman Tufts University, 2013 Acknowledgments I would like to thank Professor Adriana Zavala for her encouragement, guidance, and patience throughout each step of this research project. I am grateful to Professor Laura Baffoni-Licata and Professor Silvia Bottinelli for both supporting me and challenging me with their insightful feedback. I also wish to acknowledge Kaeli Deane at Mary-Anne Martin/Fine Art for inviting me to view Rivera’s Italian sketchbook, and Dean Carmen Lowe for her assistance in funding my trip to New York through the Undergraduate Research Fund. Additionally, I am grateful to the Academic Resource Center for providing supportive and informative workshops for thesis writers. Finally, I want to thank my friends and family for supporting me throughout this project and the rest of my time at Tufts. Contents Introduction................................................................................................................................... 1 Chapter 1: Diego Rivera’s Sketches from Italy: The Influence of Italian Renaissance Art on the Murals at the Ministry of Public Education and Chapingo Chapel ................................................ 7 Chapter 2: Historical Revival in Fascist Italy: Achille Funi’s Mito di Ferrara Frescoes........... 46 Chapter 3: Muralists’ Manifestos and the Writing of Diego Rivera and Achille Funi .............. -

Da Gola a Funi E Casorati. Opere Della Prima Metà Del Novecento Nelle Collezioni Del Museo Della Permanente
FLUSSI DDa Gola a Funi e ARTECasorati. Opere della prima metà del Novecento’ nelle collezioni del Museo della Permanente a cura di Elena Pontiggia Flussi d’arte Da Gola a Funi e Casorati. Opere della prima metà del Novecento nelle collezioni del Museo della Permanente “Flussi d’Arte” è un progetto promosso dalla Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente con il supporto di Gruppo CAP, che ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza e l’apprendimento dell’arte contemporanea sul territorio della Città metropolitana di Milano. Una mostra itinerante in alcuni comuni del territorio milanese, costituita da 33 opere del Museo che esplorano i movimenti artistici nati nella prima metà del Novecento italiano, sapientemente selezionate da Elena Pontiggia – riconosciuta storica dell’arte italiana – che ha scelto di portare all’attenzione di tutti coloro che avranno piacere di visitare questa esposizione, alcune “sorprese”, come lei stessa le definisce, opere spesso dimenticate dai critici e che invece hanno una vitalità espressiva ancora forte e attuale. A queste importanti opere, si aggiungono poi alcune fotografie significative – realizzate dal fotografo Lorenzo Maccotta dell’agenzia Contrasto – tratte dalla mostra celebrativa dei 90 anni di Gruppo CAP, che sono state esposte alla stessa Permanente e che rappresentano un viaggio attraverso le immagini attorno a Milano, seguendo il flusso di quello che è il suo vero elemento distintivo: l’acqua. Presidente Commissione artistica Emanuele Fiano annuale Renato Galbusera Consiglieri Giovanni Mattio Stefano Achermann Armanda Verdirame Cesare Cerea Vicepresidente Collegio dei Revisori Mirella Del Panta Rossana Arioli Pino Di Gennaro Ernesto Carella Franco Marrocco Ugo Marco Pollice Barbara Pietrasanta Presidente Consiglieri Alessandro Russo Lauretta Barat Arianna Cavicchioli Vicepresidente Giorgio Greci Karin Eva Imparato Sindaco Assessore alla Cultura Cesare Nai Beatrice Poggi Emanuele Fiano La mostra Flussi D’Arte. -

Architecture and Materials in the First Half of the 20Th Century in Italy
G. Bernardo & L. Palmero Iglesias, Int. J. of Herit. Archit., Vol. 1, No. 4 (2017) 593–607 ARCHITECTURE AND MatERIALS IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY IN ItaLY G. BERNARDO1 & L. PALMERO IGLESIAS2 1Department of European and Mediterranean Cultures, University of Basilicata, Italy. 2Department of Architectural Constructions, Technical University of Valencia, Spain. ABSTRACT The architecture and the materials used in the constructions have always been the symbol of the culture and progress of a people. Each historical period can be described in its complexity through the architectural heritage. The built environment is really an extraordinary testimony of the creativity and intelligence of humankind, of its enormous possibilities but also of its limitations as well as of a certain sensitivity and world view. This paper illustrates a multidisciplinary and historical-critical study of the main architectural trends in Italy in the first half of the 20th century: from the Futurism of the early 20th century to the rationalism of the fascist period. The work is focused on the role of the architecture in the socio-economic development of a country and on the complex relation- ship between materials innovation and architecture, which originates even today the debate between modernity and tradition. The results highlight the outstanding importance in the evolution of the different ways of conceiving architecture. It can be just a Utopia as in the Futuristic architecture, a drive towards a better world which will be able to meet the growing needs of an ever-changing world, or rise to fulfil the function of science and art through the innovative use of new materials and manufacturing technologies.