Qc.Rel Quadro Conoscitivo Relazione
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sintesi Rapporto Appennino 2019
Direzione generale Servizio Studi e Statistica Sintesi per la programmazione strategica Rapporto Appennino 2019 Analisi territoriale e sociale A cura di Maria Angiola Gallingani Marzo 2019 RapportoRapporto AppenninoAppennino 20192019 RAPPORTO APPENNINO 2019 Sintesi dei principali contenuti di analisi territoriale e sociale A cura di Maria Angiola Gallingani L’ambito oggetto di studio Al territorio dell’Appennino bolognese fanno capo 23 Comuni montani e collinari (se- condo le zone altimetriche ISTAT), 11 dei quali costituiscono l’Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese. I Comuni restanti appartengono rispettivamente al Nuovo Circondario Imolese, all’Unione Savena-Idice, all’Unione Reno-Lavino e Samoggia. Il Comune di Alto Re- no Terme non aderisce ad alcuna forma associativa. La popolazione dell’Ambito è nel 2017 di 153.737 abitanti, il 15,2 % della po- polazione metropolitana, per un territo- rio di 1.678,9 Kmq, ovvero ben il 45 % della superficie complessiva dell’intera Città metropolitana Ambiti associativi e territoriali Oltre a riferirsi agli ambiti associativi comunali, ovvero alle Unioni di Comuni e al Nuovo Circondario Imolese mostrati dalla mappa, questo lavoro fa riferimento ai seguenti ambiti territoriali sub-metropolitani: Collina Montagna : Alto Reno Terme, Borgo Tossignano, Camugnano, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Fontanelice, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Mon- ghidoro, Monterenzio, Monte San Pietro, Monzuno, Pianoro, -

I Principali Interventi Nel Bolognese a Bologna, Alto Reno Terme
I principali interventi nel bolognese A Bologna, Alto Reno Terme, Camugnano, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Vergato, Marzabotto, Monzuno, Sasso Marconi e San Benedetto con 440.500 euro sono in programma i lavori per ripristino e mantenimento di opere idrauliche nel bacino montano del fiume Reno. A Bologna, Bentivoglio, Casalecchio, Castel Maggiore, Malalbergo, Molinella, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Zola Predosa, uno stanziamento di 68mila euro garantirà l’esecuzione di rilievi e indagini finalizzati alla realizzazione di interventi idraulici, al riconfinamento e alla revisione dei confini demaniali nei sottobacini Medio Reno, Samoggia, Navile, Savena abbandonato. A Camugnano, Casola Valsenio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Monterenzio e Lizzano in Belvedere con 172.500 euro si faranno i lavori di manutenzione nei versanti in dissesto oltre all’implementazione della rete di monitoraggio geologico nel bacino del Reno. A Zola Predosa con un investimento di 300mila euro verrà co-finanziata la realizzazione della cassa di espansione torrente Ghironda. In più Comuni tra Bologne e Ravenna sono previste opere di consolidamento negli abitati dichiarati da consolidare e interventi sui versanti in dissesto nel bacino del Reno con un investimento di 768 mila euro distribuiti in due annualità. I principali interventi nel ferrarese Ad Argenta, Ferrara, Fiscaglia, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Ostellato e Tresignana si interviene con 100mila euro sugli argini del sistema Burana Volano. A Comacchio, Ferrara e in vari Comuni sono previsti interventi di manutenzione sulle opere di difesa del litorale ferrarese con un importo complessivo di 485mila euro. A Ferrara si finanziano con 150mila euro i lavori per la diaframmatura dei corsi d'acqua, interessati da infiltrazioni, del bacino del Po di Volano. -

Arte a Tole' (Vergato)
ARTE A TOLE’ (VERGATO) FATTORIA CA’ DI MONTI (SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO) *Info E Prenotazioni Via Giuseppe di Vittorio, Tolè, Vergato (BO) Via Ca’ di Monti 2, S. Benedetto Val di Sambro (BO) Attività, visite guidate e laboratori aperti a tutti fino a esaurimento SABATO 16. Visita guidata di 1 ora alla scoperta del borgo e delle sue opere: alle DOMENICA 17. Visita guidata per i bambini, con degustazione. Si parte alle 17 con posti. 10, alle 11.30 e alle 17.30. la visita all’azienda, alla stalla e alle caprette, mostrando il passaggio del latte Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria organizza- Dalle 15, spazio ai bambini dai 5 agli 8 anni, con il battesimo della sella al Ma- dalla capra al caseificio. Dopo la dimostrazione di mungitura i bimbi possono neggio Fil_ippo. Costo 3 euro. Dalle 16 alle 17.30, laboratorio di scultura e pittura dare da mangiare alle caprette. L’incontro termina alle 19 con una degustazione tiva, Laboratorio delle Idee, telefonando al numero 051 273861 (Lun / con l’artista Paolo Gualandi. Entrambe le attività si svolgono al boscoparco la di prodotti caseari. Possibilità di acquistare i formaggi nel punto vendita. Ven, 9-13 e 14–18) Birichinaia, via Pian di Ghera. Iniziativa adatta ai bambini sopra ai 5 anni. Ingresso su prenotazione* Ingresso libero su prenotazione* In caso di mobilità ridotta o esigenze particolari vi preghiamo di contattarci per confermarvi l’accessibilità ai siti di interesse. DOMENICA 17. Visita guidata di 1 ora alle opere del borgo alle 11.30 e alle 17.30. -

Comitato Regionale Onoranze Ai Caduti Di Marzabotto
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA Verbale n.ro 4 OGGETTO: Insediamento Assemblea previa verifica legittimità della propria costituzione. L’anno duemiladiciotto, addì otto del mese di Settembre alle ore 10,00 in seconda convocazione, non essendo presente il numero legale alle ore 9,00, presso la Sala Consiliare del Municipio di Marzabotto, previa l’osservanza delle formalità prescritte dall’articolo 5 dello Statuto del Comitato Onoranze, vennero oggi convocati a seduta i componenti dell’Assemblea: All’appello risultano presenti i signori: Cognome e nome Presente Cognome e nome Presente BARABINO PAOLO A.G. LUCCARINI GIANLUCA SI BORGHI ALESSANDRO SI MARCHI ANDREA SI CALZOLARI PIETRO SI MINGARELLI DARIO SI CAPPELLANO ANNA RITA NO MORINI LUCA NO CARDI VALTER SI MURACA DOMENICO SI CATTABRIGA CORRADO SI MURATORI STEFANO SI COCCHI ANNA NO NEROZZI ANDREA SI CUPPI VALENTINA SI PRETI ALBERTO SI EVANGELISTI MARTA SI SANTI CASALI RAFFAELLA SI FORNASINI CATERINA A.G. SIBANI GIANLUCA SI GHIDINI ACHILLE NO VENTURELLI DAVIDE SI IUBINI MARIA SI VERONESI MASSIMO SI Totale presenti 18 Totale assenti 6 Assume la presidenza ai sensi dell’art. 5, comma terzo, il signor Calzolari Pietro, quale membro più anziano dell’Assemblea, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l’Assemblea a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. Assiste il segretario del Comitato Onoranze signor Bruno Bertusi che provvede alla redazione del presente verbale. L’A S S E M B L E A VISTA la deliberazione dell’Assemblea n.ro -

Associazioni Di Volontariato
Associazioni di volontariato Amici dell'Antica Pieve di Roffeno Via Possessione, 82 40038 Pieve di Roffeno Vergato BO Amici dell'Appennino- Università "Primo Levi" Via Garibaldi, 5 40038 Vergato BO Associazione C-JAM P.zza della Pace, 1 40038 Vergato BO Associazione " La porta della Luna" Via Palmieri, 5 40038 Riola Vergato BO Associazione Musicae Monte Chinni 189 40038 Riola Vergato BO Associazione Fonte Chiara Via Del Montello 4 40038 Tolè Vergato BO Avventure nel mondo Via Provinciale, 89/1 40038 Cereglio Vergato BO Banda G. Verdi Via Ponte, 7 40038 Riola Grizzana Morandi BO Circ. Foto."SeiperSei" Via A. Moro 120/B 40038 Vergato BO Circolo Culturale Marescotti Casella Postale 38 40038 Vergato BO Comitato per la Ferrovia Porrettana P.zza della Pace, 4 40038 Vergato BO IndispArte P.zza Capitani della Montagna, 20 40038 Vergato BO Promozione Artisti Via Provinciale 10/3 40038 Cereglio BO Riflessi Via Del Montello 4 40038 Tolè BO Archivio Museo Cesare Mattei ONLUS Via Ponte, 72 40030 Grizzana Morandi BO VOLABO Via Legnano, 2 40038 Bologna BO Timbuctù via coste 22 Tolè Vergato BO La Violina Via dell'Angelo Custode, 66 Bologna Ass. Culturale Islamica per Orientamento Via Minghetti, 25 40038 Vergato BO Sez. AVIS Vergato Via Bacchetti 4 40038 Vergato BO CARITAS Vicariale Parrocchia P.zza Aldo Moro 1 40038 Riola Riola BO Associazione Nazionale Alpini Via Civetta-Baita 40038 Vergato BO AUSER Piazza XXV Aprile 40038 Vergato BO C.R.I. VDS Vergato Via Fornaci 343/D 40038 Vergato BO Centro Sociale Polivalente "Franco Nanni" Via Fornaci 343/H 40038 Vergato BO Ass. -

Emilia Romagna
Premi ctrl+f per cercare il tuo comune Provincia Località Zona climatica Altitudine BOLOGNA ANZOLA DELL'EMILIA E 38 ARGELATO E 25 BARICELLA E 11 BAZZANO E 93 BENTIVOGLIO E 19 BOLOGNA E 54 BORGO TOSSIGNANO E 102 BUDRIO E 26 CALDERARA DI RENO E 30 CAMUGNANO E 692 CASALECCHIO DI RENO E 61 CASALFIUMANESE E 125 CASTEL D'AIANO F 805 CASTEL DEL RIO E 215 CASTEL DI CASIO E 533 CASTEL GUELFO DI BOLOGNA E 32 CASTEL MAGGIORE E 29 CASTEL SAN PIETRO TERME E 75 CASTELLO D'ARGILE E 23 CASTELLO DI SERRAVALLE E 182 CASTENASO E 42 CASTIGLIONE DEI PEPOLI E 691 CRESPELLANO E 64 CREVALCORE E 20 DOZZA E 190 FONTANELICE E 165 GAGGIO MONTANO E 682 GALLIERA E 14 GRANAGLIONE E 493 GRANAROLO DELL'EMILIA E 28 GRIZZANA MORANDI E 547 IMOLA E 47 LIZZANO IN BELVEDERE F 640 LOIANO F 714 MALALBERGO E 12 MARZABOTTO E 130 MEDICINA E 25 MINERBIO E 16 MOLINELLA E 8 MONGHIDORO F 841 MONTE SAN PIETRO E 112 MONTERENZIO E 235 MONTEVEGLIO E 114 MONZUNO E 621 MORDANO E 21 OZZANO DELL'EMILIA E 67 PIANORO E 200 PIEVE DI CENTO E 18 PORRETTA TERME E 349 SALA BOLOGNESE E 29 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO E 602 SAN GIORGIO DI PIANO E 21 SAN GIOVANNI IN PERSICETO E 21 SAN LAZZARO DI SAVENA E 62 SAN PIETRO IN CASALE E 17 SANT'AGATA BOLOGNESE E 21 SASSO MARCONI E 128 SAVIGNO E 259 VERGATO E 193 ZOLA PREDOSA E 74 Provincia Località Zona climatica Altitudine FERRARA ARGENTA E 4 BERRA E 2 BONDENO E 11 CENTO E 15 CODIGORO E 3 COMACCHIO E 0 COPPARO E 5 FERRARA E 9 FORMIGNANA E 3 GORO E 1 JOLANDA DI SAVOIA E 1 LAGOSANTO E 0 MASI TORELLO E 3 MASSA FISCAGLIA E 2 MESOLA E 1 MIGLIARINO E 3 MIGLIARO E -
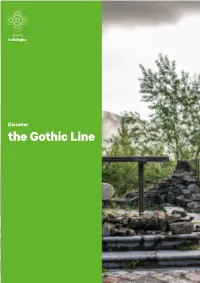
The Gothic Line
Green is Bologna Discover the Gothic Line © Martino Viviani © Martino Viviani Walking along the paths of the Gothic Line means retracing the history and the events that involved the men and women who fought in what was the last German defensive outpost during the Italian Campaign. Between October 1944 and April 1945, the Bologna Apennines were the setting of large battles between the German army and the allied forces advancing from the south of the Italian peninsula. The historic itinerary unwinds from west to east: it starts at Lake Scaffaiolo in the Corno alle Scale Regional Park and arrives in Tossignano in the Park of the Vena del Gesso Romagnolo. Milan Venice Bologna Florence Rome How to find us Bologna is easy to reach using the main means of transport. Bologna Bologna G. Marconi Airport Bologna Central Station Motorways (A1-A14) Gothic Line Trekking Lake Scaffaiolo 1st Stage: Length: 15.8 km Difference in level:+600 -1,800 Duration: 6 h Rocca Corneta 2nd Stage: Length: 14 km Difference in level:+600 -1150 Duration: 5 h Abetaia 3rd Stage: Iola Length: 15,1 km Difference in level:+500 -490 Duration: 5 h Castel d’Aiano 4th Stage: MdSpè Length: 20 km Difference in level:+750 -1,300 Duration: 7 h Vergato 5th Stage: Monte Salvaro Length: 15,6 km Difference in level:+850 -660 Duration: 6 h Monte Sole 6th Stage: Vado Length: 21 km Difference in level:+1050 -1000 Duration: 7 h Brento Livergnano 7th Stage: Monte delle Formiche Length: 16,5 km Difference in level:+1100 -1200 Duration: 6 h Monterenzio 8th Stage: Monte Cerere Length: 21 km Difference in level:+700 -800 Duration: 7 h S. -

La Fragilità Demografica, Sociale Ed Economica Nei Comuni Della Città Metropolitana Di Bologna
La fragilità demografica, sociale ed economica nei comuni della Città metropolitana di Bologna Dicembre 2018 Questo studio è stata realizzato nell’ambito di un Accordo di collaborazione istituzionale fra Città metropolitana di Bologna e Comune di Bologna in tema di statistica e ricerche demografiche, sociali ed economiche. Referente per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione: Franco Chiarini – dirigente U.I. Ufficio Comunale di Statistica del Comune di Bologna. Direttore del Servizio studi e statistica per la programmazione strategica della Città metropolitana di Bologna: Giacomo Capuzzimati. Redazione a cura di Fabrizio Dell’Atti (Ufficio di Statistica del Comune di Bologna). Hanno collaborato: Cristina Cacco ((Ufficio di Statistica del Comune di Bologna), Monica Mazzoni e Licia Nardi (Servizio studi e statistica per la programmazione strategica della Città metropolitana di Bologna). Premessa L’intento di questo studio è quello di realizzare una possibile forma di misurazione della potenziale vulnerabilità e nei territori della Città metropolitana di Bologna, utilizzando una selezione di indicatori demografici, sociali ed economici ricavati da archivi di carattere amministrativo continuamente aggiornati (in primo luogo l’anagrafe della popolazione residente e l’archivio delle dichiarazioni dei redditi), nonché dai dati del Censimento 2011. Dal punto di vista metodologico, questo lavoro prende spunto da un analogo studio realizzato già da alcuni anni dall’Area Programmazione Controlli e Statistica del Comune di Bologna sulle 90 aree statistiche della città, estendendo il metodo impiegato per il comune capoluogo ai 55 comuni della Città metropolitana di Bologna, con alcuni opportuni adattamenti. Anche a livello metropolitano, l’analisi è articolata in tre ambiti: demografico, sociale ed economico. -

Autorizzazione Alla Raccolta Del Legname Caduto Nell'alveo Dei Corsi
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE Ai Comuni di: SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO Anzola dell'Emilia, Argelato, Argenta, Bagnara di Romagna, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio IL RESPONSABILE di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel DOTT.CLAUDIO MICCOLI Guelfo, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San TIPO ANNO NUMERO Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata REG. / / Bolognese, Sasso Marconi, Vergato, Zola Predosa, Valsamoggia, Castelbolognese, Cotignola, S.Agata sul Santerno, Solarolo, Faenza, Riolo Terme, Brisighella, Massa DEL / / / Lombarda, Cento, Alto Reno Terme. SEDI e p.c.: • Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica, [email protected] • Servizio Aree Protette Foreste e Svil. Mont., [email protected] • Agenzia Regionale Protezione Civile , SEDE • Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale: [email protected] Inviato tramite PEC • Unione Comuni -

Episodio Di Pian Di Venola, Marzabotto, 23-25.06.1944 Operazione Di Rastrellamento a Monte San Pietro, Marzabotto, Savigno
Episodio di Pian di Venola, Marzabotto, 23-25.06.1944 Operazione di rastrellamento a Monte San Pietro, Marzabotto, Savigno Nome del compilatore: Massimo Turchi I.STORIA Località Comune Provincia Regione Pian di Venola Marzabotto Bologna Emilia Romagna Data iniziale: 23 giugno 1944 Data finale: 25 giugno 1944 Vittime: Totale U Bam Ragaz Adult Anzia s.i. D. Bambi Ragazze Adult Anzian S. Ig bini zi (12- i (17- ni (più ne (0- (12-16) e (17- e (più i n (0- 16) 55) 55) 11) 55) 55) 11) 5 5 3 2 Di cui Civili Partigiani Renitenti Disertori Carabinieri Militari inermi Sbandati inermi 4 Prigionieri di Antifascisti Sacerdoti e religiosi Ebrei Legati a partigiani guerra 1 Elenco dei nomi Pedretti 23/06/194 Marzabo 1872 Luminasio Custode Alessandro (1) 4 tto 06/08/19 24/06/194 Marzabo Marzabo Pian di Benini Armando Colono 17 4 tto tto Venola 26/03/18 24/06/194 Marzabo Pian di Benini Giovanni Vergato Colono 81 4 tto Venola 29/08/18 24/06/194 Marzabo Pian di Grilli Tommaso (2) Pianoro Colono 97 4 tto Venola 22/06/19 24/06/194 Marzabo Pian di Raimondi Alberto Savigno Colono 04 4 tto Venola Altre note sulle vittime: (1) Muore di crepacuore per l'arrivo dei tedeschi. Viene ricordato da Zanani. (2) Grilli viene riconosciuto partigiano della Brigata "Stella Rossa" dal 6 marzo 1944 nel "Dizionario Biografico online" curato da Albertazzi, Arbizzani e Onofri, e nell'"Elenco nominativo dei partigiani" progetto coordinato da Casali e Preti. Grilli è padre di due figli partigiani della "Stella Rossa". -

COMUNE DI VERGATO Città Metropolitana Di Bologna Area “Servizi Per La Collettività E Il Territorio” - U
COMUNE DI VERGATO Città Metropolitana di Bologna Area “Servizi per la Collettività e il Territorio” - U. O. “Urbanistica, Edilizia, Ambiente E Patrimonio” Sportello Unico per l’Edilizia Prot. n. 5613.2016 Vergato (Bo), 28.04.2016 Prot. rif. n. 4566.2016 PAS n. 02.2016 Unione Comuni dell’Appennino Bolognese Area Territorio – Servizi Tecnici Territoriali - Ufficio Sismica Piazza della Pace n. 4 40038 Vergato (Bo) [email protected] Unione Comuni dell’Appennino Bolognese Area Territorio – Servizi Tecnici Territoriali – Vincolo idrogeologico Piazza della Pace n. 4 40038 Vergato (Bo) [email protected] Città Metropolitana di Bologna Unità operativa amministrativa espropri Via Zamboni n. 13 40126 Bologna (Bo) [email protected] Agenzia regionale per la prevenzione, l´ambiente e l´energia dell´Emilia Romagna Sezione provinciale di Bologna Via B. Triachini n. 17 40138 Bologna (Bo) [email protected] Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna AUSL Bologna Dipartimento sanità pubblica Via del Seminario n. 1 40068 San Lazzaro di Savena (Bo) [email protected] Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio Province di Bologna Modena e Reggio Emilia Via IV Novembre n. 5 40125 Bologna (Bo) [email protected] Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le comunicazioni Ispettorato territoriale Emilia Romagna Via Nazario Sauro n. 20 40121 Bologna (Bo) [email protected] Piazza Capitani della Montagna n. 1 – 40038 Vergato (Bo) Tel. 051.6746708 Fax. 051.912034 pec: [email protected] mail: [email protected] Responsabile dell’ Unità Operativa: Arch. -

Curriculum Vitae
CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome LEONARDI FRANCA Data di nascita 23/05/1954 Qualifica Segretario comunale Amministrazione COMUNE DI MARZABOTTO Incarico attuale Staff - SEGRETERIA CONVEZIONATA COMUNI DI MARZABOTTO E VERGATO Numero telefonico 0516780520 dell’ufficio Fax dell’ufficio 051931350 E-mail istituzionale [email protected] TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE Titolo di studio LAUREA IN SCIENZE POLITICHE Altri titoli di studio e - professionali NULLA Esperienze professionali - (incarichi ricoperti) SEGRETARIO COMUNALE A SEGUITO NECESSITA', DELLA LOCALE PREFETTURA, RELATIVE AL POST-TERREMOTO (76) E RICOSTRUZIONE DEL FRIULI. - COMUNE DI LAUCO - SEGRETARIO COMUNALE FUORI RUOLO - COMUNE DI MARZABOTTO - SEGRETARIO COMUNALE FUORI RUOLO FINO AL 31/05/1982 - SEGRETARIO COMUNALE IN RUOLO DAL 01/06/1982 - COMUNE DI GRIZZANA MORANDI - SEGRETARI COMUNALE CAPO - COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO - SEGRETARIO COMUNALE CAPO; INCARICHI ULTERIORI AFFIDATI DAL SINDACO: DIRETTORE GENERALE (FINO TERMINE MANDATO 06/99) E PER PERIODI DEFINITI RESPONSABILE DI AREE: AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, FINANZIARI, CULTURA E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - COMUNE DI MONZUNO - SEGRETARIO COMUNALE CAPO FINO AL 24/10/99; SEGRETARIO GENERALE SEGRETERIA CONVENZIONATA MARZABOTTO/MOLINELLA FINO AL 13/09/2004; SEGRETARIO GENERALE SEGRETERIA MARZABOTTO DAL 14/09/2004 AL 03/12/2004; 1 CURRICULUM VITAE SEGRETARIO GENERALE SEGRETERIA CONVENZIONATA MARZABOTTO/VERGATO DAL 04/12/2004 A TUTT'OGGI. - COMUNE DI MARZABOTTO Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto Inglese Scolastico Scolastico PORTOGHESE Scolastico Scolastico Capacità nell’uso delle tecnologie Altro (partecipazione a - convegni e seminari, IL TOTALE DELLA RETRIBUZIONE LORDA, DI CUI AL pubblicazioni, PROSPETTO CHE SEGUE, E' RIPARTITO AL 50% TRA I collaborazione a riviste, COMUNI DI MARZABOTTO (capofila) E VERGATO.