Giorgio Strehler E L'opera Lirica. Problemi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
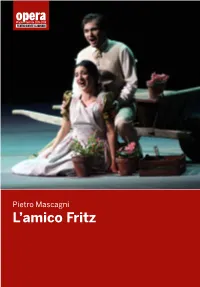
L'amico Fritz
opera Stagione teatrale 2015-2016 TEATRO DANTE ALIGHIERI Pietro Mascagni L’amico Fritz Fondazione Ravenna Manifestazioni Comune di Ravenna Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Regione Emilia Romagna Teatro di Tradizione Dante Alighieri Stagione d’Opera e Danza 2015-2016 L’amico Fritz commedia lirica in tre atti di P. Suardon musica di Pietro Mascagni Teatro Alighieri 9, 10 gennaio con il contributo di partner Sommario La locandina ................................................................ pag. 5 Il libretto ....................................................................... pag. 6 Il soggetto .................................................................... pag. 23 L’amico Fritz, seconda opera di Mascagni di Fulvio Venturi ........................................................ pag. 25 Guida all’ascolto di Sara Dieci ................................................................ pag. 31 I protagonisti ............................................................. pag. 33 Coordinamento editoriale Cristina Ghirardini GraficaUfficio Edizioni Fondazione Ravenna Manifestazioni Si ringrazia il Teatro Municipale di Piacenza per aver concesso il materiale editoriale. Foto © Gianni Cravedi L’editore si rende disponibile per gli eventuali aventi diritto sul materiale utilizzato. Stampa Edizioni Moderna, Ravenna L’amico Fritz commedia lirica in tre atti dal romanzo omonimo di Erckmann-Chatrian musica di Pietro Mascagni libretto di P. Suardon (Nicola Daspuro) Casa Musicale Sonzogno personaggi e interpreti Suzel -

Saxelovnebo Mecnierebata Ziebani #3 (68), 2016 ART SCIENCE
saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universiteti Shota Rustaveli Theatre and Film Georgian State University saxelovnebo mecnierebaTa Ziebani #3 (68), 2016 ART SCIENCE STUDIES gamomcemloba `kentavri~ Tbilisi _ 2016 UDC(uak) 7(051.2) s-364 saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universiteti saxelovnebo mecnierebaTa Ziebani #3 (68), 2016 saredaqcio sabWo krebulisaTvis mowodebuli qeTevan trapaiZe masala uzrunvelyofili unda marina iyos Sesabamisi samecniero xaratiSvili aparatiT. Tan unda axldes monacemebi avtoris samecniero maka vasaZe kvalifikaciis Sesaxeb qarTul da inglisur enebze, agreTve literaturuli naSromis inglisurenovani redaqtorebi reziume. mariam iaSvili marika krebulis stamburi gamocema mamacaSvili egzavneba sxvadasxva saerTaSoriso kvleviT centrs. dakabadoneba naSromebi mogvawodeT da ekaterine cnobebisaTvis mogvmarTeT: oqropiriZe 0102, Tbilisi, daviT aRmaSeneblis gamziri #40, saqarTvelos SoTa inglisuri teqstis rusTavelis Teatrisa da kinos redaqtori: saxelmwifo universiteti, mariam II korpusi. sxirtlaZe tel/faqsi: +995 (32) 2943728 gamomcemlobis mob: +995 (77) 288 762 +995 (77) 288 750 xelmZRvaneli E-mail: [email protected] maka vasaZe Web: www.tafu.edu.ge Shota Rustaveli Theatre and Film Georgian State University Art Science Studies #3 (68), 2016 Editorial Group Materials supplied for the KETEVAN volume should be provided TRAPAIDZE with corresponding scientific MARINA appliance. Paperwork concerning KHARATISHVILI author~s academic qualification MAKA VASADZE and summary of work should -

Memoria Académica Santander 2013
1 SANTANDER 2013 MEMORIA 1 2 Junio/septiembre CURSOS AVANZADOS Cursos magistrales El autor y su obra Escuelas Seminarios Cursos postgrado Talleres Encuentros Aulas de Verano «Ortega y Gasset» Cursos de Formación de Profesores de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional 3 ÍNDICE PROGRAMA CRONOLÓGICO ................ 5 ÍNDICE TEMÁTICO ............................. 349 ÍNDICE ALFABÉTICO .......................... 355 ESTADÍSTICA ..................................... 372 4 PROGRAMA CRONOLÓGICO Los Cursos señalados con (*) están acreditados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para profesores de enseñanzas no universitarias. A efectos de reconocimiento de los Cursos de la UIMP como créditos universitarios de libre elección, consúltese antes del comienzo del curso en la Secretaría de Alumnos. 5 6 7 CURSO MAGISTRAL DEL 17 AL 21 DE JUNIO 5 DÍAS, 5 PELÍCULAS. EL VESTUARIO DE ESPECTÁCULO Y EL TRABAJO DEL FIGURINISTA. ¿CUÁL ES SU IMPORTANCIA EN LA NARRATIVA VISUAL? PACO DELGADO DISEÑADOR DE VESTUARIO PROFESORES: 1 ALUMNOS: 11 LUNES 17 manera: 10:00 h. LECCIÓN 1ª 1- El guion Presentación 2- Las influencias visuales y las conversaciones con el Trayectoria personal ¿Por qué diseño vestuario para director cine? 3- El material sobre la película 4- Visualización de la película y/o del material 11:00 h. LECCIÓN 2ª audiovisual correspondiente. Planteamiento: 5 dÍas, 5 pelÍculas ¿Por qué esta idea? 5- Conversación posterior, preguntas y respuestas 6- Conclusión 12:00 h. LECCIÓN 3ª Este curso trata de abordar, reflexionar y arrojar luz La Comunidad de Alex De La Iglesia, la 1º película que sobre las preguntas planteadas en el título respecto al realizo como diseñador de vestuario. La comedia vestuario de espectáculo, ¿qué es? ¿Cuál es su paródica cometido? y sobre el trabajo del figurinista ¿en qué consiste? ¿Cuál es su importancia en la narrativa visual? 15:30 h. -
CENTRAL PAVILION, GIARDINI DELLA BIENNALE 29.08 — 8.12.2020 La Biennale Di Venezia La Biennale Di Venezia President Presents Roberto Cicutto
LE MUSE INQUIETE WHEN LA BIENNALE DI VENEZIA MEETS HISTORY CENTRAL PAVILION, GIARDINI DELLA BIENNALE 29.08 — 8.12.2020 La Biennale di Venezia La Biennale di Venezia President presents Roberto Cicutto Board The Disquieted Muses. Luigi Brugnaro Vicepresidente When La Biennale di Venezia Meets History Claudia Ferrazzi Luca Zaia Auditors’ Committee Jair Lorenco Presidente Stefania Bortoletti Anna Maria Como in collaboration with Director General Istituto Luce-Cinecittà e Rai Teche Andrea Del Mercato and with AAMOD-Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico Archivio Centrale dello Stato Archivio Ugo Mulas Bianconero Archivio Cameraphoto Epoche Fondazione Modena Arti Visive Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea IVESER Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea LIMA Amsterdam Peggy Guggenheim Collection Tate Modern THE DISQUIETED MUSES… The title of the exhibition The Disquieted Muses. When La Biennale di Venezia Meets History does not just convey the content that visitors to the Central Pavilion in the Giardini della Biennale will encounter, but also a vision. Disquiet serves as a driving force behind research, which requires dialogue to verify its theories and needs history to absorb knowledge. This is what La Biennale does and will continue to do as it seeks to reinforce a methodology that creates even stronger bonds between its own disciplines. There are six Muses at the Biennale: Art, Architecture, Cinema, Theatre, Music and Dance, given a voice through the great events that fill Venice and the world every year. There are the places that serve as venues for all of La Biennale’s activities: the Giardini, the Arsenale, the Palazzo del Cinema and other cinemas on the Lido, the theatres, the city of Venice itself. -

Ein Sommernachtstraum 047 3.1
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES 1 DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Ich feg den Staub aus dieser Welt“ – Jürgen Gosch inszeniert Shakespeare Verfasser Andreas Knabl angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2010 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 317 Studienrichtung lt. Studienblatt: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Michael Gissenwehrer 2 3 Inhaltsverzeichnis Danksagung 005 1. Einleitung 007 2. WAS IHR WOLLT 011 2.1. Raum und Bühne 013 2.1.1. Der Schauplatz „Illyrien“ 013 2.1.2. The first Night of Twelfth Night? 014 2.1.3. Pralinenschachtel hochkant – Illyrien nach Schütz 016 Spiegel, Musik und Melancholie 017 Einflüsse aus der Bildenden Kunst I: Cy Twombly 020 Neue Räume: Pausenumbau und Malvolios Verlies 022 2.2. Kostüm und Maske 025 2.2.1. Kostüm und sozialer Status 025 2.2.2. Zwillinge auf der Bühne 027 2.2.3. Malvolios gelbe Strümpfe 029 2.3. Schlüsselszenen 032 2.3.1. Die Exposition – „Paint it, black!” 032 2.3.2. Violas stürmische Überfahrt 037 2.4. Figurenanalyse 040 2.4.1. Feste, der Clown 041 2.4.2. Feste, der Schauspieler 043 2.4.3. Feste, der Sänger 045 3. EIN SOMMERNACHTSTRAUM 047 3.1. Raum und Bühne 049 3.1.1. Biographischer Exkurs I: Jürgen Gosch und der Sommernachtstraum 049 3.1.2. Biographischer Exkurs II: Max Reinhardt und der Sommernachtstraum 051 3.1.3. Stadt, Land, Wald – Die Berliner Schütz-Welt 054 Der Hof des Theseus 056 Die Welt der Handwerker 061 Der Wald von Athen 062 3.2. -

L'arte Di Fare Teatro Fra Intuizione E Ragione
GIORGIO STREHLER ..................................................................................................................................................................................................................... L’arte di fare teatro fra intuizione e ragione testi di Alberto Bentoglio, Marco Blaser e Claudio Magris introduzione di Rita Levi Montalcini L’arte di fare teatro fra intuizione e ragione ..................................................................................................................................................................................................................... «Il teatro è l’attiva riflessione dell’uomo su se stesso»: una riflessione questa che un mae- stro, un regista quale Giorgio Strehler ha saputo conciliare al meglio con la sua vita. È riuscito, infatti, a contrapporre la vita alla scena, dove tutte le libertà sono possibili. La sua imponente produzione artistica è la testimonianza di una crescita culturale che vede unito il teatro italiano a quello della scena europea. La sua attività di cinquanta anni lo ha visto impegnato alla direzione del “Piccolo” di Milano da lui fondato nel 1947 con Paolo Grassi. Strehler è riuscito a sviluppare un lavoro teatrale legato al realismo poetico attraverso le opere di grandi autori, quali Shakespeare, Goldoni, Pirandello, Brecht, Bertolazzi, Cechov. Ha percorso non sol- tanto la strada del teatro con l’apporto di regista anche all’opera lirica, ma la sua conoscenza della musica ha fatto eccellere la sua “abilità” nell’aver saputo “svecchia- re” le arretrate tradizioni teatrali creando l’epifania di un metodo teatrale del tutto nuovo, offrendo agli spettatori di ogni estrazione sociale la proiezione di un calei- doscopio fantastico del mondo dell’arte, della poesia e della musica. Parole e musica hanno diretto la vita di A pagina I: Ritratto di Giorgio Giorgio Strehler così come egli stesso ha Strehler nel 1974. diretto la musica e il teatro. A sinistra: Una scena del Faust. -
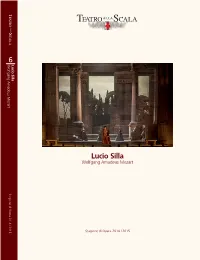
Lucio Silla Wolfgang Amadeus Mozart S T a G I O N E D I O P E R a 2 0 1 4 / 2 0 1
6 W L u o c l i f o g a S n i l g l a A m a d e u s M o z a r t Lucio Silla Wolfgang Amadeus Mozart S t a g i o n e d i O p e r a 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Stagione di Opera 2014 / 2015 Lucio Silla Dramma in musica in tre atti Libretto di Giovanni De Gamerra Musica di Wolfgang Amadeus Mozart Nuova produzione In coproduzione con Mozartwoche Salzburg/Fondazione Mozarteum e Festival di Salisburgo EDIZIONI DEL TEATRO ALLA SCALA TEATRO ALLA SCALA PRIMA RAPPRESENTAZIONE Giovedì 26 febbraio 2015, ore 20 - Turno E REPLICHE febbraio Sabato 28 Ore 20 – Turno D marzo Martedì 3 Ore 20 – ScalAperta Giovedì 12 Ore 20 – Turno B Sabato 14 Ore 20 – Turno A Martedì 17 Ore 20 – Turno C SOMMARIO 4 Lucio Silla . Il libretto 28 Il soggetto Argument – Synopsis – Die Handlung – ࠶ࡽࡍࡌ – Сюжет Cesare Fertonani 40 L’opera in breve Cesare Fertonani 42 La musica Giancarlo Landini 45 Luci del crepuscolo Il Lucio Silla di Mozart per Milano Raffaele Mellace 79 Modernità in veste storica Marc Minkowski parla di Mozart e di Lucio Silla 85 Wolfgang A. Mozart - Lucio Silla Ronny Dietrich 104 Lucio Silla alla Scala Luca Chierici 113 Marc Minkowski 115 Marshall Pynkoski 116 Antoine Fontaine 117 Jeannette Lajeunesse Zingg 118 Hervé Gary 119 Lucio Silla . I personaggi e gli interpreti 121 Wolfgang Amadeus Mozart. Cesare Fertonani Cronologia della vita e delle opere 128 Letture Cesare Fertonani 130 Ascolti Luigi Bellingardi 133 Coro del Teatro alla Scala 134 Orchestra del Teatro alla Scala 135 Corpo di Ballo del Teatro alla Scala 136 Teatro alla Scala Wolfgang Amadeus Mozart . -

Il Piccolo Teatro Di Milano E L'esperienza Del Decentramento
Il PIccolo TeaTro dI MIlano e l’esPerIenza del decenTraMenTo TeaTrale (1968-1972) Il Piccolo, teatro brechtiano, non può parlare di «arte del teatro», ma di «lavoro teatrale» e, quindi, non può indicare una via di democratizzazione che non sia una via che guardi a tutti indistintamente i lavoratori. Paolo Grassi, 13 settembre 1968 a bstract – after Giorgio strehler’s leaving from the Piccolo Teatro di Milano, Paolo Grassi was appointed with the role of main director of the theatre (1968-1972). during these four years – dramatically complex from a social point of view – he launched various initiatives, marking a deep change in the cultural policy of the Piccolo Teatro. The most relevant initiative is considered to be the so-called “decentramento” (delo- calization) bringing the cultural offer of the theatre not only in Milan but also toward the Province of Milan and, further, the whole regione lombardia. The Piccolo Teatro productions were brought out of the theatre’s house and shown in unusual places, thus reaching a huge and completely new kind of audience. This initiative reached extraor- dinary outcomes. Though, when Grassi became managing director of la scala, strehler took his role back at the Piccolo but he broke up with that kind of cultural policy. He preferred to give the role of high quality “teatro d’arte” to the Piccolo Teatro. c ’è un periodo nella storia del Piccolo Teatro di Milano guardato spes- so con diffidenza da coloro che si sono occupati delle vicende artisti- che e organizzative del primo teatro stabile pubblico italiano. si tratta di un arco di tempo, in realtà assai breve, che va dal luglio 1968, quando Giorgio strehler lasciò il Piccolo per trasferirsi a roma, all’aprile 1972, quando Paolo Grassi lasciò il Piccolo per dedicarsi alla scala e strehler vi fece ritorno in veste di direttore unico. -

Quartino.Rai.Pdf
Per informazioni: Servizio Infotel Scala +39.02.72.003.744 (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18) www.teatroallascala.org Grandi opere sul grande schermo Cinque spettacoli storici in proiezione gratuita alla Scala 18 giugno – 22 ottobre 2017 Main Media Partner o n a s i m A - a i c s e r B o t o F Grandi opere sul grande schermo Domenica 10 settembre 2017, ore 11 i l l e Dal 18 giugno al 22 ottobre la Rai e il Teatro alla Scala celebrano 40 anni Europa riconosciuta L o t di Antonio Salieri o di collaborazione proiettando in sala i video di cinque grandi spettacoli diretti F da Carlos Kleiber, Claudio Abbado, Riccardo Muti, Daniel Barenboim e Riccardo Chailly. Direttore Riccardo Muti Regia Luca Ronconi Il 7 dicembre 1976 le telecamere della Rai facevano entrare per la prima volta gli italiani L’opera con cui il Teatro alla Scala fu inaugurato nel 1778 è stata scelta da Riccardo Muti per celebrare alla Prima della Scala trasmettendo l’ Otello di Verdi con la direzione di Carlos Kleiber. anche il ritorno all’attività dopo il restauro nel dicembre Da allora la Rai e il Teatro alla Scala hanno collaborato per far conoscere sempre meglio 2004. Per l’occasione erano tornati a collaborare Luca agli italiani lo straordinario patrimonio del melodramma. Ronconi e Pier Luigi Pizzi, mentre in scena si sfidavano In occasione del 40° anniversario di questa prima, folgorante diretta in mondovisione le voci di Diana Damrau e Desirée Rancatore. la Prima è tornata su Rai1 e la Madama Butterfly inaugurale della Stagione 2016/2017 Ritiro biglietti gratuiti da lunedì 4 settembre diretta dal Maestro Riccardo Chailly ha battuto tutti i record di ascolti per l’opera lirica sulla televisione italiana. -

La Biblioteca Di Alessandria Di Alfredo Pizzo Greco Alla Biblioteca Sormani
Settore Biblioteche Servizio Biblioteca Centrale CASA MUSEO ALFREDO PIZZO GRECO La Biblioteca di Alessandria di Alfredo Pizzo Greco alla Biblioteca Sormani In occasione delle celebrazioni dei 60 anni nella sede di Palazzo Sormani, la Biblioteca Centrale propone ai lettori un’opera d’arte che rievoca un archetipo bimillenario, custode di uno dei più antichi tesori del sapere umano. La Biblioteca di Alessandria di Alfredo Pizzo Greco si compone di 2063 volumi tra libri combusti e libri rossi, realizzati dal 1922 al 2013, e sarà allestita nella sala Cataloghi al primo piano con progetto dell’Architetto Rosmary Pirotta. L’opera sarà inaugurata domenica 13 marzo alle ore 17.00 e sarà visitabile fino al 4 giugno 2016 . Così l’artista motiva la sua poetica ed esprime l’energia che si effonde dalla sua opera: Corso di Porta Vittoria, 6 – 20122 Milano tel. +39 02 88463372 – fax +39 02 88463616 www.comune.milano.it/biblioteche La Biblioteca di Alessandria di Alfredo Pizzo Greco Biblioteca Sormani 13 marzo-4 giugno 2016 “Qui si consuma il tempo nella polvere degli eventi, ove non si custodisce l’incubo dei percorsi ma bensì l’affascinante culla della bellezza, dell’energia vitale e vitalizzante da liberare nel presente … e ciò, è per chi lo voglia e per chi necessita di scoprire la passione nel “segno e nel “simbolo” dell’umanità tutta!” I libri sono stati realizzati con il fuoco, con il colore acrilico, con la pece bruna, legati dalla juta, sigillati con cera lacca ed esaltati dalle foglie dell’oro. L’opera li espone nella condizione intonsa, come classificati dall’artista, per lasciare inviolata la loro traccia emotiva attraverso la forza cromatica del colore rosso lacca, dell’odore di fumo e del colore opacizzante della polvere che incide il segno del suo tempo. -

Teatro Dal Verme
SIRBeC scheda ARL - MI220-00097 Teatro Dal Verme Milano (MI) Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI220-00097/ Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI220-00097/ SIRBeC scheda ARL - MI220-00097 CODICI Unità operativa: MI220 Numero scheda: 97 Codice scheda: MI220-00097 Visibilità scheda: 3 Utilizzo scheda per diffusione: 03 Tipo scheda: A Livello ricerca: P CODICE UNIVOCO Codice regione: 03 Numero catalogo generale: 00101584 Ente schedatore: S26 Ente competente: S26 Data del sopralluogo: 2011 OGGETTO OGGETTO Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi Definizione tipologica: teatro Denominazione: Teatro Dal Verme Fonte della denominazione: bibliografia Specifica della fonte della denominazione: Bibliografica "Milano nell'arte e nella storia" LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA Stato: Italia Regione: Lombardia Provincia: MI Nome provincia: Milano Codice ISTAT comune: 015146 Pagina 2/11 SIRBeC scheda ARL - MI220-00097 Comune: Milano CAP: 20121 Indirizzo: Via San Giovanni sul Muro Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 3]: Affaccio: secondario Indirizzo: Largo Maria Callas Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 3]: Affaccio: secondario Indirizzo: Foro Buonaparte Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [3 / 3]: Affaccio: secondario Indirizzo: Via Giacomo Puccini CENTRO STORICO Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale ZONA URBANA Denominazione: -

È Un Piacere E Un Onore Poter Rappresentare E Presentare Milano Al Mondo
È un piacere e un onore poter rappresentare e presentare Milano al mondo. Milano e la sua storia millenaria; Milano e la sua cultura, le sue eccellenze scientifiche; Milano e la sua vocazione al nuovo, i sui progetti, il suo spirito internazionale. Milano è una città che unisce le sue antiche tradizioni con una sensibilità contemporanea. Il Museo del Novecento che sta nascendo dalla trasformazione del Palazzo dell’Arengario, nel cuore di Milano, rappresenta questo spirito milanese: sarà la sede dei capolavori italiani che sono patrimonio di Milano, di opere d’arte del Futurismo che il mondo ci ammira e che troveranno un luogo magico dove essere esposti e ammirati. Milano fu capitale dell’Impero Romano d’Occidente: le testimonianze di queste antiche radici sono conservate nel Museo Archeologico del Castello Sforzesco e nel Parco Archeologico. Milano è l’antica Mediolanum: un luogo di mezzo, un ponte tra culture, un centro di scambi commerciali, sociali, culturali. Tale è rimasta per sempre: nel Medioevoe poi soprattutto nel Rinascimento,quando Ludovico il Moro chiamò alla corte milaneseLeonardo Da Vinci ed egli fece di Milano il suo laboratorio di idee, producendo capolavori d’arte come il Cenacolo 1 Vinciano e opere di ingegneria idraulica come i Navigli. Milano è una capitale mondiale della cultura. Il Castello Sforzesco è con il Duomo il monumento simbolo di Milano. Vi è custodito un tesoro inestimabile:la Pietà Rondanini, l'ultima opera scolpita da Michelangelo, un capolavoro incompiuto, dove proprio il "non finito" rappresentail culmine dell'espressione drammatica del genio michelangiolesco. Tutto questo si integra con la Milano di oggi, centro culturale internazionale.