Annali 2003-2004.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
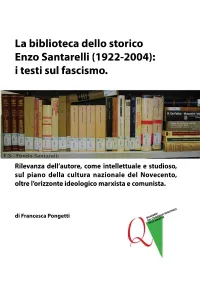
La Biblioteca Dello Storico Enzo Santarelli (1922-2004): I Testi Sul Fascismo
La biblioteca dello storico Enzo Santarelli (1922-2004): i testi sul fascismo. Rilevanza dell’autore, come intellettuale e studioso, sul piano della cultura nazionale del Novecento, oltre l’orizzonte ideologico marxista e comunista. di Francesca Pongetti Si ringrazia per la collaborazione: Fabrizio Manizza Nora Santarelli Nessuna parte di questa pubblicazione può essere memorizzata, fotocopiata o co- munque riprodotta senza le dovute autorizzazioni 5 PRESENTAZIONE Il Fondo Santarelli è un lascito librario costituito da oltre 5.000 vo- lumi, pervenuto alla Regione Marche in seguito ad un atto di dona- zione del possessore dei libri, il professor Enzo Santarelli, che ha così deciso di destinare ad una pubblica istituzione una parte importante della sua biblioteca privata. Nel 2001, a 79 anni di età e sofferente per una grave malattia, Santa- relli stipula con la Regione Marche una convenzione nella quale, oltre a disporre la donazione del patrimonio librario, frutto di una intera vita di studi e di insegnamento, indica in modo esplicito la destina- zione d’uso del patrimonio stesso: secondo la volontà del prof. San- tarelli, i libri dovranno essere messi a disposizione di tutti i cittadini e utilizzati in particolare per iniziative indirizzate ai giovani. Come è noto, Santarelli ha tenuto la cattedra di Storia contempora- nea all’Università degli Studi di Urbino, a partire dal 1964 fino al rag- giungimento dei limiti di età, e il Fondo Santarelli è lo specchio fedele della sua personalità di studioso e intellettuale dai molteplici inte- ressi. Ma non è soltanto questo, è anche qualche cosa di più: attra- verso la donazione del patrimonio librario, Santarelli ha testimoniato un’ultima volta la sua caratteristica concezione del ruolo dell’intellet- tuale e dell’uomo di cultura nella società, portatore di una specifica “missione” di civilizzazione ed educazione collettiva. -

Documento Scaricato Dal Sito Mininterno.Net - Il Portale Per La Preparazione Ai Concorsi Pubblici - Esercitati GRATIS On-Line! N
N. Domanda A B C D 1 Dove si trova il Darfur, regione in cui Somalia Uganda Sudan Eritrea nel 2003 è iniziato un drammatico conflitto? 2 A quale partito è appartenuto Oscar Partito Repubblicano Partito Socialista Partito Democratico Democrazia Cristiana Luigi Scalfaro? 3 Quale dei seguenti politici italiani è Gianni Letta Raffaele Fitto Graziano Delrio Filippo Patroni Griffi stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei governi Berlusconi? 4 Il 6/1/1980 venne ucciso dalla mafia Presidente della Presidente della Segretario della Sindaco di Palermo Piersanti Mattarella: quale carica Commissione Regione Siciliana Democrazia Cristiana ricopriva? antimafia 5 Alla storia recente di quale paese è Messico Bolivia Venezuela Colombia legata principalmente la figura di Hugo Chavez? 6 Alla storia recente di quale paese è Bielorussia Georgia Russia Ucraina legata principalmente la figura di Julija Tymosenko? 7 Quale incarico ha ricoperto Emma Ministro per gli affari Ministro degli esteri Vicepresidente del Ministro per i rapporti Bonino nel governo Letta europei Consiglio col Parlamento (2013-2014)? 8 Alla storia recente di quale paese è Costa Rica Messico Cuba Venezuela legata principalmente la figura del "subcomandante Marcos"? 9 Nel 2012 è sorta fra Italia e India una La MCS Melody La Exxon Valdez L'Enrica Lexie La Sirius Star controversia internazionale in merito all'arresto di due marò italiani imbarcati, come nuclei militari di protezione, a bordo di quale nave? 10 Quale carica ha ricoperto Yanis Ministro delle finanze -

Delpaese E Le Forze Armate
L’ITALIA 1945-1955 LA RICOSTRUZIONE DEL PAESE STATO MAGGIORE DELLA DIFESA UFFICIO STORICO E LE Commissione E LE FORZE ARMATE Italiana Storia Militare MINISTERO DELLA DIFESA CONGRESSOCONGRESSO DIDI STUDISTUDI STORICISTORICI INTERNAZIONALIINTERNAZIONALI CISM - Sapienza Università di Roma ROMA, 20-21 NOVEMBRE 2012 Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) Palazzo Salviati ATTI DEL CONGRESSO PROPRIETÀ LETTERARIA tutti i diritti riservati: Vietata anche la riproduzione parziale senza autorizzazione © 2014 • Ministero della Difesa Ufficio Storico dello SMD Salita S. Nicola da Tolentino, 1/B - Roma [email protected] A cura di: Dott. Piero Crociani Dott.ssa Ada Fichera Dott. Paolo Formiconi Hanno contribuito alla realizzazione del Congresso di studi storici internazionali CISM Ten. Col. Cosimo SCHINAIA Capo Sezione Documentazione Storica e Coordinamento dell’Ufficio Storico dello SMD Ten. Col. Fabrizio RIZZI Capo Sezione Archivio Storico dell’Ufficio Storico dello SMD CF. Fabio SERRA Addetto alla Sezione Documentazione Storica e Coordinamento dell’Ufficio Storico dello SMD 1° Mar. Giuseppe TRINCHESE Capo Segreteria dell’Ufficio Storico dello SMD Mar. Ca. Francesco D’AURIA Addetto alla Sezione Archivio Storico dell’Ufficio Storico dello SMD Mar. Ca. Giovanni BOMBA Addetto alla Sezione Documentazione Storica e Coordinamento dell’Ufficio Storico dello SMD ISBN: 978-88-98185-09-2 3 Presentazione Col. Matteo PAESANO1 Italia 1945-1955 la ricostruzione del Paese el 1945 il Paese è un cumulo di macerie con una bassissima produzione industriale -

Liste Dal Catalogo Di Biblioteca: Politica Estera Italiana / Subject Lists
Liste dal catalogo di biblioteca – maggio 2021 Istituto Affari Internazionali – Biblioteca / Library Subject lists from Library catalogue – May 2021 Politica estera italiana / Italian foreign policy LISTE DAL CATALOGO DI BIBLIOTECA SUBJECT LISTS FROM LIBRARY CATALOGUE maggio 2021 May 2021 Politica estera italiana Italian foreign policy 2nd international conference on the Mediterranean region on the subject "Security, stability and cooperation in the Mediterranean Region" / proceedings elaborated by Lorena Di Placido, Maria Egizia Gattamorta. - Roma : Centro militare di studi strategici, 2008. - 170 p. Pubbl. in: Osservatorio strategico, suppl. al n. 3 (marzo 2008) PM 1377 Il 18 aprile 1948 nella storia d'Italia : un contributo all'unità europea : bibliografia e riflessioni / [a cura di Giampaolo Malgeri e Maria Benedetta Francesconi ; saggio di Agostino Giovagnoli]. - Roma : Associazione popolo parlamento istituzioni, 1998. - 94 p. Bibliogr.: p.72-88. - Pubbl. come: Bollettino dell'Associazione popolo parlamento istituzioni, a.1., n.2 (settembre-dicembre 1998) DO 1286 150 anni di Unità d'Italia: aspetti istituzionali / Dipartimento di Scienze politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. - Milano : EDUCatt, 2011. - 213 p. - (Quaderni del Dipartimento di Scienze politiche Università Cattolica del Sacro Cuore ; 2/2011). - ISBN 978-88-8311-879-1 Contiene anche gli atti del convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore il 10 maggio 2011 Testo online: http://www.educatt.it/libri/ebooks/A-00000314%20QDSP02_2011.pdf O 2608 1990 : il nuovo quadro mondiale / Istituto affari internazionali. - Roma : Istituto affari internazionali, 1989. - 28p. - (Documenti Iai ; 8929) IAI 1989 1992 : la crisi doppia. - Roma : Istituto affari internazionali, 1992. - 32 p. - (Documenti Iai ; 9238) Sul front.: Rapporto dell'Istituto affari internazionali in occasione della presentazione del XIX volume dell'annuario L'Italia nella politica internazionale : Progetto Rondinini, Roma 15 dicembre 1992. -

Storia Contemporanea 1922-1943 LO STATO FASCISTA 25 Luglio 1943
Dipartimento di Scienze umane e sociali CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE a.a. 2018-2019 Storia contemporanea 1922-1943 LO STATO FASCISTA 25 luglio 1943 • Il re revoca dell’incarico di governo a Mussolini • arresto e confino Cronologia: IL REGIME FASCISTA / 1 LA FASE STATUTARIA 1922, ottobre: dopo la intrapresa, ma non completata ‘marcia su Roma’, Mussolini ottiene dal re l’incarico a formare il governo › governo Mussolini I, con pieni poteri su bilancio e amministrazione 1923: legge elettorale ‘Acerbo’ con premio di maggioranza alla lista che ottenga almeno il 25% dei voti 1924: elezioni, denuncia di Matteotti, assassinio di Matteotti / riconferma di Mussolini al governo LA COSTRUZIONE DELLA MONARCHIA FASCISTA 1925, gennaio: Mussolini chiude affare Matteotti e procede al introdurre ordinamenti dittatoriali 1925-1926 LEGGI FASCISTISSIME 1928 Nuova legge elettorale plebiscitaria: Lista unica 1929 Trasformazione del Gran Consiglio del Fascismo in organo costituzionale Patti Lateranensi 1936 Proclamazione dell’Impero, dopo la conquista dell’Etiopia Cronologia: IL REGIME FASCISTA / 2 FASE INVOLUTIVA E CRISI 1937 Mussolini si proclama ‘duce del fascismo’ 1938-39 LEGGI RAZZIALI 1939 Abolizione della Camera dei Deputati, sostituita da una Camera dei Fasci e delle Corporazioni non elettiva 1940, 10 giugno: l’Italia entra in GUERRA 1943, 9 luglio: sbarco in Sicilia degli angloamericani › inizia l’occupazione 1943, 25 luglio: il Gran Consiglio del Fascismo propone al re la destituzione di Mussolini; il re revoca l’incarico a Mussolini, -

The Interjurisdictional Migration of European Authors of Liberty, 1660 – 1961: a Quantitative Analysis1
1 January 12, 2016 THE INTERJURISDICTIONAL MIGRATION OF EUROPEAN AUTHORS OF LIBERTY, 1660 – 1961: A QUANTITATIVE ANALYSIS1 Niklas Potrafke2 Roland Vaubel3 Abstract Hume, Montesquieu and Kant were the first to suggest that the rise of liberty in Europe and the West has been due to political fragmentation and competition among rulers because the creative elites had the option of leaving the country in response to political repression. In this paper we estimate the extent to which emigrating authors of liberty actually reacted to such political and economic factors. We distinguish four types of repressive political events: restoration of an authoritarian monarchy, suppression of liberal protests, takeover by a totalitarian regime and occupation by a foreign repressive power. We test for additional explanations of emigration. Our sample of well-known authors of liberty includes 401 persons from twenty European countries in 1660 to 1961. Our logistic regressions yield the following main results. The repressive events did have significant and large effects on emigration with lags of up to five years. Emigration was also influenced by the author’s occupation and interjurisdictional income differentials. The probability of emigration was larger if the author was of middle age and lived in a small country but these effects were numerically small. The decision to emigrate was not affected by the author’s education. JEL classifications: F22, N33, Z18 _______________ 1 Acknowledgements: The authors thank Daniel Mannfeld, Felix Weber, Georg Arndt and Justina Fischer for tabulating the data and Justina Fischer and Jonathan Seiler for retrieving some of the data. We received helpful comments from Dennis Snower, David Stadelmann, Bengt-Arne Wickström and the participants of the World Public Choice Society Meetings 2012, the Silvaplana Workshop on Political Economy 2013, the CESifo Political Economy Workshop 2013 and two anonymous referees. -

Elezione Del Presidente Della Repubblica
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Indice ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA La Costituzione della Repubblica Italiana: norme che riguardano l’elezione del Presidente della Repubblica ..............pag. 5 Elezione dei delegati delle Regioni per l’elezione del Presidente della Repubblica ...........................................................................................pag. 13 Elenco delle legislature della Repubblica Italiana .......................................pag. 15 Dati sintetici delle elezioni del Presidente della Repubblica .......................pag. 16 I Presidenti della Repubblica – scrutinii ed elezioni - Enrico DE NICOLA...........................................................................pag. 19 - Luigi EINAUDI .................................................................................pag. 21 - Giovanni GRONCHI..........................................................................pag. 24 - Antonio SEGNI..................................................................................pag. 27 - Giuseppe SARAGAT.........................................................................pag. 32 - Giovanni LEONE...............................................................................pag. 43 - Sandro PERTINI ................................................................................pag. 54 - Francesco COSSIGA .........................................................................pag. 64 - Oscar Luigi SCALFARO...................................................................pag. 66 -

Introduzione
Introduzione Il primo profilo che incontriamo in questo libro è quello di Silvio Pellico (Saluzzo, Cuneo, 25 giugno 1789 - Torino, 31 gennaio 1854), e Vittorio Badini Confalonieri lo traccia a partire da un’importante let- tera inedita a Giulietta di Barolo del 17 aprile 1837 che trascrive e pubblica nell’ottobre 1954, in occasione del centenario della morte dello scrittore. Quarantenne deputato liberale del collegio Cuneo-A- sti-Alessandria (era a nato a Torino, il 14 marzo 1914), da settembre sottosegretario agli Affari esteri nel governo Scelba (incarico che manterrà anche nel successivo governo Segni, fino al maggio 1957), Badini Confalonieri sottolinea in queste pagine la « coerente fedeltà » di Pellico « all’idea liberale » e allo stesso tempo la sua profonda reli- giosità. Cita una lettera al Boglino, in cui lo scrittore afferma che « I princípi anche più giusti in sé medesimi diventano iniqui per i loro effetti, allorché sono professati da anime violente, superbe, vendicati- ve . No, il progresso sociale non verrà mai dalle fazioni irate, impa- zienti e calunniatrici; verrà con le virtù domestiche e con la carità civile oppure non verrà in nessun tempo », per insistere sull’impor- tanza appunto della “carità”, di un « generoso amore verso Dio e ver- so gli uomini », sulla capacità di perdonare anche i propri « nemici e torturatori ». Non era passato molto tempo da quando lo stesso Badi- ni aveva perdonato, permettendone la riabilitazione, il responsabile della prigionia e delle torture subite nei primi mesi del 1945 nella fa- migerata caserma di via Asti, a Torino. In conclusione, il giovane sottosegretario rivolge abilmente a Pellico le parole che lo scrittore aveva dedicato a Pietro Maroncelli: « Un grande amore per la giu- stizia, una grande tolleranza, una grande fiducia nelle virtù umane e negli aiuti della Provvidenza, un sentimento vivissimo del bello in tutte le arti, una fantasia ricca di poesia », dicendo che tale « è la defi- nizione che a lui meglio si addice e che lo rende e lo renderà sempre a noi caro, all’Italia esemplarmente prezioso ». -

Annali 2000.Pdf
ANNALI del CENTRO PANNUNZIO TORINO Anno XXXI - 2000 Mario Soldati 1906 - 1999 ANNALI del CENTRO PANNUNZIO CENTRO PANNUNZIO TORINO 2000 SOMMARIO p. 9 Considerazioni per il 2000 11 Mario Soldati, la verità della bugia di Giorgio Calcagno 16 Intervento commemorativo di Mario Soldati di Ugo Perone 19 Il Tocqueville di Pannunzio di Luigi Compagna 23 Vittorio Alfieri: un classico che ci legge? di Arnaldo Di Benedetto 29 Morale laica e morale cristiana di Francesco Barone 41 Due lettere a Benedetto Croce di Massimo Mila 45 Aldo Garosci di Pier Franco Quaglieni 50 Prezzolini e il superamento del fascismo e dell’antifascismo di Augusto del Noce 71 Il Centro Pannunzio: più di trent’anni al servizio della cultura di Giancarlo Borri 78 L’attività culturale 87 L’impegno per i «Beni Culturali» e le principali iniziative del Centro 91 Per la scuola 94 I «Premi Pannunzio» 96 Inchieste e sondaggi d’opinione 101 Iniziative varie (Concorsi, Mostre, Pubblicazioni, Attività socio-aggregativa) 108 Il Centro Pannunzio: Un progetto di cultura libera, laica, pluralista 111 Da Pannunzio al Centro Pannunzio di Giovanni Spadolini 116 Intervista a Luciano Gallino su Adriano Olivetti a quarant’anni dalla morte di Federica Giuliani e Manuela Maranzani 122 Intervista a Mario Rigoni Stern: «Sono un piccolo “Mario” che vive in montagna» di Paolo Fossati 125 Intervista a Valerio Riva su “Oro di Mosca” di Giuseppe Luciano 132 Intervista a Carlo Nordio sulla Giustizia di Elisabetta Buzzano e Federico Roncon 136 In difesa del Liceo Europeo 138 Appello del Centro Pannunzio per la difesa del Liceo Europeo 7 140 Intervista al Professor Mario Perrini, preside del Liceo Scientifico Statale Galileo Ferraris di Torino (a cura di Fulvio Gambotto) 143 Intevista al Professor Daniele Straniero, preside del Liceo Classico Statale Parini di Milano (a cura di Fulvio Gambotto) 145 Il Firpo minore di P. -

Iconographies in the Public Sphere. Fiction Devices in the Representation of Power», Barcelona, 2019
Vol. VI Núm 11 ISSN: 2014-8933 Vol.2018 VII comparative cinema No. 12 2019 of power the representation in devices Fiction the publicsphere. in Iconographies Editors Albert Elduque (University of Reading, United Kingdom), Núria Gómez Gabriel (Universitat Pompeu Fabra, Spain) and Gonzalo de Lucas (Universitat Pompeu Fabra, Spain). Associate Editors Núria Bou (Universitat Pompeu Fabra, Spain) and Xavier Pérez (Universitat Pompeu Fabra, Spain). Advisory Board Dudley Andrew (Yale University, United States), Jordi Balló (Universitat Pompeu Fabra, Spain), Raymond Bellour (Université Sorbonne-Paris III, France), Francisco Javier Benavente (Universitat Pompeu Fabra, Spain), Nicole Brenez (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, France), Maeve Connolly (Dun Laoghaire Institut of Art, Design and Technology, Irleland), Thomas Elsaesser (University of Amsterdam, Netherlands), Gino Frezza (Università de Salerno, Italy), Chris Fujiwara (Edinburgh International Film Festival, United Kingdom), Jane Gaines (Columbia University, United States), Haden Guest (Harvard University, United States), Tom Gunning (University of Chicago, United States), John MacKay (Yale University, United States), Adrian Martin (Monash University, Australia), Cezar Migliorin (Universidade Federal Fluminense, Brazil), Alejandro Montiel (Universitat de València, Spain), Meaghan Morris (University of Sidney, Australia and Lignan University, Hong Kong), Raffaele Pinto (Universitat de Barcelona, Spain), Ivan Pintor (Universitat Pompeu Fabra, Spain), Àngel Quintana (Universitat de Girona, -

I GOVERNI ITALIANI ( 25 Luglio 1943 - 6 Agosto 1970)
Settembre- Ottobre 1970 756. Governi 1943-1970 I GOVERNI ITALIANI ( 25 luglio 1943 - 6 agosto 1970) DALLA CADUTA DEL FASCISMO ALLA ASSEMBLEA COSTITUENTE 0 I• MINISTERO BADOGLIO (25 Luglio 1943 - 17 aprile 1944) ( ) Pr esid. Consiglio: PIETRO BADOGLIO - Affari Ester i: RAFFAELE GUA RIGLIA - PIETRO BADOGLIO - Interno: UMBERTO RICCI - VITO R.EALE - Africa italiana: MELCHIADE GABBA - PIETRO BADOGLIO - Giustizia: GAETANO AZZARITI - ETTORE CASATI - F inanze: DOMENI CO BARTOLINI - GUIDO JUNG - Guerra: ANTONIO SORICE - TADDEO ORLANDO -Marina: RAFFAELE DE COURTEN -Aeronautica: RENATO SANDALLI - Educazione Nazionale: LEONARDO SEVERI - GIOVANNI CUOMO - Lavori Pubblici: ANTONIO ROMANO- RAFFAELE DE CARO - Agricoltura e Foreste: ALESSANDRO BRIZI - FALCONE LUCIFERO - Co mtmicazioni: FEDERICO AMOROSO - TOMMASO SICILIANI - I ndustr ia, Commercio e Lavoro: LEOPOLDO PICCARDI - EPICARMO CORBINO - Cultura popolare: CARLO GALLI - GIOVANNI CUOMO - Scambi e Valute: GIOVANNI ACANFORA- GUIDO JUNG - Produzione bellica: CARLO FA V AGROSSA - Alto commissario per la Sardegna: PINNA - Alto commissa rio per la Sicilia: FRANCESCO MUSOTTO - Alto commissario per l'epum zlone nazionale: TITO ZANffiONI - Commissario generale per l'alimenta zione: CAMll;RA. n• MINISTERO BADOGLIO (22 aprile 1944 - 18 giugno 1944) P·resid. Consiglio: PIETRO BADOGLIO - Ministri senza portafoglio: BE NEDETTO CROCE, CARLO SFORZA, GIULIO RODINO, PIETRO MANCI NI, PALMIRO TOGLIATTI - Esteri: PIETRO BADOGLIO - Interno: SAL VATORE ALDISIO • Africa italiana: PIETRO BADOGLIO - Giustizia : VINCENZO ARAN·GIO-RUIZ - Finanze: QUINTO QUINTIERI - Guer ra : TADDEO ORLANDO - Marina: RAFFAELE DE COURTEN - Aeronautica: RENATO SANDALLI - Pubblica Istruzione: ADOLFO OMODEO - Lavori Pubblici: ALBERTO TARCHIANI - Agricoltura e Foreste: FAUSTO GUL LO - Comunicazioni: FRANCESCO CERABONA - I ndustria e Commercio: ATTILIO DI NAPOLI - ALto commissario per le sanzioni contro iL fasci smo: CARLO SFORZA - Alto commissario per l'assistenza morale e mate riale dei profughi di guerra: TITO ZANIBONI. -

Italy's Post-War Culture and Its Fascist Past
An entirely new land? Italy’s post-war culture and its fascist past Article Accepted Version Leavitt IV, C. L. (2016) An entirely new land? Italy’s post-war culture and its fascist past. Journal of Modern Italian Studies, 21 (1). pp. 4-18. ISSN 1354-571X doi: https://doi.org/10.1080/1354571X.2016.1112060 Available at http://centaur.reading.ac.uk/45857/ It is advisable to refer to the publisher’s version if you intend to cite from the work. See Guidance on citing . To link to this article DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1354571X.2016.1112060 Publisher: Taylor and Francis All outputs in CentAUR are protected by Intellectual Property Rights law, including copyright law. Copyright and IPR is retained by the creators or other copyright holders. Terms and conditions for use of this material are defined in the End User Agreement . www.reading.ac.uk/centaur CentAUR Central Archive at the University of Reading Reading’s research outputs online ‘An Entirely New land’? Italy’s Post-War Culture and its Fascist Past Charles L. Leavitt IV, University of Reading Abstract: Scholarship has for decades emphasised the significant continuities in Italian culture and society after Fascism, calling into question the rhetoric of post-war renewal. This essay proposes a reassessment of that rhetoric through the analysis of five key metaphors with which Italian intellectuals represented national recovery after 1945: parenthesis, disease, flood, childhood, and discovery. While the current critical consensus would lead us to expect a cultural conversation characterised by repression and evasion, an analysis of these five post-war metaphors instead reveals both a penetrating re-assessment of Italian culture after Fascism and an earnest adherence to the cause of national re-vitalisation.