PIEMONTE E VALLE D AOSTA 5 Maggio 2019
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Percorsi Archeologici
Percorsi archeologici Durata: 3 giorni / 2 notti (a richiesta possono essere ampliati a 4/5 giorni o ridotti a 2 giorni) Periodo di validità: ottobre-maggio (sconto del 5% per soggiorni entro il 28 febbraio) Descrizione del soggiorno: 1. 1° giorno In mattinata arrivo a Torino, ritrovo con la guida e visita del centro storico con un rapido cenno ai principali monumenti (solo esterni): la Mole Antonelliana simbolo della città, Palazzo Reale, piazza Castello, piazza San Carlo, i portici di via Roma e di via Po. Pranzo. Nel pomeriggio visita del Museo Egizio, secondo al mondo per importanza dei reperti esposti. Rientro in hotel e cena. 2. 2° giorno Partenza per la Valle di Susa e visita ai resti romani e medievali di Susa: l’arco di Augusto, l’anfiteatro, la porta romana, la cattedrale di San Giusto. Pranzo. Nel pomeriggio visita della Sacra di San Michele, monumento simbolo della Regione Piemonte fatta costruire sulla cima del monte Pirchiriano. Rientro in hotel e cena. 3. 3° giorno In mattinata visita dei resti archeologici di Torino e del Museo di Antichità. Pranzo. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione e partenza per la città di origine. Le serate del 1° e del 2° giorno saranno animate con giochi di tipo archeologico e suddivisione del gruppo in squadre con assegnazione dei ruoli per le giornate successive. Sistemazione: Hotel 3* a Torino o prima cintura, in camere multiple (da riconfermare secondo disponibilità) Trattamento: pensione completa con bevande incluse (dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno) Prezzo a persona: a partire da € 158,00, minimo 20 studenti (1 gratuità in doppia ogni 25 studenti paganti) – suppl. -

The Thyroid in Art
THE THYROID IN ART Luigi Massimino SENA Clinical Pathology Faculty of Medicine University of Turin (Italy) 1 TAKE ART AND PUT IT IN SCIENCE Art and science are different aspects of human creativity. Over the centuries, artists have made use of the expressive power of images to awaken both emotions and empathy, which are often universal. 2 The thyroid gland (tireos, oblong "shield" , but which in reality meant big stone used as a door or for shutting the wooden door: cover, defend with the shield) is located in a part of the human body, i.e., in the neck, making it clearly visible in the throat when enlarged (goiter from Latin guttur). The prevalence of goiter was already known in ancient times, but the writings that described it were almost always devoid of explanatory drawings. The representation of the goiter is illustrated in the numerous depictions of goitrous men, women and children in coins, sculptures, paintings, simple craft objects and even in forms of folklore that involved persons not engaged in the medical art. The depictions were the works of artists living in endemic areas, or of travelers who illustrated the reality they encountered. The size of the goiter has always provoked amazement or fear, feelings that are associated with the mystery surrounding its origin and function. Over the centuries, it has stimulated the imagination of people, while at the same time it has paved the way to understanding the historical relationship between disease and society (pathocoenosis). 3 PATHOCOENOSIS In 1969, Mirko Drazen Grmek (1924-2000) created the neologism pathocenose or pathocoenosis , that is a “community of diseases”: “the collection of pathological states present in a given population in a certain time and space”. -

Exhibitions Food&Wine
APRIL 2016 TORINO METROPOLI 18/09/2015 - 26/09/2016 NOT TO BE MISSED EXHIBITIONS IN THE GREAT MUSEUMS 18/09/2015-22/05/2016 Torino and the Great War - Museo Nazionale del Risorgimento Italiano; 27/01-01/05 At the crime scene. The image’s 05/03 - 04/09 evidence from the Shroud to the drones - Camera Centro Italiano per THE NILE AT POMPEI. la Fotografia; 04/02-29/08 Hecho en Cuba. The cinema in the Cuban VISIONS OF EGYPT IN THE ROMAN WORLD graphic - Museo Nazionale del Cinema; 19/02-05/06 Sprites, cupids, The exhibition focuses on the meeting of two cultures, Egyptian genies and cherubs. Allegories and decoration of putti from the and Roman-Hellenistic, starting from Alexandria through to the Baroque to Neoclassic - Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto; Pompei’s homes and places of worship. 27/02-10/04 Olympic Museum. The passion relives; 18/03-05/06 Museo Egizio, Via Accademia delle Scienze 6 Simply. Rural family; 15/04-11/09 A prince on the cover. Lous Amadeus T. (+39) 011.4406903 - www.museoegizio.it of Savoy, Duke of Abruzzi - Museo Nazionale della Montagna; 07/03- 10/04 Aesop, Phaedrus & C. The classic fairy tales among art and 11/03 - 04/07 children’s books - MUSLI Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia; FROM POUSSIN TO THE IMPRESSIONISTS. 09/03-19/06 Botto&Bruno. Society, you’re a crazy breed - Fondazione THREE CENTURIES OF FRENCH Merz; 10/03-26/06 Florence Henri. Photographs and paintings 1920- 1960; 10/03-26/06 Renato Birolli. -
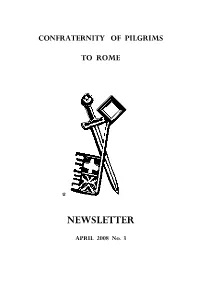
April Newsletter Issue 3
CONFRATERNITY OF PILGRIMS TO ROME * NEWSLETTER APRIL 2008 No. 3 Contents 1 Editorial Alison Raju Chris George 2 “A Pilgrim’s Tale” in the footsteps of Sigeric, Archbishop of Canterbury Veronica O’Connor 10 The Seven Pilgrim Churches of Rome Almis Simans 18 Who was St. Maurice? Janet Skinner 20 Medieval Itineraries to Rome Peter Robins 28 Rome for the modern pilgrim: traces of Peter and Paul Howard Nelson 36 Michael Alberto Alberti 38 Reviews William Marques Alison Raju 42 Additions to the CPR Library Howard Nelson 45 Secretary's Notebook Confraternity of Pilgrims to Rome Founded November 2006 www.pilgrimstorome.org Chairman William Marques [email protected] Webmaster Ann Milner [email protected] Treasurer Alison Payne [email protected] Newsletter Alison Raju [email protected] Chris George [email protected] Secretary Bronwen Marques bronwyn.marques2hertscc.gov.uk Company Secretary Ian Brodrick [email protected] AIVF Liason Joe Patterson [email protected] Editorial This is the third issue of the Confraternity of Pilgrims to Rome's Newsletter. We started on a modest scale to begin with - two issues a year, June and December, in 2007 - but in 2008 we plan three: April, August and December. Eventually we hope to make it a quarterly publication. There are six articles, four book reviews, a listing of new additions to the CPR library and the section entitled “Secretary's Notebook,” containing short items of information likely to be of interest to our members. Veronica O’Connor has written an account of her experiences on her pilgrimage from Canterbury to Rome in 2002, after which Almis Simans tells us about the Seven Pilgrim Churches in Rome. -

VIAGGIO in PIEMONTE Dal 25 Settembre Al 09 Ottobre 2021
VIAGGIO IN PIEMONTE Dal 25 Settembre al 09 Ottobre 2021 Monti, laghi, castelli, dimore storiche, edifici religiosi, fortezze… tutto questo e molto altro ancora fa parte del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del Piemonte, regione ricca di tantissimi luoghi da scoprire e ammirare. Oltre ovviamente alla città di Torino con i suoi musei, le sue piazze, gli edifici storici e gli appuntamenti culturali, la regione piemontese offre tante altre attrazioni disseminate su tutto il territorio che meritano senza dubbio di essere viste almeno una volta. 1° giorno: 25 settembre 2021 Pallanza (Lago Maggiore) Ritrovo dei partecipanti presso l’area di sosta camper di Pallanza, nel tardo pomeriggio. Riunione pre- viaggio e pernottamento. 2° giorno: 26 settembre 2021 Pallanza – Villa Taranto – Stresa (escursione in barca all’Isola Bella) - Orta San Giulio km 40 In mattinata raggiungiamo Villa Taranto, una vera e propria opera d’arte con migliaia di piante e fiori provenienti da ogni parte del mondo. Ingresso e visita guidata. A seguire raggiungiamo Stresa dove ci imbarchiamo per un’escursione di 2 ore circa sul Lago Maggiore che permetterà di visitare l’Isola Bella. Ingresso al Palazzo Borromeo. Per la notte ci spostiamo a Orta San Giulio in campeggio, sulle sponde dell'omonimo lago. Pernottamento. 3°giorno: 27 settembre 2021 Orta San Giulio – Novara - Vercelli km 70 Mattinata dedicata alla visita del piccolo borgo, che possiede un patrimonio storico, artistico e naturale di grande eccellenza, una delle mete turistiche molto gettonate. In pochi minuti di navigazione raggiungiamo l’isola di San Giulio, un piccolo gioiello. Visitiamo la chiesa di San Giulio. -

Scaricano Et Assicurano Lo Stato Di Milano È L’Istrumento Della Ruina Et Disperatione Di Quelli Di V
COLLANA DELLA SOCIETÀ DI STUDI VALDESI 20 Volumi disponibili nella Collana della Società di Studi Valdesi: 10. AA.VV., Il glorioso rimpatrio dei Valdesi. Storia - contesto - significato 11. Dall’Europa alle Valli valdesi. Atti del Convegno «Il Glorioso Rimpatrio, 1689-1989». A cura di A. de Lange 12. Giorgio ROCHAT , Regime fascista e chiese evangeliche. Di- rettive e articolazioni del controllo e della repressione 13. Marie BONNET , Tradizioni orali delle Valli valdesi del Pie monte. A cura di A. Genre 14. Giorgio SPINI , Studi sull’evangelismo italiano tra otto e nove- cento 15. Giuseppe LA SCA L A , Diario di guerra di un cappellano meto- dista durante la prima guerra mondiale, a cura di G. Vicentini (esaurito) 16. AA.VV., Dalle Valli all’Italia. 1848 - 1998. I Valdesi nel Risorgimento 17. Una resistenza spirituale. «Conscientia» 1922-1927. A cura di D. Dalmas e A. Strumia 18. La Bibbia, la coccarda e il tricolore. I valdesi fra due Eman- cipazioni (1798-1848). A cura di G.P. Romagnani 19. Emanuele Fiume, Scipione Lentolo (1525-1599). «Quotidie laborans evangelii causa» COLLANA DELLA SOCIETÀ DI STUDI VALDESI - 20 L’ANNESSIONE SABAUDA DEL MARCHESATO DI SALUZZO TRA DISSIDENZA RELIGIOSA E ORTODOSSIA CATTOLICA secc. XVI-XVIII Atti del XLI Convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi in Italia (Torre Pellice - Saluzzo 1-2 settembre 2001) a cura di Marco Fratini con 20 illustrazioni fuori testo CLAUDIANA - TORINO Marco Fratini, nato a Torino nel 1971, è storico dell’arte. Impiegato presso la Fondazione Centro Culturale Valdese in qualità di conservatore del Museo valdese di Torre Pellice, è membro del Seggio della Società di Studi Valdesi, redattore del “Bollettino della Società di Studi Valdesi” e de “La beidana”, collabora con varie riviste storiche e si occupa di storia dell’arte piemontese, storia valdese e cartografia storica. -

Torino E Dintorni
Torino e dintorni dal 25/05/15 al 03/06/15 Equipaggio: Manuele, 53 anni, autista, addetto alla logistica, ai problemi tecnici, fotografo ed editor dei diari (il Braccio). Valentina, 48 anni, navigatrice, cuoca, donna delle pulizie, organizzatrice viaggi e redattrice diari (la Mente). Isotta, 15 anni, piccola meticcia terribile Tom, 13 anni, grande meticcio fifone Mezzo: Rino, Semintegrale Adria Adriatik Coral ds 640 del 2004 Percorso: Km = 1325,10 Gasolio: € = 125,00 Soste: € = 55,00 Ingressi: € = 140,00 Altro: € = 250,00 Lunedì 25 maggio Questa volta ci siamo finalmente decisi ad organizzare questa visita alla città di Torino e ai suoi musei e monumenti. Città che non avevamo mai visto, ma visita che continuavamo a rimandare soprattutto a causa della mia scarsa predisposizione alla frequentazione delle città “grandi” in questa fase della mia vita. Abbiamo “approfittato” della debolezza di uno degli amici di famiglia, in questo caso Tom, che non essendo più in grado di camminare a lungo, è ormai costretto a restare sul camper, in compagnia dell'altra pelosa. Quindi, non potendo portarceli in giro, occasione per fare scorpacciata di musei! Come sempre, studio il territorio circostante alla ricerca di siti interessanti e fisso la prima tappa all'Abbazia romanica di Vezzolano. Attenzione, perché nonostante quello che si trova scritto su Internet, l'Abbazia è chiusa di lunedì. Perciò, al nostro arrivo, dopo un bel po' di strada stretta (ma non impossibile) fra boschi e paesini, non ci resta che ammirarla da fuori. Ma il pomeriggio è bello, il clima mite, la luce splendida e quindi decidiamo di restare a dormire lì, sul vasto piazzale gratis, perché io non voglio andarmene senza averla vista anche all'interno. -

20° Sister City Anniversary
1998 – 2018 20° SISTER CITY ANNIVERSARY COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO PROGRAM OF THE VISIT Thursday April 19th 2.00 pm : Arrival at the Tourin airport. 4.30 pm : Welcome Drink in City Hall. 8:00 pm : Dinner at Pizzeria Restaurant (Italian Pizza) Friday April 20th - Visit by bus of Langhe Hills (All Day) https://www.youtube.com/watch?v=7ASVKXT8EkM - Lunch in tipical Langhe Restaurant. - Visit of different vinery with tasting of wine. - Dinner in Borgogno Vinery ( Francesco Borgogno is been also in Duncanville in the past visit) Saturday April 21th - Visit of Sacra di San Michele This monument is a symbol of Piedmont Region and a place that inspired the writer Umberto Eco to conceive the best-seller “Il nome della rosa” ( The name of the rose ) , the Sacra of San Michele is an ancient abbey built between 983 and 987 on the top of mount Pirchiriano, 40 km from Turin . From it’s towers you can admire Turin and a breathtaking view of the Val di Susa . Inside the main Church of the Sacra, dating from the twelfth century, are buried members of House of Savoy (one of the oldest royal family in the world). Dedicated to the cult of the Archangel Michele , defender of the Christian people, the Sacra di San Michele fits inside a ruote of pilgrimage (long over 2000 km) wich runs from Saint-Michel ( France ) to Monte Sant’Angelo (Puglia). - Lunch near the next site of visit - Visit of La Venaria Reale La Venaria Reale is a grandiose estate just outside Turin. In comprises 80,000 square meters of floor surface in the Reggia and 60 hectares of Gardens, adjacent to the 17th century ancient village of Venaria and the 3,000 fenced hectares of the Park of La Mandria. -
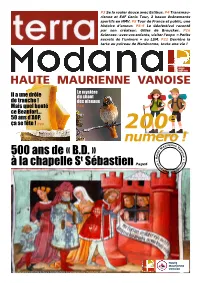
Numéro ! N Urie Ne a Va M N E O T I U S E A
P3 Se la rouler douce avec Estibus. P4 Transmau- rienne et EdF Cenis Tour, 2 beaux événements sportifs en HMV. P5 Tour de France et public, une histoire d’amour. P8-9 Le Géofestival raconté par son créateur, Gilles de Broucker. P16 Sciences : avec vos enfants, visiter l’expo « Petits secrets de l’univers » au LSM. P22 Derrière la tarte au poireau de Manévonne, toute une vie ! JUILLET AOÛT 2018 HAUTE MAURIENNE VANOISE Le mystère Il a une drôle du chant de tranche ! des oiseaux Mais quel bonté P10 ce Beaufort... 50 ans d’AOP, e ça se fête ! P20 200 numéro ! ienn ur e a Va M n e o t i u s e a 500 ans de « B.D. » * H T * t e r n r o Page6 i t t o p i à la chapelle S Sébastien r e e c x d E ’ Fresque sur un mur intérieur de la chapelle Saint-Sébastien à Val-cenis-Lanslevillard. Photo Samuel JORCIN Journal gratuit N°200 d’information du territoire JUILLET Haute Maurienne Vanoise. e AOÛT 2018 Art de vivre, habitat, culture, 200 économie, sport et nature, circuits courts, sorties, spectacles, patrimoine, histoire... numéro!Deux-cents numéros de Terra c’est aujourd’hui une réalité. www.cchautemaurienne.com Modana ! Ce n’est pas rien ! Aux Ce journal - un magazine en fait - premières éditions, à partir de dé- est devenu le support de commu- cembre 2004, d’aucuns nous prédi- nication le plus lu sur le territoire. saient que la publication serait ra- Ses habitants l’ont plébiscité et pidement à court de sujets.. -

Discover Italy from Expo Milano 2015
DISCOVER ITALY FROM EXPO MILANO 2015 CITIES The charm of Turin and much more NATURE Fairy-tale panoramas and mythical summits THE FASCINATION OF THE ROYAL Ideas for the discovery of REGION a unique region, protagonist of history. And of the future. CULTURE Between museums, royal palaces and legends The Royal Palace of Turin SHOPPING When the purchase 40 becomes discovery Historic shops 42 EXCELLENCE IN CRAFTSMANSHIP Outlets and factory shops 43 UNEXPECTED BARGAINS 34 A CONTENTS CULTURE LAKES SPAS In Piedmont, 8 Mirrors of beauty 20 To each his own wellness 30 culture is enchantment Lago d’Orta and Island of San Giulio 20 THE PLEASURE OF REGENERATION 31 The Royal Palace of Venaria 9 OASIS OF SILENCE AND OF POETRY 42 45 INVITATION TO THE COURT Lago Maggiore and the Borromeo Islands 22 FOOD Museum of Contemporary Art at Rivoli Castle 10 SUSPENDED BETWEEN ADMIRATION AND WONDER THE PAST HOUSES THE FUTURE Delicious itineraries of taste 32 B Turin’s Museum of Cinema 10 MOUNTAINS IN WINTER THE MAGIC OF THE SEVENTH ART A legend in white 24 White truffle 33 DESTINATIONS IN TURIn’s MUSEUM OF CINEMA LET THE AROMA INEBRIATE YOU IN PISTE, AMONG THE MOST STUNNING PEAKS OF ITALY 25 Here every city has a story 44 Egyptian Museum of Turin 11 Chocolate 34 INDIANA JONES FOR A DAY THE MOUTH-WATERING PASSION Turin 45 THE FASciNATING ELEGANCE OF HISTORY Turin, Saluzzo and Mondovì 12 Cheeses and cold cuts 34 BAROQUE SEDUCTION 27 GOOD BY TRADITION Alessandria 47 Holy Shroud of Turin 13 THE ciTY OF THE BORSALINO AND MARENGO Rice 35 THE MYSTERY OF A FACE CHOICE -

Parish Week 31 May 2020 the 41 Victims of the Avalanche in Van Province, Turkey Saturday, 30 May
Focus on the Word Pentecost Sunday, Year A Acts 2.1-11; 1 Corinthians 12.3-13; John 20.19-23 O God, who by the mystery of today’s great feast sanctify your whole Church in every people and nation, pour out, we pray, the gifts of the Holy Spirit across the face of the earth and, with the divine grace that was at work when the Gospel was first proclaimed, fill now once more the hearts of believers. Amen Pray for the Deceased Photo above: The alabaster window of the Holy Spirit is in the Apse Winefreda Caminting Fr. Robert Reddy wall above the Cathedra Petri in St. Peter Basilica, Vatican City. Mary Mendonca Rita Shafton Gerald Reardon Shirley Sora Parish Week 31 May 2020 The 41 victims of the avalanche in Van province, Turkey Saturday, 30 May 8.00 am Mass: † Lloyd Burke (family) st 5.00 pm Mass: † Raphael & Mariam Thattil (Mary Fernando) 1 Communion and Confirmation SUNDAY, 31 MAY / PENTECOST At the time of publication and posting, the Ontario Government DESCENT OF THE HOLY SPIRIT ON THE APOSTLES has clarified that schools will not resume until after this Summer. ■ Homilist: Deacon Ramon Villardo Sacramental Preparation meetings and instructions, which were ■ 2nd Collection: Maintenance mostly completed prior to the Covid 19 shutdown in March, will be finished as soon as it is practical. The celebrations of 1st HOLY 9.00 am Mass: † Peter Gordon Fleming (McLaughlin family) COMMUNION and CONFIRMATION, which were to take place after 10.30 am Mass: † Ernesto & Lydia Rodas (family) Holy Week, will be rescheduled later in the Fall. -

Undiscovered Italy Art, Food & Wine in Piedmont & Liguria October 4-17, 2018 (14 Days) with Carleton Professor Emeritus John Schott
Maximum participants of 24 Undiscovered Italy Art, Food & Wine in Piedmont & Liguria October 4-17, 2018 (14 days) with Carleton Professor Emeritus John Schott “It is wonderful to travel to a fascinating place with a bunch of curious, friendly people who like to talk about ideas, and to be treated to a series of lectures by a fabulous Carleton professor. In fact, this is sort of my idea of heaven.” - Marian, Oregon Sacra di San Michele © Elio Pallard CC BY-SA 4.0 Dear Carleton College Alumni and Friends, SWITZERLAND This unique program,accompanied by cinema and media studies See detail expert John Schott, Carleton Professor Emeritus, incorporates visits to Sacro Monte di Varallo fascinating, lesser-known sites with fine food and wine experiences in the Basilica of Lake San Giulio spectacular Piedmont and Liguria regions of Italy. These regions could Orta hardly be more photogenic and historically rich, with a seemingly endless Milan supply of charming churches and castles housing masterpieces of Airport medieval art, not to mention a long tradition of delectable cuisine and Milan wines, set amid backdrops of the Alps and the Mediterranean. expert trip manager and local guides Santa Maria An will illuminate the historical delle Grazie and cultural backgrounds of the places you explore, while Professor Schott will lend charm and insight to group discussions and casual Sacra di San Turin conversation. Throughout this trip, Prof. Schott will offerphotography Michele workshops for both beginners and advanced photographers. These will ITALY address a range of topics on travel photography, including workshops Piedmont Castello on landscape, architectural, “people,” and food photography.