Numero Completo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
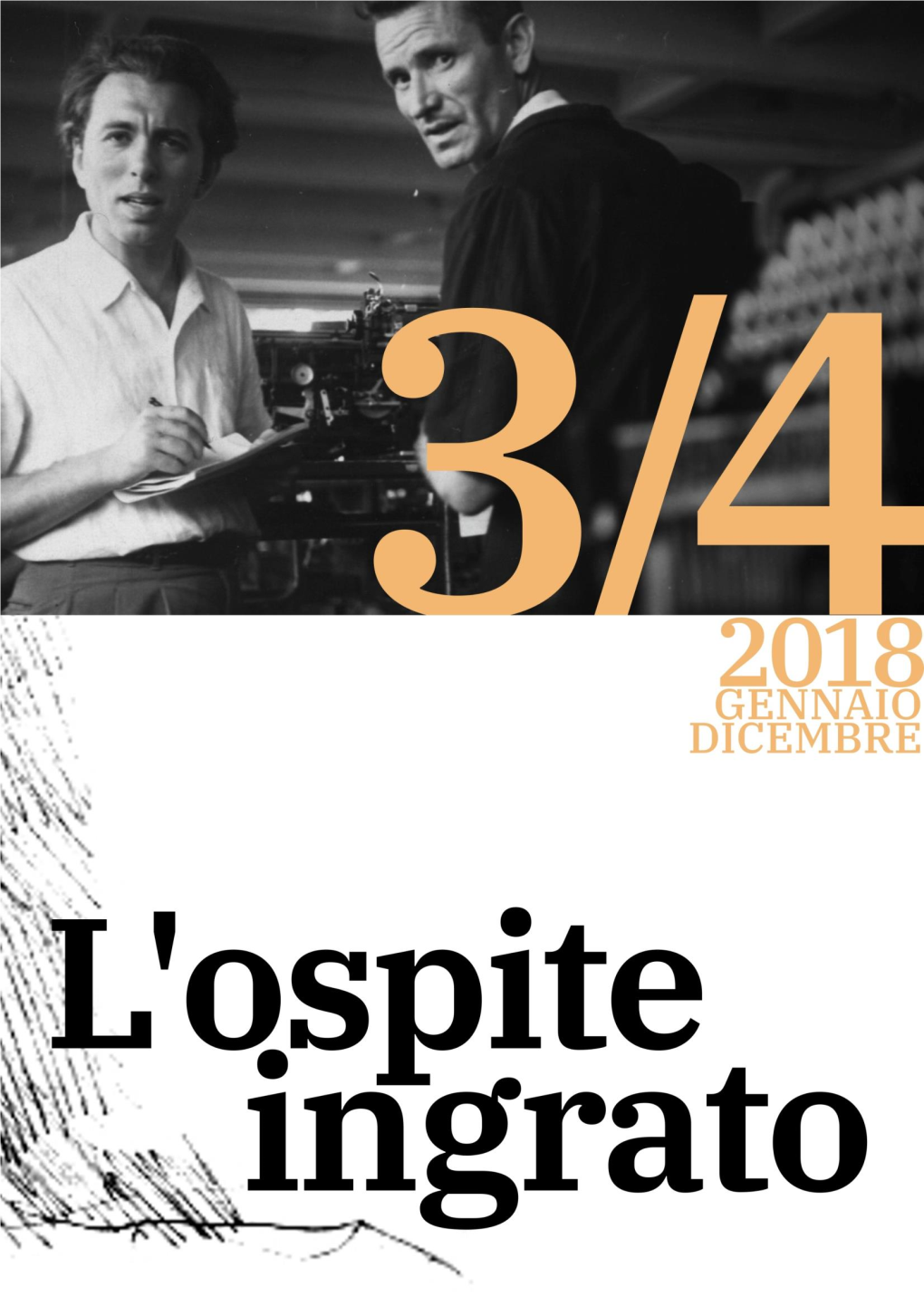
Load more
Recommended publications
-

Table Des Matières
Table des matières Préface 5 L’importance de l’archive dans la littérature de la postmodernité Margherita Ganeri «Il ritorno alla realtà» nel romanzo degli anni zero 11 Jean-François Carcelén Écriture de l’Histoire et postmodernité Le roman espagnol actuel et la mémoire revisitée 21 Ana Paula Arnaut La reescritura del pasado en clave postmodernista 31 Walter Geerts Le roman historique et ses messies À propos de Perec, Goytísolo, Tournier, Lobo Antunes et Saramago 45 Catherine De Wrangel-Lanfranchi Écriture et Histoire dans le roman historique postmoderne en France et en Italie. Peut-on parler de la constitution d’un modèle national ? 55 Alessandro Leiduan La réécriture postmoderne de l’Histoire ou le crépuscule de la praxis 67 Giuseppe Lovito La construction du sens de l’Histoire dans Le Pendule de Foucault et dans Baudolino d’Umberto Eco 79 Réflexions sur la réinvention de l’Histoire Claudio Milanesi 91 Il complotto, il gioco, la realtà Umberto Eco, George Orwell, Primo Levi, Dan Brown… 91 Leonardo Manigrasso Le eterne passioni degli italianise. L’epopea fantastorica di Enrico Brizzi 103 Alessandro Martini Une uchronie de Résistance et de football L’inattesa piega degli eventi d’Enrico Brizzi 113 La mémoire des dictatures Monica Jansen Storia, menzogna e utopia in L’amore graffia il mondo di Ugo Riccarelli e Per Isabel di Antonio Tabucchi 123 Perle Abbrugiati Tristano non invecchia in fretta 133 Stefano Magni Campo del langue Il viaggio di Eraldo Affinati attraverso la storia e la memoria 139 Hanna Serkowska Da illazioni a allucinazioni ovvero sulla cecità nella storia nei romanzi a sfondo storico di Claudio Magris 149 Anne Laure Rebreyend Réalisme postmoderne et déconstruction de l’écriture de l’Histoire dans le roman espagnol contemporain. -

L'italia in 150 Libri
LL’’IIttaalliiaa iinn 115500 lliibbrrii l’Italia in 150 libri. 150 libri, uno al giorno, sull’Italia, gli italiani e l’italianità L’Italia in 150 libri 150 libri, uno al giorno, sull’Italia, gli italiani e l’italianità In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, la Biblioteca ha predisposto uno speciale percorso di lettura che ha raccontato l’Italia e gli italiani attraverso 150 titoli significativi, scelti tra libri e altri documenti. Nel corso dell’anno, per 150 giorni, ogni giorno abbiamo proposto un titolo che è stato esposto in un apposito spazio della Biblioteca, riconoscibile perché “avvolto” dal tricolore; l’opera era corredata da una scheda sintetica di presentazione che, oltre all’argomento trattato, dava ragione dell’inclusione di quel documento all’interno di questa particolare bibliografia. Nella selezione, pur avendo privilegiato le opere più recenti, abbiamo ritenuto opportuno inserire anche alcuni classici particolarmente significativi, perché hanno contribuito alla formazione culturale degli italiani. Le schede sono qui presentate secondo l’ordine della collocazione a scaffale, per facilitarne al lettore la ricerca, ed anche perché questa classificazione consente di ordinare i materiali per affinità di argomento. All’inizio del fascicolo abbiamo inserito anche un indice ordinato per titolo, con segnata a fianco la collocazione. Ovviamente tutti i titoli selezionati sono prestabili con le consuete modalità e durante l’orario di apertura della Biblioteca. l’Italia in 150 libri. 150 libri, uno al giorno, sull’Italia, gli italiani e l’italianità ELENCO PER TITOLO (La collocazione serve a recuperare i singoli titoli nel presente repertorio e nello scaffale) 150 (anni di) invenzioni italiane / Vittorio Marchis....................................................................608.773 MAR Alpini, schutzen e kaiserjager nella Grande Guerra / Enrico Folisi ................................. -

Fenomenologia Umbedi Rto Eco (1932-2016) UMBERTO ECO VISTO DA TULLIO PERICOLI TULLIO DA VISTO ECO UMBERTO Alberto Arbasino
DI REPUBBLICA DOMENICA 21 FEBBRAIO 2016 NUMERO 571 La copertina. Il boom della “Financial Fiction” Le mostre. L’arte di Marisa e Mario Merz $VMU I tabù del mondo. Nella mente del terrorista Fenomenologia Umbedi rto Eco (1932-2016) UMBERTO ECO VISTO DA TULLIO PERICOLI TULLIO DA VISTO ECO UMBERTO Alberto Arbasino. Alberto Asor Rosa. Corrado Augias. Nanni Balestrini. Alessandro Baricco. Stefano Bartezzaghi. Zygmunt Bauman. Ginevra Bompiani. Zita Dazzi. Raffaella De Santis. Maurizio Ferraris. Simonetta Fiori. Antonio Gnoli. Ugo Gregoretti. Ezio Mauro. Tullio Pericoli. Danco Singer. Michele Smargiassi Repubblica Nazionale 2016-02-21 la Repubblica LA DOMENICA DOMENICA 21 FEBBRAIO 2016 28 Fenomenologia di Umberto Eco. “La scommessa di non cedere alla banalizzazione del sapere ma nello stesso tempo la capacità di costruirsi lettori. Accendendo una passione” EZIO MAURO RA “UNA BELLA MATTINA DI FINE NOVEMBRE, nella notte aveva nevica- to un poco” quando frate Guglielmo da Baskerville allo spuntar del sole venne avanti nell’Italia confusa del 1980. Il Paese aveva appena vissuto lo shock del delitto Moro, il punto più temerario Lo studioso della sfida terroristica alla democrazia, e l’inizio della sua caduta. Come su un terreno prosciugato, ripiegavano le Brigate Rosse e si ritiravano le ideologie, e noi entravamo senza bussola in un terri- torio sconosciuto. Ed ecco quel frate, amico di Occam e di Marsilio da Padova, che si mette in cammino sette secoli fa, procede per sette giorni e 576 pagine insieme al novizio Adso da Melk, viaggia verso settentrione ma senza seguire una linea retta, tocca città fa- che voleva Emose e abbazie antichissime che incutono paura come fortezze di Dio inaccessibili, masticando le erbe misteriose che raccoglie nei boschi e scrutando di notte, dopo vespro e compieta, le magie stregonesche dell’orologio, dell’astrolabio e addirittura del magnete. -

QUADERNI DEL PREMIO BIELLA LETTERATURA E INDUSTRIA © 2017 E20progetti Editore Via Milano, 94 - 13900 Biella
QUADERNI DEL PREMIO BIELLA LETTERATURA E INDUSTRIA © 2017 E20progetti Editore via Milano, 94 - 13900 Biella www.e20progetti.it ISBN 978-88-97816-46-1 Finito di stampare nel mese di Aprile 2017 Un’idea e l’ambizione. L’idea è che un premio letterario possa significativamente contribuire ad allargare il pubblico dei lettori e ad aumentare l’attenzione loro e degli autori sul tema dell’industria e del lavoro. Questo perchè siamo convinti che, aldilà e senza nulla togliere alla rilevanza di nuovi settori e ragioni di impiego che si affacciano e si accavallano nell’evoluzione economica e sociale di un Paese, le attività di produzione mantengono un ruolo determinante nella cultura e nella vita delle persone. L’ambizione, pensando in modo particolare ai giovani, è di contribuire a mettere in evi- denza ed a far apprezzare storie, situazioni e persone la cui rilevanza fa spesso il pari con l’inten- sità dei valori che ne sono all’origine e con l’apporto allo sviluppo della società. Il Premio Biella Letteratura Industria nasce nel 2001 ed il percorso di questi 15 anni è ricco di emozioni, di scoperte, di incontri e di idee che poche altre esperienze avrebbero potuto procurare. I Quaderni del Premio vogliono portare testimonianza e memoria di questo eccezionale percorso. Il mio pensiero volge poi al sentimento di gratitudine verso le tante persone che hanno e continua- no a contribuire all’esistenza del Premio. Nessun successo è altrettanto gratificante quanto quelli da condividere. Paolo Piana Presidente Premio Biella Letteratura e Industria 4 5 LA STORIA DEL PREMIO Per una storia del premio, sono ormai quin- unico, premio nel panorama sconfinato dei dici gli anni da raccontare, affollati di nomi, premi letterari italiani, dedicato alla lettera- date, eventi, cifre. -

Catalogo Libri.Pdf
Medianizer 1 / 348 Cover Book Summary 02.02.2020. La notte 2 febbraio 2020. È tutto pronto, il grafico incisore che ha avuto dal ministro dell’Economia l’incarico di disegnare la che uscimmo Lira Nuova ha finito, il punto di verde è perfetto. Banconote dall’euro e monete verranno messe in circolazione a partire dalla mezzanotte. Il governo è in carica da un anno e mezzo, e ormai la maggioranza è costituita da un partito unico, il Psi Sergio Rizzo – Partito sovranista italiano. Per tener fede alle promesse elettorali il Psi ha fatto saltare i conti pubblici. Così non c’è altro da fare che... 100 X 100: The Twentieth Century Through Portraits of a Hundred Sardinian Centenarians Luigi Corda 1000 giochi 10, 100, 1000 giochi... per un divertimento stratopico! Una raccolta di giochi enigmistici per tutti i gusti e tutte le età. enigmistici Cruciverba, rebus, labirinti, quiz e tanti altri rompicapo per mettere alla prova le proprie abilità e allenare la mente Geronimo Stilton divertendosi! Parola di Stilton. Età di lettura: da 7 anni. 1984 1984. Il mondo è diviso in tre immensi superstati in perenne guerra fra loro: Oceania, Eurasia ed Estasia. In Oceania la società è governata dall'infallibile e onnisciente Grande George Orwell Fratello, che nessuno ha mai visto di persona. I suoi occhi sono le telecamere che spiano di continuo nelle case, il suo braccio la Psicopolizia che interviene al minimo sospetto. Non c'è legge scritta e niente, apparentemente, è proibito. Tranne divertirsi. Tranne pensare. Tranne amare. Tranne vivere, insomma. Dal loro... 2020 verso un nuovo ecosistema della mobilità Created by Medianizer - www.medianizer.com Medianizer 2 / 348 Cover Book Summary 21 lezioni per il XXI In un mondo invaso da informazioni irrilevanti, la lucidità è potere. -

Il Bilancio Sociale 2017
PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA BILANCIO SOCIALE 2017 Hanno sostenuto l’attività della Fondazione soci partecipanti sponsor istituzionale con il sostegno sponsor attività didattiche sponsor di evento media partner sponsor tecnici Il nono Bilancio Sociale Nel corso del 2017, a seguito delle elezioni ammini- strative che hanno cambiato la giunta comunale, è venuto a scadere, come da Statuto, il Consiglio Diret- tivo della Fondazione. I membri di nuova nomina nella prima riunione han- no designato Presidente Luca Bizzarri e Vicepresi- dente Tiziana Lazzari. La struttura organizzativa di Palazzo, immutata, è nel contempo garanzia di continuità operativa e suppor- to al nuovo Consiglio Direttivo nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Questo Bilancio sociale, il nono, è redatto adottando la seguente metodologia: Pianificazione (planning): definizione della strategia e delle politiche con particolare riferimento al ruolo che l’Istituzione svolge per lo sviluppo del territorio, analisi degli ambiti di intervento, mappatura dei portatori d’interesse da coinvolgere. Raccolta dati (accounting): raccolta e analisi delle informazioni quantitative e qualitative relative ai singoli ambiti d’intervento, sia di tipo economico- finanziario sia di tipo sociale. Verifica, elaborazione e comunicazione delle risultanze (auditing e reporting): elaborazione del documento finale da diffondere e condividere con i portatori di interesse mediante gli strumenti di comunicazione su indicati. Coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholder engagement): la valutazione del gradi- mento registrato nell’anno da parte degli stakeholder; nei confronti di alcuni, come Partner o Sponsor Isti- tuzionali, la misurazione è precipuamente induttiva, fondandosi sulla continuità del supporto ricevuto, sulle dichiarazioni dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio Direttivo, sui numerosi incontri bilaterali tra vertici, sulla condivisione dei programmi. -

DONAZIONE Goffredo Fofi
AUTORE TITOLO EDITORE ANNO Eschilo. Le tragedie. Persiani, Sette Angelo Tonelli (a cura di) contro Tebe, Coefore, Supplici, Marsilio 2000 Eumenidi, Prometeo incatenato Ignazio Trappa maestro di cuoio e Rosso di S.Secondo Garzanti 1943 suolame Giovanni Comisso Il porto dell'amore Mondadori 1983 Ignacio Padilla L'ombra Giunti 2007 Alfredo Galletti(a cura di) De Marchi garzanti 1951 Norberto Bobbio De Senectute einaudi 2006 Nico Naldini Come ci si difende dai ricordi cargo 2005 Pierre Schoendoerffer Addio al re Bompiani 1970 Elena Croce In visita Mondadori 1972 Mario Pomilio Il nuovo corso Bompiani 1959 Niccolò Ammaniti Io e te einaudi 2010 Derek Walcott Odissea. Una versione teatrale crocetti 2006 Amos Oz Una pace perfetta Feltrinelli 2009 Philip K.Dick Illusione di potere Fanucci 2009 Giovanni Brera Naso bugiardo Rizzoli 1977 il terzo libro della fantascienza Il Sergio Solmi( a cura di) einaudi 1983 giardino nel tempo e altri racconti Circolo Gianni Bosio (a cura di) Il borgo e la borgata Donzelli 2002 I viaggi straordinari. Ventimila leghe Jules Verne Mursia 1988 sotto i mari G.A.Borghese Rubè Mondadori 1974 M.P.Shiel La nube Purpurea Adelphi 1967 Octavia e.Butler La parabola del seminatore Fanucci 2006 Richard Matheson Incubo a seimila metri Nightmare 2004 Mario Soldati L'architetto Rizzoli 1985 Il signor Ellery Queen l'eretico Pietro Bianchi (prefazione di) Feltrinelli 1963 avventuroso Claude Aveline L'occhio di gatto Mondadori 1974 Bertol Brecht La restibile ascesa di Artuto Ui einaudi 1961 Margaret Atwood Giochi di specchi Tricks with -

Premio Strega
VINCITORI E FINALISTI DAL 2000 Agosto – Settembre 2018 BIBLIOTECA NATALIA GINZBURG Via Genova, 10 / Bologna / Bus 19 e 27 B Tel. 051/46.63.07 [email protected] www.bibliotechebologna.it 1 PREMIO STREGA Il Premio Strega è un premio letterario che viene assegnato annualmente all'autore o autrice di un libro pubblicato in Italia, tra il 1º aprile dell'anno precedente ed il 31 marzo dell'anno in corso. Dal 1986 è organizzato e gestito dalla Fondazione Bellonci. È universalmente riconosciuto come il premio letterario più prestigioso d'Italia, oltre a godere di una consolidata fama in Europa e nel resto del mondo. Fonte: Wikipedia 2018 Vincitore: Helena Janeczek, La ragazza con la Leica, Guanda Inv. GIN 34424 - Coll. N JANEH RAG Marco Santagata. :Biografia, romanzo storico, romanzo sentimentale? La ragazza con la Leica è tutte queste cose e, forse, qualcosa di più: è la fotografia di un intero gruppo di giovani esuli, per lo più di origine ebraica, che si incontra e si unisce nella Parigi degli anni Trenta. Benedetta Tobagi :Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere rosse attraversa Parigi. È il corteo funebre per Gerda Taro, la prima fotografa caduta su un campo di battaglia. Finalisti: Carlo D’Amicis, Il gioco, Mondadori. Sandra Petrignani, La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg, Pozza. Inv. GIN 34830 - Col. MAZ 928 GIN Lia Levi, Questa sera è già domani, E/O. Inv. GIN 34732 - Col. N LEVIL QUE Marco Balzano, Resto qui, Einaudi. Inv. GIN 34906 - Col N BALZM RES 2017 Vincitore: Paolo Cognetti , Le otto montagne, Einaudi. -

La Giornalista E Scrittrice Femminista Il Fondo Adele Cambria (1956-2013)
ARCHIVI, BIBLIOTECHE, CENTRI DI DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE La giornalista e scrittrice femminista Il Fondo Adele Cambria (1956-2013) INVENTARIO a cura di Chiara Franzoni Profilo biografico di Gabriella Nisticò ROMA 2020 1 2 SOMMARIO Profilo biografico pag. 3 Introduzione archivistica generale » 5 Inventario » 7 Corrispondenza » 8 Scritti » 12 Narrativa » 12 Saggistica » 19 Articoli » 20 Dossier » 29 Interventi e interviste » 43 Testi teatrali » 57 Collaborazioni » 59 Televisive » 60 Radiofoniche » 62 Premi e riconoscimenti » 64 Materiale audiovisivo di carattere professionale » 66 Documentazione di carattere personale » 68 Carte di carattere personale » 68 Diari e appunti » 71 Materiale audiovisivo di carattere privato » 73 Cataloghi dei libri » 74 Eventi culturali » 74 Indice dei nomi » 76 Enti e associazioni » 87 3 ADELE CAMBRIA Profilo biografico di Gabriella Nisticò Giornalista e scrittrice, femminista (Reggio Calabria, 12 lug. 1931 - Roma, 5 nov. 2015). Adele Cambria è stata una giornalista e scrittrice italiana, una femminista delle origini che ha promosso e sostenuto sin dagli inizi delle sue molteplici attività i movimenti e le azioni per la conquista dei diritti delle donne. Laureatasi in Giurisprudenza all'Università di Messina con una tesi in diritto civile sotto la guida Salvatore Pugliatti, nel 1956 si trasferì a Roma ed esordì nel mondo del giornalismo come inviata de "Il Giorno", collaborando contemporaneamente e in seguito a molte testate quali "Il Mondo" di Mario Pannunzio, "Paese sera", "La Stampa", "Il Messaggero", "L'Espresso", "L'Europeo", "Il Diario della settimana", "Il Domani della Calabria", "L'Ora" di Palermo, "Lo Specchio della Stampa", "l'Unità" e altri non ancora identificati. Nel 1957 sposò il giornalista, inviato di guerra, Bernardo Valli, conosciuto a Milano negli anni de "Il Giorno", da cui ebbe due figli Emilio e Luciano, prima di separarsi scegliendo il suo percorso di vita nella capitale. -

Scarica Il Bilancio Sociale 2019
PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA BILANCIO SOCIALE 2019 HANNO SOSTENUTO L’ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE soci partecipanti sponsor istituzionale con il sostegno sponsor attività didattiche sponsor di evento media partner sponsor tecnici L’UNDICESIMO BILANCIO SOCIALE Questo Bilancio Sociale, l’undicesimo, è redatto adottando la seguente metodologia: Pianificazione (planning): definizione della strategia e delle politiche con particolare riferimento al ruolo che l’Istituzione svolge per lo sviluppo del territorio, analisi degli ambiti di intervento, mappatura dei portatori d’interesse da coinvolgere. Raccolta dati (accounting): raccolta e analisi delle informazioni quantitative e qualitative relative ai singoli ambiti d’intervento, sia di tipo economico-finanziario sia di tipo sociale. Verifica, elaborazione e comunicazione delle risultanze (auditing e reporting): elaborazione del documento finale da diffondere e condividere con i portatori di interesse mediante gli strumenti di comunicazione su indicati. Coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholder engagement): la valutazione del gradimento registrato nell’anno da parte degli stakeholder; nei confronti di alcuni, come Partner o Sponsor Istituzionali, la misurazione è precipuamente induttiva, fondandosi sulla continuità del supporto ricevuto, sulle dichiarazioni dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio Direttivo, sui numerosi incontri bilaterali tra vertici, sulla condivisione dei programmi. Per altri, i clienti e i fornitori, viene monitorata la soddisfazione con le procedure della qualità ISO 9001:2015, attraverso la compilazione dei moduli della customer satisfaction. Per il grande pubblico ha valore la capacità di generare benessere attraverso la proposta di eventi culturali a ingresso gratuito. 5 LA FONDAZIONE FONDATORI, PARTECIPANTI, ORGANI SOCIALI ART. 3 DELLO STATUTO-FINALITÀ E SCOPO Sono soci Fondatori il Comune di Genova e la Regione Liguria. -

Elenco Libri Completo Al 4-11-2017 in Ordine Di Autore E Titolo Titolo Autore Tipo Anno Cod
Elenco libri completo al 4-11-2017 in ordine di Autore e titolo Titolo Autore Tipo Anno Cod. Classificazione Il Cerchio n.9 Da Macao a Napoleone A Enciclopedia1976 29 Enciclopedia Egenio Oneghin A.A. Puskin Libro 1967 2686 Romanzo in versi Cremona fedelissima A.Campi Libro 1990 2943 Storia cremonese Anni verdi A.J. Cronin Libro 1972 2864 Narrativa ragazzi E le stelle stanno a guardare A.J. Cronin Libro 1974 3790 Romanzo Gran Canaria A.J. Cronin Libro 1956 4438 Romanzo Il medico dell'isola A.J. Cronin Libro 1966 4424 Narrativa La Cittadella A.J. Cronin Libro 1974 3787 Romanzo Dizionario illustrato della lingua latina AA Libro 1974 42 Dizionario 1945 La Liberazion. Pagina giornale AA.VV. Libro 1986 2276 Narrativa storica 24H MountainBike Cremona KulaMula AA.VV. Libro 2013 5221 Sport 25 anni dell'Espresso AA.VV. Libro 1981 1592 Narrativa storica 50 anni fa Crema e i cremaschi dal '43 al '45 AA.VV. Libro 1995 4867 Storia Acque bonifica e irrigazione in Lombardia AA.VV. Libro 2001 4294 Territorio Acque dolci sotterranee raccolta dati Agip AA.VV. Libro 1972 200 Territorio After effect 4 AA.VV. Libro 2000 4916 Computer Alla scoperta del modo ANIMALI AA.VV. Libro 1998 4782 Scienza Alla scoperta del modo DINOSAURI AA.VV. Libro 1997 4789 Scienza Alla scoperta del modo IL MARE AA.VV. Libro 1998 4787 Scienza Alla scoperta del modo IL MEDIOEVO AA.VV. Libro 2001 4786 Storia Alla scoperta del modo LA FORESTA AA.VV. Libro 2002 4788 Scienza Alla scoperta del modo LA NATURA AA.VV. -

Premio Strega
Anno Vincitore Opera Editore La nave di 2020 Sandro Veronesi Colibrì Teseo 2019 Antonio Scurati M. Il figlio del secolo Bompiani 2018 Helena Janeczek La ragazza con la Leica Guanda 2017 Paolo Cognetti Le otto montagne Einaudi 2016 Edoardo Albinati La scuola cattolica Rizzoli 2015 Nicola Lagioia La ferocia Einaudi 2014 Francesco Piccolo Il desiderio di essere come tutti Einaudi 2013 Walter Siti Resistere non serve a niente Rizzoli 2012 Alessandro Piperno Inseparabili. Il fuoco amico dei ricordi Mondadori 2011 Edoardo Nesi Storia della mia gente Bompiani 2010 Antonio Pennacchi Canale Mussolini Mondadori 2009 Tiziano Scarpa Stabat Mater Einaudi 2008 Paolo Giordano La solitudine dei numeri primi Mondadori 2007 Niccolò Ammaniti Come Dio comanda Mondadori 2006 Sandro Veronesi Caos Calmo Bompiani 2005 Maurizio Maggiani Il viaggiatore notturno Feltrinelli 2004 Ugo Riccarelli Il dolore perfetto Mondadori 2003 Melania Gaia Mazzucco Vita Rizzoli 2002 Margaret Mazzantini Non ti muovere Mondadori 2001 Domenico Starnone Via Gemito Feltrinelli 2000 Ernesto Ferrero N. Einaudi 1999 Dacia Maraini Buio Rizzoli 1998 Enzo Siciliano I bei momenti Mondadori 1997 Claudio Magris Microcosmi Garzanti Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, 1996 Alessandro Barbero Mondadori gentiluomo 1995 Mariateresa Di Lascia Passaggio in ombra Feltrinelli 1994 Giorgio Montefoschi La casa del padre Bompiani 1993 Domenico Rea Ninfa plebea Leonardo 1992 Vincenzo Consolo Nottetempo, casa per casa Mondadori 1991 Paolo Volponi La strada per Roma Einaudi 1990 Sebastiano Vassalli La