Manuale-Di-Cultura-Veneta.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Durham E-Theses
Durham E-Theses Translation and Réécriture in the Middle Ages: Rewriting Merlin in the French and Italian Vernacular Traditions CAMPBELL, LAURA,JANE How to cite: CAMPBELL, LAURA,JANE (2011) Translation and Réécriture in the Middle Ages: Rewriting Merlin in the French and Italian Vernacular Traditions, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/705/ Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in Durham E-Theses • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full Durham E-Theses policy for further details. Academic Support Oce, Durham University, University Oce, Old Elvet, Durham DH1 3HP e-mail: [email protected] Tel: +44 0191 334 6107 http://etheses.dur.ac.uk 2 Translation and Réécriture in the Middle Ages: Rewriting Merlin in the French and Italian Vernacular Traditions PhD Laura Jane Campbell Durham University, Department of French Submission Date: October 2010 i Translation and Réécriture in the Middle Ages: Rewriting Merlin in the French and Italian Vernacular Traditions Laura Jane Campbell, Durham University Abstract: This thesis will investigate the processes of translation and rewriting (réécriture) in the thirteenth and fourteenth centuries, through a study of the French and Italian Merlin corpus. -

Il Capitale Culturale
21 IL CAPITALE CULTURALE Studies on the Value of Cultural Heritage eum Rivista fondata da Massimo Montella Ines Ivić, «Recubo praesepis ad antrum»: The Cult of Saint Jerome in the Church of Santa Maria Maggiore in Rome at the End of the 13th Century «Il capitale culturale», n. 21, 2020, pp. 87-119 ISSN 2039-2362 (online); DOI: 10.13138/2039-2362/2234 «Recubo praesepis ad antrum»: The Cult of Saint Jerome in the Church of Santa Maria Maggiore in Rome at the End of the 13th Century Ines Ivić* Abstract This paper analyzes the setting up of the cult of Saint Jerome in Rome at the end of the 13th century in the papal basilica of Santa Maria Maggiore. It observes the development of the cult as part of the renovations of the church during the pontificate of Nicholas IV and the patronage of the Colonna family. It argues that it happened during the process of Franciscanization of the church and making the ideological axis between the Roman basilica and new papal basilica in Assisi, stressed also in their pictorial decorations – the mosaics in the apse in Rome, and the Life of Saint Francis in Assisi. It also studies the construction of Jerome’s Roman identity in correlation with the confirmation of Santa Maria Maggiore church as a “second Bethlehem” after the fall of the Latin Kingdom of Jerusalem, reflecting upon the leading proponents of the idea, architectural setting, artistic production and hagiographical texts produced to uphold this idea. *Ines Ivić, PhD Candidate, Central European University (CEU), Department of Medieval Studies, Nádor utca 9, H-1051 Budapest, e-mail: [email protected]. -

Submitted Ro the #"Ïlì;Ïi"Raduare Srudies in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Of
Locating the Franciscans within the cities of Thirteenth century Northem Italy Using the Chronicle of Salimbene de Adant by Robert C. Jacobs Submitted ro the #"Ïlì;ïi"raduare srudies In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of: MASTER OF ARTS Joint Masters program Department of History University of Manitoba/University of Winnipeg @2007 THE T]NTVERSITY OF MANITOBA F'ACULTY OF GÌADUATE STUDIES COPYRIGHT PERMISSION Locating the Franciscans within the Cities of Thirteenth Century Northern Italy Using the Chronicle of Salimbene de Adøm BY Robert C. Jacobs A ThesisÆracticum submitted to the Faculty of Graduate Studies of The Universitv of Manitoba in partiat fulfillment of the requirement of the degree MASTER OF ARTS Robert C. Jacobs A 2007 Permission has been granted to the Library of the University of Manitoba to lend or sell copies of this thesis/practicum, to the National Library of Canada to microfilm this thesis and to lend or sell copies of the film, and to University Microfilms Inc. to publish an abstract of this thesis/practicum. This reproduction or copy of this thesis has been made available by authority of the copyright owner solely for the purpose of private study and research, and may ónly be reproduce¿ án¿ copied as permitted by copyright laws or with express written authorization from thã copyright ownôr. THE T'NIVERSITY OF MANITOBA FACULTY OF GRADUATE STUDIES {<++* MASTER'S THESISi?RACTICUM FINAL REPORT Master's Thesis entitled: Locating the Franciscans within the Cities of Thirteenth Century Northern ltaly Using the Chronicle of Sølimbene de Adam Submitted bv Robert C. -

The Pedagogical Value of Autopsy
Editorial The pedagogical value of autopsy Fernando Peixoto Ferraz de Camposa, Luiz Otávio Savassi Rochab Campos FPF, Rocha LOS. The pedagogical value of autopsy [editorial]. Autopsy Case Rep [Internet]. 2015;5(3):1-6. http://dx.doi.org/10.4322/acr.2015.011 “WHERE WE HAVE BEEN” Knowledge of human anatomy was acquired opening of one of the bodies in an attempt to find the through dissections of the human body that may possible cause of death by studying the viscera. have begun as long as 4000 years ago, in Babylonian A century later, in 1286, Salimbene di Adam of times. Later documentation was in Egyptian times Parma, a Franciscan friar, examined the heart of a (3000 BC-1600 BC), as exemplified with the Ebers and patient who died from the plague, comparing it to other papyri. Around 300 BC, the Greek physician, the heart of a chicken thought to have been affected Herophilus (335-280 BC), wrote a treatise on human by the same disease. It is worth noting that Pope anatomy and Erasistratus (304-250 BC), his student Innocent III, in 1209, had already recommended that and colleague at the medical school of Alexandria, all unexplained deaths should be evaluated by an produced the first description, albeit brief, of liver experienced physician; this ruling reversed the church’s cirrhosis observing that the liver of a man who died position against violation of the corpse. with anasarca (“hydrops”) was “as hard as a rock”, However, it was only at the height of the Italian contrasting it with the soft consistency of the liver of Renaissance that Antonio Benivieni (1443-1502), a another man who died from the bite of a poisonous physician to the most important families of Florence, snake. -

Read Ebook {PDF EPUB} Il Novellino by Anonymous Unfinished Stories
Read Ebook {PDF EPUB} Il Novellino by Anonymous Unfinished Stories. There was a shepherd once who went out to the hill to look after his sheep. It was misty and cold, and he had much trouble to find them. At last he had them all but one; and after much searching he found that one too in a peat hag [bog] half drowned. So he took off his plaid, and bent down and took hold of the sheep's tail, and he pulled! The sheep was heavy with water, and he could not lift her, so he took off his coat, and he pulled!! But it was too much for him, and he spit on his hands, and took a good hold of the tail and he PULLED!! And the tail broke! And if it had not been for that, this tale would have been a great deal longer. Source: J. F. Campbell, Popular Tales of the West Highlands (London: Alexander Gardner, 1890), vol. 2, no. 57, p. 494. Norway. Once upon a time a little boy was walking down a road. After he had gone a piece he found a chest. "For sure there is something rare in this chest," he said to himself. But however he examined it, he found no way to open it. "That is very strange," he thought. When he had gone on a piece he found a little key. So he stopped and sat down, and he thought it would be good if the key fit the chest, for there was a little keyhole in it. -

Fra Salimbene and the Franciscan Ideal
Harvard Theological Review http://journals.cambridge.org/HTR Additional services for Harvard Theological Review: Email alerts: Click here Subscriptions: Click here Commercial reprints: Click here Terms of use : Click here Fra Salimbene and the Franciscan Ideal Ephraim Emerton Harvard Theological Review / Volume 8 / Issue 04 / October 1915, pp 480 - 503 DOI: 10.1017/S0017816000009196, Published online: 03 November 2011 Link to this article: http://journals.cambridge.org/ abstract_S0017816000009196 How to cite this article: Ephraim Emerton (1915). Fra Salimbene and the Franciscan Ideal. Harvard Theological Review, 8, pp 480-503 doi:10.1017/S0017816000009196 Request Permissions : Click here Downloaded from http://journals.cambridge.org/HTR, IP address: 131.220.247.202 on 01 Apr 2015 480 HARVARD THEOLOGICAL REVIEW FRA SALIMBENE AND THE FRANCISCAN IDEAL EPHRAIM EMERTON HARVARD UNIVERSITY One of the most engaging personalities of that most engaging of Christian centuries, the thirteenth, is Brother Salimbene of Parma. His life, begun in 1221, five years before the death of Francis of Assisi and ended, probably, about 1288, thirteen years after the birth of Dante, connects the mystical, devotional, ascetic piety of the Middle Ages with the rational, individualistic, personal attitude of the modern mind. A devoted member of the Franciscan Order and acutely sensitive to its historic sig- nificance, he spends his life in its manifold activities, and toward the close sets himself to the congenial task of put- ting down in order the most vivid impressions remaining to him of the men and things he has had dealings with. The result is the famous Chronicle, now for the first time presented to the learned world in an edition worthy of the best traditions of modern editorial thoroughness and exactness.1 It was a fortunate chance that brought the work of this Italian, concerned almost entirely with the affairs of his own country and his own Order, within the scope of the Monumenta Germaniae Historica and thus into the trained hands of the late Professor Oswald Holder-Egger. -

The Four Great Catalan Chronicles, One of the Best Historiographic Series in Mediaeval Europe*
CATALAN HISTORICAL REVIEW, 12: 27-41 (2019) Institut d’Estudis Catalans, Barcelona DOI: 10.2436/20.1000.01.154 · ISSN: 2013-407X http://revistes.iec.cat/chr/ The four great Catalan chronicles, one of the best historiographic series in mediaeval Europe* Lluís Cifuentes i Comamala** Universitat de Barcelona Received 8 October 2018 · Accepted 14 January 2019 Abstract The chronicles of James I (c. 1270-1276), Bernat Desclot (c. 1280-1288), Ramon Muntaner (1325-1328) and Peter the Ceremonious (c. 1345-1385), known as the four great Catalan chronicles, are one of the best sets of historiographic works from mediaeval Europe. Eminent scholars, historians and philologists have studied and published them, and translations in numerous languages have also been issued. Nonetheless, they are still undeservedly unknown outside the circle of experts in Catalan history and literature. In 1971, Ferran Soldevila published a joint edition of all four chronicles with profuse historical annotations, which was recently revised and expanded by the historian Maria Teresa Ferrer i Mallol and the linguist Jordi Bruguera in an edition which currently provides the best access to these works. This article provides a summary of current knowledge of these works from an interdisciplinary perspective, along with a few new insights. Keywords: historiography, chronicles, James I the Conqueror, Bernat Desclot, Ramon Muntaner, Peter III the Ceremonious The chronicles of James I (c. 1270-1276), Bernat Desclot of the Crown of Aragon, and in consequence the domi- (c. 1280-1288), Ramon Muntaner (1325-1328) and Peter nant vernacular at the court and in the administration. the Ceremonious (c. 1345-1385), known as the four great For this same reason, these chronicles are also predomi- Catalan chronicles, are one of the best sets of historio- nantly Catalan-centric. -

The Mongol Empire Between Myth and Reality Iran Studies
The Mongol Empire between Myth and Reality Iran Studies Editorial Board Ali Gheissari (University of San Diego, CA) Yann Richard (Sorbonne Nouvelle) Christoph Werner (University of Marburg) VOLUME 11 The titles published in this series are listed at brill.com/is The Mongol Empire between Myth and Reality Studies in Anthropological History By Denise Aigle LEIDEN | BOSTON Cover illustration: Genghis Khan’s quriltai of 1206, illustration from Rashīd al-Dīn, Jāmiʿ al-tawārīkh, BNF Suppl. persan 1113, fol. 139v. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Aigle, Denise. The Mongol Empire between myth and reality : studies in anthropological history / by Denise Aigle. pages cm. — (Iran studies ; v. 11) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-90-04-27749-6 (hardback : alk. paper) — ISBN 978-90-04-28064-9 (e-book : alk. paper) 1. Mongols—History—To 1500. 2. Ethnohistory—Asia. I. Title. DS19.A36 2014 950’.2—dc23 2014030153 This publication has been typeset in the multilingual “Brill” typeface. With over 5,100 characters covering Latin, ipa, Greek, and Cyrillic, this typeface is especially suitable for use in the humanities. For more information, please see brill.com/brill-typeface. issn 1569-7401 isbn 978-90-04-27749-6 (hardback) isbn 978-90-04-28064-9 (e-book) Copyright 2015 by Koninklijke Brill nv, Leiden, The Netherlands. Koninklijke Brill nv incorporates the imprints Brill, Brill Nijhoff, Global Oriental and Hotei Publishing. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher. -

Frederick II Hohenstaufen
Salvatore Ferdinando Antonio Caputo The Court of Frederick II Hohenstaufen Salvatore Ferdinando Antonio Caputo The Court of Frederick II Hohenstaufen Copyright © Salvatore Ferdinando Antonio Caputo 2013. All rights reserved. No part of this book shall be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means – electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise– without written permission from the publisher. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. Although every precaution has been taken in the preparation of this book, the publisher and author assume no responsibility for errors or omissions. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein. Page 2 of 132 I have always been fascinated by history, of my own history, and that of my family, which I discovered could be traced from the Hohenstaufen Dynasty. Through studying different periods of history from medieval to early modern through to the present day I have gained an understanding into some of the crucial developments that have determined what course our future would take. Salvatore Ferdinando Antonio Caputo Other publications of Dr. Salvatore Ferdinando Antonio Caputo: The Hohenstaufen Dynasty (2013) Who is noble included in the Almanach de Gotha - Goliardica Editrice s.r.l, Trieste (2013) The Court of Frederick II Hohenstaufen - Goliardica Editrice s.r.l, Trieste (2013) Corrado I principe d´Antiochia Della Casa di Sveva (Ramo Caputo) - Edizioni Italo Svevo, Trieste (2012) The Legitimacy of Non Reigning Royal Families - Edizioni Italo Svevo, Trieste (2012) Creation of Order of Chivalry (2012) The Royal House of Georgia - H.R.H. -

Imagopapae-2018-Programmedef.Pdf
Organisation IMAGOPAPAE Colloque International Claudia D’Alberto Chercheuse post-doc Marie Curie COFUND Liège Université Transitions Unité de Recherches sur le Moyen Age et la Première Modernité Service d’Histoire de l’Art et Archéologie du Moyen Âge En collaboration avec Bibliotheca Hertziana (Rome) Institut de recherche et d’histoire des textes (Paris) Musée du Petit Palais d’Avignon Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (Florence) Università degli Studi di Ferrara Comité Organisateur 20-22 JUIN 2018 Université de Liège, Salle Académique Dominique Allart Eric Bousmar Claudia D’Alberto Annick Delfosse Laure Fagnart Marie-Elisabeth Henneau Alain Marchandisse Benoît Van den Bossche UR Transitions Comité Scientifique Moyen Âge et première Modernité Marcello Angheben, Étienne Anheim, Pierre Assenmaker, Maria Giulia Aurigemma, Martin Aurell, Xavier Barral I Altet, Philippe Bernardi, Paul Bertrand, Eric Bousmar, Yves Bruley, Francesca Cappelletti, Guido Castelnuovo, Florence Close, Jean-Michel Counet, Gaetano Curzi, Jean-Pierre Delville, Maria Carmen Lacarra Ducay, Nadine Henrard, Dominique Iogna-Prat, Armand Jamme, Barbara Jatta, Fabienne Joubert, Silvia Maddalo, Francesca Manzari, Marc-Emmanuel Mélon, Tanja Michalsky, Maria Giuseppina Muzzarelli, Dominic Olariu, Sergio Pagano, Stefania Paone, Agostino Paravicini Bagliani, Paul Payan, Laura Pettinaroli, Pio Francesco Pistilli, Josefina Planas, Joëlle Rollo-Koster, Serena Romano, Francesco Santi, Stephano Simiz, Valérie Theis, Alessandro Tomei, Michele Tomasi, Marina Vicelja-Matijasic, -

Harvard Theological Review Fra Salimbene and the Franciscan Ideal
Harvard Theological Review http://journals.cambridge.org/HTR Additional services for Harvard Theological Review: Email alerts: Click here Subscriptions: Click here Commercial reprints: Click here Terms of use : Click here Fra Salimbene and the Franciscan Ideal Ephraim Emerton Harvard Theological Review / Volume 8 / Issue 04 / October 1915, pp 480 - 503 DOI: 10.1017/S0017816000009196, Published online: 03 November 2011 Link to this article: http://journals.cambridge.org/ abstract_S0017816000009196 How to cite this article: Ephraim Emerton (1915). Fra Salimbene and the Franciscan Ideal. Harvard Theological Review, 8, pp 480-503 doi:10.1017/S0017816000009196 Request Permissions : Click here Downloaded from http://journals.cambridge.org/HTR, IP address: 131.220.247.202 on 01 Apr 2015 480 HARVARD THEOLOGICAL REVIEW FRA SALIMBENE AND THE FRANCISCAN IDEAL EPHRAIM EMERTON HARVARD UNIVERSITY One of the most engaging personalities of that most engaging of Christian centuries, the thirteenth, is Brother Salimbene of Parma. His life, begun in 1221, five years before the death of Francis of Assisi and ended, probably, about 1288, thirteen years after the birth of Dante, connects the mystical, devotional, ascetic piety of the Middle Ages with the rational, individualistic, personal attitude of the modern mind. A devoted member of the Franciscan Order and acutely sensitive to its historic sig- nificance, he spends his life in its manifold activities, and toward the close sets himself to the congenial task of put- ting down in order the most vivid impressions remaining to him of the men and things he has had dealings with. The result is the famous Chronicle, now for the first time presented to the learned world in an edition worthy of the best traditions of modern editorial thoroughness and exactness.1 It was a fortunate chance that brought the work of this Italian, concerned almost entirely with the affairs of his own country and his own Order, within the scope of the Monumenta Germaniae Historica and thus into the trained hands of the late Professor Oswald Holder-Egger. -
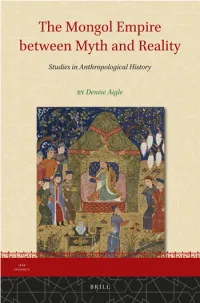
The Mongol Empire Between Myth and Reality: Studies in Anthropological History
The Mongol Empire between Myth and Reality Iran Studies Editorial Board Ali Gheissari (University of San Diego, CA) Yann Richard (Sorbonne Nouvelle) Christoph Werner (University of Marburg) VOLUME 11 The titles published in this series are listed at brill.com/is The Mongol Empire between Myth and Reality Studies in Anthropological History By Denise Aigle LEIDEN | BOSTON Cover illustration: Genghis Khan’s quriltai of 1206, illustration from Rashīd al-Dīn, Jāmiʿ al-tawārīkh, BNF Suppl. persan 1113, fol. 139v. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Aigle, Denise. The Mongol Empire between myth and reality : studies in anthropological history / by Denise Aigle. pages cm. — (Iran studies ; v. 11) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-90-04-27749-6 (hardback : alk. paper) — ISBN 978-90-04-28064-9 (e-book : alk. paper) 1. Mongols—History—To 1500. 2. Ethnohistory—Asia. I. Title. DS19.A36 2014 950’.2—dc23 2014030153 This publication has been typeset in the multilingual “Brill” typeface. With over 5,100 characters covering Latin, ipa, Greek, and Cyrillic, this typeface is especially suitable for use in the humanities. For more information, please see brill.com/brill-typeface. issn 1569-7401 isbn 978-90-04-27749-6 (hardback) isbn 978-90-04-28064-9 (e-book) Copyright 2015 by Koninklijke Brill nv, Leiden, The Netherlands. Koninklijke Brill nv incorporates the imprints Brill, Brill Nijhoff, Global Oriental and Hotei Publishing. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher.