Il Castello Di Minturno. Tecniche Costruttive E Lettura
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
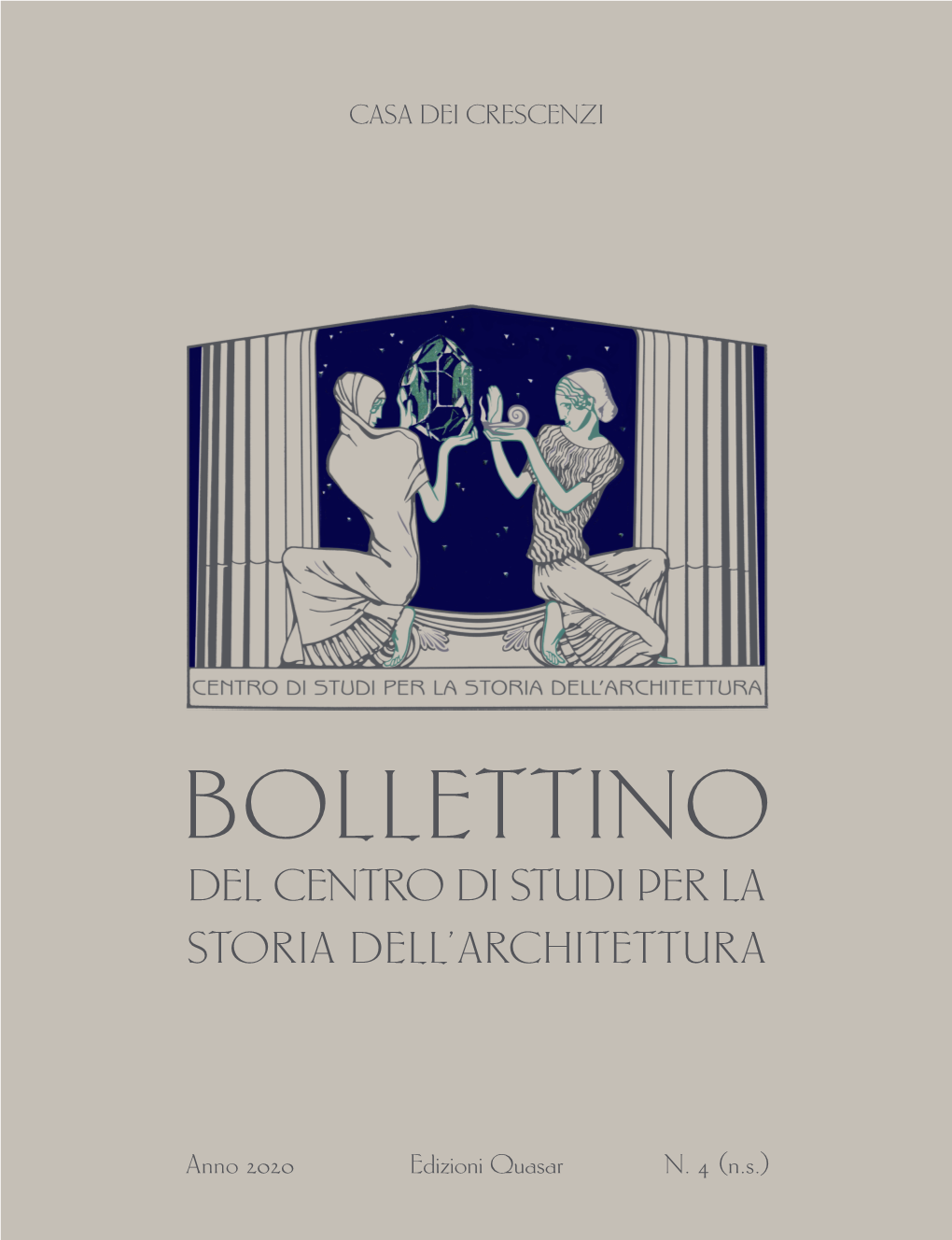
Load more
Recommended publications
-

A Friendship
Conversions Wars Cultures Religions and a Family Name MICHAEL L. SENA C OPYRIGHTED , 2012 B Y G R E E N H O R SE P U B L I S H I N G C OMPANY V ADSTENA , S WEDEN EDITED AND REVISED DECEMBER 2013 ii WARS ARE FOUGHT to gain and keep control over wealth. Tribes, clans, countries and other groups that have wealth have the power to wage and win wars. Those without wealth will always be war’s victims. They lack the resources to build effective defences and protect themselves against destructive powers. Besides extermination or assimilation, one consequence of wars for the vanquished is displacement. Defeated peoples are often set adrift. Cultures, or societies, come into existence when a sufficient number of individuals agree on a way of living together, either through consensus or through force. Cultures are sensitive organisms. They are born, sometimes growing and flourishing, oftentimes contracting and vanishing. Even the most powerful civilizations in their times have had to relinquish their positions of dominance, most often because of self destructive actions taken by their leaders. When one culture is diminished, there is always another waiting to take its place. Humankind is the sum total of all those cultures that have gone before. Religion is the codification of a society’s rules that define what is considered right and what is deemed wrong. Societies base their laws on these definitions, and the laws establish the worldly consequences of not upholding or abiding by the rules. Those who are the codifiers, the priests, gain their legitimacy by providing answers to the unanswerable. -

Inati Si In- Tende a Titolo Gratuito
La collaborazione a Studi Cassinati si in- tende a titolo gratuito. Articoli, foto, ed al tro, inviati in re da zio ne, anche se non pubbli- cati, non vengono re- stituiti. Centro Documentazione e Studi Cassinati - Onlus Si raccomanda di in - viare i testi per po sta STUDI CASSINATI e let tronica o supporti informatici al fine di Bollettino trimestrale di studi storici del Lazio meridionale e vi tare eventuali er- Anno XX, nn. 3-4, Luglio - Dicembre 2020 rori di battitura. Il contenuto e l’atten- www.cdsconlus.it - [email protected] dibilità degli ar ticoli pubblicati so no da rife- Autorizzazione del Tribunale di Cassino N. 1/2001 rirsi sempre al la re spon- sabi lità degli autori. La quota associativa annuale al CDSC-Onlus è pari a Non si accettano testi tratti da altre pubbli- € 35.00 cazioni o scaricati da internet senza l’auto- e può essere versata con bonifico, codice Iban: rizzazione degli autori. IT 09 R 07601 14800 000075845248 *** oppure sul c.c.p.: 75845248 (Codice SIA: BE7JI) Copie arretrate sono intestato a: disponibili presso i Centro Documentazione e Studi Cassinati - Onlus punti vendita se gnalati. Via S. Pasquale - 03043 CASSINO (Fr) Possono, tuttavia, es- sere richieste alla re- C.F.: 90013480604 dazione versando un *** adeguato contributo per le spese di spedi- Direttore: Gaetano de Angelis-Curtis zione. Direttore Responsabile: Giovanni D'Orefice La spedizione gratuita Vice Direttore: Arturo Gallozzi a domicilio è riservata Coordinatore: Chiara Mangiante ai soli soci. Segretario di Redazione: Fernando Sidonio *** Redazione: Ilenia Carnevale, Domenico Cedrone, Erasmo Di Vito, Costantino Jadecola, Gaetano Lena, Alberto Mangiante, Punti vendita: Giovanni Petrucci, Fernando Riccardi, Maurizio Zambardi. -

The Chronicle of Richard of S. Germano, 1189-99
1 The Chronicle of Richard of S. Germano, 1189-1199. This chronicle, which in its final form covers the years from the death of King William II of Sicily in 1189 until 1243 is the most important narrative source for the history of southern Italy under the rule of the Staufen emperors. Its author, Richard was active as a notary at S. Germano (renamed Cassino in 1863), the town at the foot of Montecassino subject to the abbey of that name, from February 1186 until March 1232. He appears to have been a trusted confidant of Stephen of Marsia, Abbot of Montecassino 1215-27, whom he accompanied to the Fourth Lateran Council of 1215, and to whom the first redaction of his chronicle was dedicated. However, from the early 1220s onwards Richard was also active in the service of Frederick II, primarily as a financial official. He may have followed his brother John, who was a chancery notary, into imperial service. In the late 1230s, despite his advanced age – he must by then have been in his seventies, Richard was active as an imperial chamberlain. He was with the emperor at the siege of Milan in the autumn of 1239, and is last attested as a chamberlain in 1242. He probably commenced writing the first version of his chronicle shortly before the death of Innocent III in 1216; this was intended as a continuation of the Annales Casinenses and covered the years from 1208, commencing with the visit of Innocent III to S. Germano in June of that year, until 1226, when it broke off abruptly, quite possibly because of the death of his patron Abbot Stephen (in July 1227). -

Open THESIS SUBMISSION5.Pdf
THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY SCHREYER HONORS COLLEGE DEPARTMENT OF HISTORY AND RELIGIOUS STUDIES ACCIDENT, OPPORTUNITY, AND FAMILY TIES: NORMAN "STATE-BUILDING" IN SOUTHERN ITALY 999-1085 SEAN C. SURFACE SPRING 2013 A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for a baccalaureate degree in History with honors in History Reviewed and approved* by the following: Kathryn Salzer Associate Professor of History Thesis Supervisor Michael Milligan Senior Lecturer in History Honors Adviser * Signatures are on file in the Schreyer Honors College. i ABSTRACT Accident, Opportunity, and Family Ties: Norman "State-Building" in Southern Italy 999- 1085 analyzes the slow and tumultuous takeover of southern Italy and Sicily by Norman immigrants in the eleventh century. Inheriting from their forebears in Normandy a uniquely flexible definition of kinship, these invaders were highly adaptable to the chaotic political landscape of Italy in the High Middle Ages. Entering the scene as mercenaries, pilgrims, and adventurers seeking glory, over the course of the eleventh century they became bandits, then landowners, then counts beneath the native rulers, and finally achieved the status of ducal powers. With no apparent plan leading to this conquest, and many signs that they were possessed of a peerless ability to take advantage of their neighbors' disorder, the Normans under the (in)famous Robert Guiscard and his family created a powerful duchy, and by the middle of the twelfth century the Kingdom of Sicily, which would exert considerable influence over the affairs of the great powers of the papacy, the Holy Roman Empire, and the Byzantine Empire throughout the Crusader Era. The translation of social values, particularly the role of kinship between the Norman rulers, and how these values affected the course of the conquest and its aftermath are the subject of this thesis. -

Colonization and the Church in High Medieval Sardinia
Colonization and the Church in High Medieval Sardinia by Ann Wesson A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Centre for Medieval Studies University of Toronto © Copyright 2015 by Ann Wesson Colonization and the Church in High Medieval Sardinia Ann Wesson Doctor of Philosophy Centre for Medieval Studies University of Toronto 2015 Abstract This thesis investigates the role that the Church played in the political, spiritual and economic colonization of Sardinia in the high Middle Ages. By using Robert Bartlett’s conception of the European “center” and “periphery,” it shows that Sardinia represents an unusual case of a territory that was culturally both central and peripheral. Within this ambiguous cultural setting, and using papal letters, political treaties, chronicles, monastic documents, and onomastic evidence, the thesis examines the way Pisa, Genoa and the Roman pontiffs used Rome’s spiritual and cultural authority to strengthen their own political and economic claims in Sardinia. Specifically, by focusing on the archbishop of Pisa and the bishops and archbishops of Sardinia, it shows that the personnel of the Church, which are not commonly considered agents of colonization in Sardinia, were in reality fundamental to bringing Sardinian society closer to being a political and cultural extension of the Italian mainland. It also, however, investigates the ways in which local Sardinian rulers at times strongly resisted ecclesiastical pressures to conform to the norms of Rome, or used the spiritual prestige and cultural tools offered by the Roman Church to negotiate political advantages for themselves. In this way, the thesis finds that foreign cultural colonization in Sardinia was at times less effective than is generally assumed, and that in certain situations the personnel of the Sardinian Church could offer the means for resistance to foreign colonization. -

Appendix Epsilon
Appendix Epsilon: The Pavia Intellectual Line Connecting brothers of Phi Kappa Psi Fraternity at Cornell University, tracing their fraternal Big Brother/Little Brother line to tri-Founder John Andrew Rea (1869) John Andrew Rea, tri-founder of Phi Kappa Psi at Cornell . . was advised by Andrew Dickson White, . Olybrius was nephew to Flavius President of Cornell . Maximus . who was lectured by, and referred Jack . Flavius Maximus was grandson to Sextus Rea to, Washington Irving . Probus . and then through the Halle line, Appendix . Sextus Probus was son-in-law and first Delta, to the University of Pavia . cousin to Quintus Olybrius . . Pavia was elevated by the Carolingian . Quintus Olybrius was the son of to Clodius Emperor Lothair . Celsinus Adelphus spouse to Faltonia Betitia Proba . whose grandfather deposed the last . all of the above were Neo-Platonists in the Lombardic king Desiderius . tradition of Plotinus . who ruled in succession to the founder of . Plotimus was a student of Ammonius, he of his dynasty, Alboin . Numenius, he of Pythagoras, he of Pherecydes . Alboin forcefully married Rosamund, . Pythagoras also studied under princess of the Gepids . Anaximenes, he under Anaximander, he under Thales . Rosamund was daugther to Cunimund, last . king of the Gepids. Thales studied in the school of Egyption priest Petiese, who was invested by king Psamtik . the story of Cunimund’s court was . who served under Assyria king preserved by Cassiodorus . Esarhaddon, successor to Sennencherib . . Cassiodorus succeeded Boethius as first . successor to the two Sargons . Minister to the Ostrogoths . Boethius was grandson of Emperor Olybrius . Below we present short biographies of the Pavia intellectual line of the Phi Kappa Psi Fraternity at Cornell University. -

Historia Medieval 43 2 Diplomatiques — K
www.porticolibrerias.es Nº 732 PÓRTICOSemanal Historia medieval 43 8 mayo 2006 Responsable de la Sección: Concha Aguirre Dirige: José Miguel Alcrudo Obras generales: 001 — 030 Fuentes y ciencias auxiliares: 031 — 054 Arte — Arqueología: 055 — 067 Filología — Literatura: 068 — 084 Filosofía — Teología — Ciencia — Cultura: 085 — 129 Derecho — Instituciones: 130 — 146 Historia económica y social: 147 — 172 Iglesia — Religión: 173 — 185 Bizanzio — Oriente cristiano: 186 — 194 Islam: 195 — 211 Judaica: 212 — 217 OBRAS GENERALES 001 Bachrach, B. S.: Early Carolingian Warfare. Prelude to Empire 2000 – 432 pp. € 61,85 002 Bicchierai, M.: Ai confini della repubblica di Firenze. Poppi dalla signoria dei conti. Guidi al vicariato del Casentino (1360-1480) 2005 – xxxii + 450 pp. € 46,80 003 Bouet, P. / V. Gazeau, eds.: La Normandie et l’Angleterre au moyen âge. Colloque de Cerisy-la-Salle, 4-7 octobre 2001 2003 – 363 pp., fig., lám.col. € 32,50 INDICE: 1. 911-1204: P. Bauduin: La parentèle de Guillaume le conquérant: l’aperçu des sources PÓRTICO LIBRERÍAS PS 732 — Historia medieval 43 2 diplomatiques — K. Keats-Rohan: Le rôle des élites dans la colonisation de l’Angleterre (vers 1066- 1135) — J. Green: Le gouvernement d’Henri Ier Beauclerc en Normandie — N. Vincent: Les normands de l’entourage d’Henri II Plantagenêt — V. Moss: Reprise et innovations: les rôles normands et anglais de l’année 1194-1195 et la perte de la Normandie — D. Rouet: Le patrimoine anglais et l’Angleterre vus à travers les actes du cartulaire de Saint-Pierre de Préaux — E. van Houts: L’exil dans l’espace anglo-normand — R. -

CEU Department of Medieval Studies in 2014/2015
ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU VOL. 22 2016 Central European University Budapest ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU VOL. 22 2016 Edited by Judith A. Rasson and Zsuzsanna Reed Central European University Budapest Department of Medieval Studies All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means without the permission of the publisher. Editorial Board Gerhard Jaritz, György Geréby, Gábor Klaniczay, József Laszlovszky, Judith A. Rasson, Marianne Sághy, Katalin Szende, Daniel Ziemann Editors Judith A. Rasson and Zsuzsanna Reed Technical Assistant Kyra Lyublyanovics Cover Illustration Copper coin of Béla III (1172–1196), CNH 101, Hungary. Pannonia Terra Numizmatika © (reproduced with permission) Department of Medieval Studies Central European University H-1051 Budapest, Nádor u. 9., Hungary Postal address: H-1245 Budapest 5, P.O. Box 1082 E-mail: [email protected] Net: http://medievalstudies.ceu.edu Copies can be ordered at the Department, and from the CEU Press http://www.ceupress.com/order.html Volumes of the Annual are available online at: http://www.library.ceu.hu/ams/ ISSN 1219-0616 Non-discrimination policy: CEU does not discriminate on the basis of—including, but not limited to—race, color, national or ethnic origin, religion, gender or sexual orientation in administering its educational policies, admissions policies, scholarship and loan programs, and athletic and other school-administered programs. © Central European University Produced by Archaeolingua Foundation & Publishing House TABLE OF CONTENTS Editors’ preface ............................................................................................................ 5 I. ARTICLES AND STUDIES ........................................................... 7 Johanna Rákos-Zichy To Bury and to Praise: The Late Antique Bishop at His Parents’ Grave .............................................. -

Langobardia Minor, Secoli IX-XI Persistenza E Trasformazione Dell'identità Longobarda Tra Confronto Politico, Pratiche Giuridiche E Memoria Storiografica
Corso di Laurea magistrale in Storia dal medioevo all'età contemporanea Tesi di Laurea Langobardia minor, secoli IX-XI Persistenza e trasformazione dell'identità longobarda tra confronto politico, pratiche giuridiche e memoria storiografica. Relatore Prof. Stefano Gasparri Laureanda Giulia Zornetta 811003 Anno Accademico 2011 / 2012 Introduzione L'oggetto della presente tesi è la persistenza e la trasformazione dell'identità longobarda nell'Italia meridionale, ovvero come la ricca tradizione del Regnum Langobardorum venga ripresa dopo il 774, cioè dopo la caduta di quest'ultimo nelle mani dei Franchi, dal ducato di Benevento e qui riabilitata, oltre che progressivamente trasformata, in funzione delle nuove esigenze – sociali e politiche – del Mezzogiorno longobardo. Questo processo ha dunque inizio con la seconda metà dell'VIII secolo ed arriva a compimento tra IX e X secolo, per poi archiviarsi definitivamente con la conquista normanna dell'Italia meridionale, avvenuta nel secolo XI per mano delle famiglie Drengot e, soprattutto, con gli Altavilla. A tale proposito si sono prese in esame essenzialmente tre tipologie di fonti, ovvero quelle cronachistiche da un lato e quelle documentarie e legislative dall'altro. Le prime hanno consentito un'analisi degli aspetti riguardanti la costruzione sociale della memoria storiografica – un processo che ha sede soprattutto negli ambienti colti ed in primo luogo a Montecassino – e, accanto a ciò, di quelli relativi alla rappresentazione del potere, con una particolare attenzione per quanto riguarda -

Cosimo Damiano Fonseca Monachesimo Ed Eremitismo in Italia Nel XII Secolo [A Stampa in Studi in Onore Di Giosuè Musca , a Cura Di C
Cosimo Damiano Fonseca Monachesimo ed Eremitismo in Italia nel XII secolo [A stampa in Studi in onore di Giosuè Musca , a cura di C. D. Fonseca e V. Sivo, Bari 2000, pp. 173-187 – Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”] La vicenda per tanti versi emblematica di Raniero da Ponza esemplata su quella di Gioacchino da Fiore il quale, partendo da una esperienza religiosa legata al monachesimo riformato, approda a una scelta eremitica, ripropone, ancora una volta, uno dei tratti distintivi del XII secolo e cioè il rapporto dialettico tra monachesimo ed eremitismo, un rapporto fecondo per le implicazioni che comporta sul piano istituzionale, spirituale, ascetico e sociale 1. A scorrere le due Vite dell’Abate calabrese, quella dell’Anonimo e l’altra di Luca di Casamari – a prescindere dal valore paradigmatico e dall’orientamento ideale dei rispettivi biografi – si coglie con sufficiente chiarezza l’itinerario percorso da Raniero e la consapevolezza di condividere con Gioacchino una esperienza religiosa, singolare e irripetibile 2. Raniero da Ponza, personalità molto verosimilmente di robusta formazione giuridica, aveva gravitato negli ambienti curiali romani e aveva svolto missioni diplomatiche nella penisola iberica (“liberalibus eruditus, sermone disertus… et factus fuit per Ispaniam postea <legatus>“) prima di essere conquistato dalla personalità di Gioacchino e dalla sua innegabile capacità di interpretazione delle Sacre Scritture (“venit… de insula Pontiane audire novi sapientiam Salomonis… testatus est de magistro discipulus quia per hunc est in divinarum scripturarum ianuam introductus”) 3. Inizia così quell’avventura spirituale e quel sodalizio religioso che porterà entrambi – anche se l’Anonimo specifica con consapevole accentuazione che, pur correndo insieme (Joh. -

Labour Services and Peasant Obligations in Twelfth- and Thirteenth-Century Southern Italy
This is a repository copy of Labour Services and Peasant Obligations in Twelfth- and Thirteenth-Century Southern Italy. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/94585/ Version: Accepted Version Book Section: Loud, GA (2018) Labour Services and Peasant Obligations in Twelfth- and Thirteenth-Century Southern Italy. In: Balzaretti, R, Barrow, J and Skinner, P, (eds.) Italy and Early Medieval Europe: Papers for Chris Wickham. The Past and Present Book Series . Oxford University Press , Oxford, UK , p. 182. ISBN 9780198777601 © 2018, Oxford University Press. This is a pre-copyedited, author-produced version of a book chapter published in Italy and Early Medieval Europe: Papers for Chris Wickham, following peer review. The version of record, Loud, GA (2018) Labour Services and Peasant Obligations in Twelfth- and Thirteenth-Century Southern Italy. In: Balzaretti, R, Barrow, J and Skinner, P, (eds.) Italy and Early Medieval Europe: Papers for Chris Wickham. The Past and Present Book Series . Oxford University Press , Oxford, UK , p. 182. ISBN 9780198777601, is available online at: https://global.oup.com/academic/product/italy-and-early-medieval-europe-9780198777601 Reuse Items deposited in White Rose Research Online are protected by copyright, with all rights reserved unless indicated otherwise. They may be downloaded and/or printed for private study, or other acts as permitted by national copyright laws. The publisher or other rights holders may allow further reproduction and re-use of the full text version. This is indicated by the licence information on the White Rose Research Online record for the item. Takedown If you consider content in White Rose Research Online to be in breach of UK law, please notify us by emailing [email protected] including the URL of the record and the reason for the withdrawal request. -

Sacco-Tondo-E-Betori
estratto MINI S TERO PER I BENI E L E ATTIVITÀ CU L TURA L I SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEO L OGICI DE L LAZIO Lazio e Sabina 8 a cura di GIU S EPPINA GHINI e ZACCARIA MARI Atti del Convegno Ottavo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina Roma 30-31 marzo, 1 aprile 2011 EDIZIONI QUA S AR estratto MINI S TERO PER I BENI E L E ATTIVITÀ CU L TURA L I SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEO L OGICI DE L LAZIO a cura di Giuseppina Ghini e Zaccaria Mari Coordinamento Giuseppina Ghini L’editore si dichiara pienamente disponibile a soddisfare eventuali oneri derivanti da diritti di riproduzione. È vietata la riproduzione con qualsiasi procedimento della presente opera o di parti di essa. © 2012 Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio © Roma 2012, Edizioni Quasar di Severino Tognon srl via Ajaccio 43 - 00198 Roma, tel. 0685358444 fax 0685833591 e-mail: [email protected] www.edizioniquasar.it ISBN 978-88-7140-476-9 estratto Ricerche nel Comune di Villa Santa Lucia presso Cassino (Frosinone) Alessandro Betori – Manuela Tondo – Dante Sacco 1. Premessa dazione (fig. 1), ha permesso una buona conoscenza dell’evoluzione delle dinamiche insediamentali. La Il territorio del Comune di Villa Santa Lucia, pic- presenza di due assi viari principali, la via Latina5 e colo centro a mezzacosta sulle estreme propaggini la via Pedemontana6, e l’esistenza, variamente indi- di monte Cairo presso Cassino, noto nel medioevo ziata, di alcuni collegamenti trasversali con la valle di come Villa Pedemontis1, è posto a confine tra le anti- Comino, quali i percorsi condotti attraverso il fosso che città di Aquinum, Casinum e Interamna Lirenas, dell’Acquasanta e il vallone di Santa Scolastica, han- i cui agri si incontravano presso il sito del monastero, no favorito la presenza antropica e lo stanziamento poi castrum, di Piumarola2.