Rodolfo Renier Il Libro Ritrovato
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Der Österreichische Neoabsolutismus Als Verfassungs- Und Verwaltungsproblem. Diskussionen Über Einen Strittigen Epochenbegriff
VERÖFFENTLICHUNGEN DER KOMMISSION FÜR NEUERE GESCHICHTE ÖSTERREICHS Band 108 Kommission für Neuere Geschichte Österreichs Vorsitzende: Univ.-Prof. Dr. Brigitte Mazohl Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Reinhard Stauber Mitglieder: Dr. Franz Adlgasser Univ.-Prof. Dr. Peter Becker Univ.-Prof. i. R. Dr. Ernst Bruckmüller Univ.-Prof. Dr. Laurence Cole Univ.-Prof. Dr. Margret Friedrich Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Garms-Cornides Univ.-Prof. Dr. Michael Gehler Univ.-Doz. Mag. Dr. Andreas Gottsmann Univ.-Prof. Dr. Margarete Grandner em. Univ.-Prof. Dr. Hanns Haas Univ.-Prof. i. R. Dr. Wolfgang Häusler Univ.-Prof. i. R. Dr. Ernst Hanisch Univ.-Prof. Dr. Gabriele Haug-Moritz Dr. Michael Hochedlinger Univ.-Prof. Dr. Lothar Höbelt Mag. Thomas Just Univ.-Prof. i. R. Dr. Grete Klingenstein em. Univ.-Prof. Dr. Alfred Kohler Univ.-Prof. Dr. Christopher Laferl Gen. Dir. Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Maderthaner Dr. Stefan Malfèr Gen. Dir. i. R. H.-Prof. Dr. Lorenz Mikoletzky Dr. Gernot Obersteiner Dr. Hans Petschar em. Univ.-Prof. Dr. Helmut Rumpler em. Univ.-Prof. Dr. Gerald Stourzh Univ.-Prof. Dr. Arno Strohmeyer Univ.-Prof. i. R. Dr. Arnold Suppan Univ.-Doz. Dr. Werner Telesko Univ.-Prof. Dr. Thomas Winkelbauer Sekretärin: Mag. Dr. Karin Schneider Der österreichische Neoabsolutismus als Verfassungs- und Verwaltungsproblem Diskussionen über einen strittigen Epochenbegriff Herausgegeben von Harm-Hinrich Brandt 2014 BÖHLAU VERLAG WIEN · KÖLN · WEIMAR Die in den Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs gemachten Aussagen sind die der jeweiligen Verfasser, nicht die der Kommission. Veröffentlicht mit Unterstützung des Austrian Science Fund ( FWF ): PUB 158-V21 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek : Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National- bibliografie ; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http ://dnb.d-nb.de abrufbar. -

Přírůstky Knihovny ÚDUK-AUK Za Únor 2017
Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za únor 2017 U n i v e r s i t i k a : Aragon, Louis, 1897-1982 O teorii a praxi v literatuře : projev Louise Aragona při udělení čestného doktorátu University Karlovy dne 6. září 1962 / Projev Louise Aragona ; [editor] P. Levit Praha, 1963. nestr. sg.: 15G81 Bericht des Präsidenten 3. (1984-1988) Passau, 1988. 92 s. sg.: Ev/Ne/Pasov/1 Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis = Die ältesten Bücherkataloge der Prager Universität / ediderunt Zuzana Silagiová, František Šmahel. Turnhout, 2015.. lxxv, 290 pages sg.: 15D119 Die feierliche Inauguration des Rectors der k.k. Franz-Josefs-Universität in Czernowitz für das Studienjahr 1893/94 am 4. October 1893 Czernowitz, 1894. 41 s. sg.: Ev/Ukrajina/Černov./1 Ermini, Giuseppe Storia dell' Universita di Perugia / Giuseppe Ermini Firenza, 1971. 2 sv. sg.: Ev/It/Perugia/2-1 Universität ohne Zukunft? Herausgegeben von Dorothee Kimmich und Alexander Thumfart Frankfurt am Main, 2004. 270 s. sg.: 17B6 Zwischenberger, Anton 250 Vetmeduni Vienna : 1768-2015 Verantwortung für Tier une Mensch / Autoren : Anton Zwischenberger und Matthias Georgi, Mitarbeit Heiko Schmidt München, 2015. 120 s. sg.: Ev/Ra/Vídeň/56 P e r i o d i k a : Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Plzeň, 2006-. Roč. 8 (2016), č. 2 sg.: 65F2/2016/2 Administrační zpráva hlavního města Prahy za léta 1908, 1909 a 1910. Díl I. Praha, 1919. 124 s. sg.: 77E2/1908-10 I. Administrační zpráva hlavního města Prahy za rok 1911 Praha, 1919. 456 s. sg.: 77E1/1911 Agrikultúra : zborník Poĺnohospodárskeho múzea v Nitre V Bratislave, 1962-1991. -

HISTORIA UNIVERSITATIS Carollnae PRAGENSIS PŘÍSPĚVKY K DĚJINÁM UNIVERSITY KARLOVY
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE 1975 HISTORIA UNIVERSITATIS CAROllNAE PRAGENSIS PŘÍSPĚVKY K DĚJINÁM UNIVERSITY KARLOVY TOMUS XV o FASC. 1 OBSAH Clánky 7 J a n M ar t í n e k, Neznámá báseň Jana Keplera [ Keplerovo blahopřání k magisterské promoci Melichara Mathebaea) 19 J a n Martíne k, Campanovo Protreptikon ad scholam Neudorfinam - pramen k dějinám předbělohorského školství 35 V ě r a S trn ad o v á, Vyučování přírodních věd na některých středoevrop ských universitách v 1. polovině 19. století 61 J a n G a 1 a n d a u e r, Dětství, mládí a studentská léta Bohumíra Šmerala Materiály 89 Události z 15. března 1848 v Praze v dopise studenta jeho učiteli. Jan N. Cžermak profesoru Janu E. Purkyňovi. V 1 ad i s 1 a v Kr u ta Referáty 105 Z nových prací k starším dějinám University Karlovy. [Ivan !--Haváček) 106 Universitat und Gelehrtenstand 1400-1800. [Hvr.J 108 Ján Hučko, Sociálne zloženie a póvod slovenskeJ obrodenskej inteligencie. [Hvr.J llO Hugh Kearney, Scholars a:nd Gentlemen. Universities and Society in Pre -Industrial Britain. 1500-1700. [ Hvr.) 111 Science and Society 1600-1900. Vydal Peter Mathias. [Hvr.J ll2 Bibliography of the History of Medicine 1964-1969. [ V. Kruta) 114 Helena Lipska - Kazimíra Tatarowicz, Bibliografia pismiennictwa de dzie jów Uniwersytetu Jagiellonskiego [Mi. S. - M. Kb.) 114 Eibliographie internationale de l'histoire des Universités [Mi. S. - M. Kb.) UNIVERSITA KARLOVA • PRAHA C:zzoiazyčné texty a souhrny ACTA UN!VERSITATIS CAROLINAE - HISTOKIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS 1975 Tomus XV - Fasc. 1 Pag. 7-17 11 Jan Martínek Den Matheba 1 ' uper reperto carmine quo Iohannes Keplerus Melchiori eo aurea secunda coronato applaudebat 13 J a n M a r t í n e k Ein u b k . -

The Domestication of History in American Art: 1848-1876
W&M ScholarWorks Dissertations, Theses, and Masters Projects Theses, Dissertations, & Master Projects 1998 The domestication of history in American art: 1848-1876 Jochen Wierich College of William & Mary - Arts & Sciences Follow this and additional works at: https://scholarworks.wm.edu/etd Part of the American Studies Commons, History of Art, Architecture, and Archaeology Commons, and the United States History Commons Recommended Citation Wierich, Jochen, "The domestication of history in American art: 1848-1876" (1998). Dissertations, Theses, and Masters Projects. Paper 1539623945. https://dx.doi.org/doi:10.21220/s2-qc92-2y94 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Theses, Dissertations, & Master Projects at W&M ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Dissertations, Theses, and Masters Projects by an authorized administrator of W&M ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. -
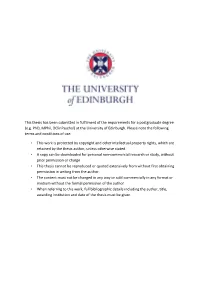
This Thesis Has Been Submitted in Fulfilment of the Requirements for a Postgraduate Degree (E.G
This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: • This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. • A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. • This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author. • The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. • When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. The Monument Question in Late Habsburg Austria A Critical Introduction to Max Dvořák’s Denkmalpflege Jonathan Blower Doctor of Philosophy The University of Edinburgh 2012 Abstract The present thesis is a critical introduction to a body of writings on heritage conservation by the Czech-born art historian Max Dvořák (1874–1921). From 1905 onwards, Dvořák was both professor of art history at the University of Vienna and Conservator General at the state institution responsible for heritage conservation in Austria: the ‘Royal and Imperial Central Commission for the Research and Preservation of Artistic and Historical Monuments’ (est. 1850). His published and archival texts on the subject are presented here for the first time in English translation. In this sense, the thesis follows the model of existing scholarship on the visual arts in Vienna around 1900, namely the combined English translations and critical introductions to the writings of Camillo Sitte (Collins & Collins, 1986), Otto Wagner (Mallgrave, 1988) and Alois Riegl (Forster & Ghirardo, 1982). -

Namenregister
Namenregister Personenregister Symbole *–* 417 *** 7 ca 311 -d. 97, 163, 218 - Dbr. K.- 352 -e. 72 -er- 56 - f - , d. i. Karl Joseph Kinderfreund (*1793) -g.- 197 *g****.* 142 – h‒ 255 - hl - 161 -l- 79, 380 -n. 217 -r. 382 -Randa 276 -Rdm.- 166 -rrr- 278, 284, 330, 368 -rrrr- 328 -t 288 -th- 346 -tzer 355 -z. 375 -ZKA- 11 A A. 93, 207, 208, 229, 305, 336, 400 A. C. 253 A. G. 409, 412 A. M. 13 A. S. 82, 97, 114, 124−126, 172 A. V. 215 Abaelardus, Petrus (1079–1142) 211 Abälard, d. i. Petrus Abaelardus (1079–1142) Aberli, Johann Ludwig (1723‒1786) 246 Achilles 282, 372 Adalbert (Heiliger), d. i. Vojtěch (Bischof von Prag) (ca. 956‒997) Adalbert (Bischof), d. i. Vojtěch (Bischof von Prag) (ca. 956‒997) Adam, Louis (1758‒1848) 29 Adlerstein, R. v., d. i. wohl Johann Janotykh von Adlerstein (*1811) 1 Adolph, d. i. Franz Adolph von Freenthal (1721‒1773) Adrian 361 Aeneas 265 Agricola, Christoph Ludwig (1667‒1719) 251 Albert, Moritz 221 Albrecht (Herzog von Friedland), d. i. Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein (1583‒1634) Albrechtsberger, Johann Georg (1736‒1809) 156 Aleth 329 Alkan, Charles Valentin (1813‒1888) 146 Allram, Babette (1794‒1872) 364, 365, 367 Alth, Minna von 362 Altmutter, Caroline 331 Alvisetti, Giulio (1786‒1868) 241 Ambros, August Wilhelm (1816‒1876) 128, 213 Ambrozi, Wenz. Bernh., d. i. Wenzel Bernhard Ambrozy (1723‒1806) Ambrozy, Wenzel Bernhard (1723‒1806) 259 Amerling, Friedrich von (1803‒1887) 278 Ammerling, d. i. Friedrich von Amerling (1803‒1887) André, Christian Carl (1787‒1835) 306 Angely, Louis-Jean-Jacques (1787‒1835) 374 Anschütz, d. -

The Construction of National Identity in the Historiography of Czech Art
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Enlighten: Theses THE CONSTRUCTION OF NATIONAL IDENTITY IN THE HISTORIOGRAPHY OF CZECH ART MARTA FILIPOVÁ A THESIS SUBMITTED TO THE UNIVERSITY OF GLASGOW FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ART August 2008 © Marta Filipová 2008 Abstract National identity can be expressed in many ways by individuals, groups and states. Since the nineteenth century, Central Europe has been undergoing rapid changes in the political, social and cultural spheres, which was reflected in the self-definition of the nations living in this region, and in their definition by others. The Czech people, who until 1918 were a part of the Austro-Hungarian Empire, gave birth to a national revival movement in the nineteenth century and eventually emancipated themselves to create an independent Czechoslovakia. The idea of „national identity“ was, therefore, crucial and this was enhanced in many areas of human activity, including the construction of a historical legitimacy for the nation. The struggle for recognition of the historical existence of the Czech nation was also projected into the discourse adopted for historical and contemporary art writing and exhibition practice. In this thesis, I focus on the ways in which Czech national identity was constructed in the historiography of art. I shall argue that the various ideologies which influenced the writers led to an understanding of Czech art as epitomising certain qualities of the Czech nation. At the same time, the Czech nation was presented as highly advanced because of its artistic achievements. -

Kunstgeschichte
Originalveröffentlichung in: Hehl, Ulrich von ; John, Uwe ; Rudersdorf, Manfred (Hrsgg.): Geschichte der Universität Leipzig 1409 – 2009. Fakultäten, Institute, zentrale Einrichtungen, Bd. 4,1. Leipzig 2009, S. 218-234 Kunstgeschichte Thomas Topfstedt, Frank Zöllner Die Geschichte des Instituts für Kunstgeschichte der Universität Leipzig ist vor allem für den Zeitraum zwischen 1933 und 1989 weitgehend unerforscht. Auf Archivrecher- chen gestützte Vörarbeiten existieren hauptsächlich über die erste Entwicklungsphase des Instituts im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert und zu den damaligen Lehrstuhl- inhabern. 1 Der hier folgende Abriß der Institutsgeschichte basiert auf diesen Vorarbeiten und auf den Ergebnissen einer 1997 von Frank Zöllner abgehaltenen Lehrveranstaltung zu den älteren Protagonisten der Leipziger Kunstgeschichte. Verdienstvoll ist des wei- teren die 2006 erschienene Studie von Christine Kratzke2 über das Kunsthistorische Institut der Universität Leipzig von 1945 bis 1958. Für weitere Projekte bietet das Universitätsarchiv Leipzig einen reichen Fundus bislang kaum genutzten Materials. Von der Gründung 1873 bis zur Zerstörung 1943 Die Gründung des Instituts für Kunstgeschichte an der Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig erfolgte im Jahre 1873. Es ist somit nach dem 1872 gegründeten Kunsthistorischen Institut der Bonner Universität das zweitälteste Institut dieser Art in Deutschland und zählt zu den weltweit wenigen kunsthistorischen Instituten, deren Gründungsdatum noch in das 19. Jahrhundert fällt. Der erste Lehrstuhlinhaber war der 1873 als Ordinarius für Geschichte der Mittleren und Neueren Kunst an die Philoso- phische Fakultät berufene Anton Heinrich Springer. 3 Er wurde 1825 in Prag geboren, wo er an der Universität von 1841 bis 1846 Philosophie und Geschichte studierte. Unter den Lehrern der ersten Generation des Faches Kunstgeschichte, das sich damals als univer- sitäre Disziplin zu etablieren begann, gehört er zu den herausragenden Persönlichkeiten. -

Max Liebermann - Sein Briefwechsel Mit Alfred Lichtwark
Max Liebermann - sein Briefwechsel mit Alfred Lichtwark - DISSERTATION zur Erlangung der Würde des Doktors der Philosophie der Universität Hamburg Birgit Pflugmacher aus Berlin Hamburg 2001 1. Gutachter: Prof. Dr. Hermann Hipp 2. Gutachter: Dr. Fritz Jacobs Tag des Vollzugs der Promotion: 7. Februar 2000 3 Inhaltsverzeichnis 3 Abkürzungsverzeichnis 4 - 5 Teil I Einleitung 7 - 8 Biographisches über Max Liebermann 9 - 11 Biographisches über Alfred Lichtwark 12 - 14 Max Liebermanns schriftliches Erbe 15 - 20 Erläuterungen zur Transkription des Briefwechsels 21 - 32 Das Verhältnis Max Liebermann zu Alfred Lichtwark 33 - 37 Liebermann - Ein ‘Meisterwerk’ Lichtwarks? 38 - 43 Teil II Der Briefwechsel 1 - 424 Teil III Quellen- und Literaturverzeichnis 1 - 12 Personenverzeichnis 13 - 27 Bildnisverzeichnis 28 - 38 Abbildungsnachweis 39 4 Abkürzungsverzeichnis Abb. Abbildung AKL Allgemeines Künstler Lexikon a. M. am Main Anm. Anmerkung/en BAT British American Tobacco bez. bezeichnet BSM Bayrische Staatsbibliothek München bzw. beziehungsweise cm Zentimeter Conn. Connecticut, USA DDR Deutsche Demokratische Republik ders. derselbe d.h. das heißt dies. dieselbe Diss. Dissertation Dr. Doktor dtv Deutscher Taschenbuchverlag E Eberle f. folgende FCP Foundation Custodia Paris ff. fortfolgende FN Fußnote geb. geborene Hrsg. Herausgeber Inv. Inventar Jg. Jahrgang KB Kunsthalle Bremen KH Kunsthalle Hamburg KK Kupferstichkabinet LAB Landesarchiv Berlin LB Lichwark-Briefe LBI Leo Baeck Institute LM Lichtwark-Mappe LO Lichtwark-Ordner M Mark n nach NF Neue Folge Nr. Nummer o. J. ohne Jahr o. O. ohne Ort o. S. ohne Seite o. V. ohne Verfasser PAK Preußische Akademie der Künste Berlin PK Preußischer Kulturbesitz 5 Penns. Pennsylvania, USA Prof. Professor RA Rijkmuseum Amsterdam S. Seite Sch Schellenberg SLD Stadt- und Landesbibiothek Dortmund S. -

František Schmoranz Le Jeune (1845-1892)
Mercedes Volait (dir.) Le Caire dessiné et photographié au XIXe siècle Publications de l’Institut national d’histoire de l’art František Schmoranz le Jeune (1845-1892) Milan Němeček Barbora Faure DOI : 10.4000/books.inha.4876 Éditeur : Publications de l’Institut national d’histoire de l’art, Picard Lieu d'édition : Paris Année d'édition : 2013 Date de mise en ligne : 5 décembre 2017 Collection : InVisu ISBN électronique : 9782917902806 http://books.openedition.org Édition imprimée Date de publication : 1 janvier 2013 Référence électronique NĚMEČEK, Milan. František Schmoranz le Jeune (1845-1892) In : Le Caire dessiné et photographié au XIXe siècle [en ligne]. Paris : Publications de l’Institut national d’histoire de l’art, 2013 (généré le 18 décembre 2020). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/inha/4876>. ISBN : 9782917902806. DOI : https://doi.org/10.4000/books.inha.4876. Ce document a été généré automatiquement le 18 décembre 2020. František Schmoranz le Jeune (1845-1892) 1 František Schmoranz le Jeune (1845-1892) Milan Němeček Traduction : Barbora Faure 1 L’architecte František Schmoranz le jeune (fig. 1), fondateur, concepteur et directeur de l’École des Arts décoratifs de Prague était à bout de forces lorsqu’il s’éteignit dans son bureau de l’École, le 11 janvier 1892. La célèbre publication Deutsche Bauzeitung écrivit à cette occasion que l’Autriche « perd en lui un de ses artistes les plus sensibles et l’architecture un de ses talents les plus originaux » et que, hormis l’architecte Franz pacha1 : « il n’est probablement guère d’artiste européen qui […] ait manifesté une connaissance aussi intime de l’art arabe et l’ait à ce point intégré a ses propres formes artistiques »2. -

Photo Archives and the Photographic Memory of Art History
Ca_00_Titelei_1-6_Ca_00_Titelei_1-6 12.05.11 13:00 Seite 1 Photo Archives and the Photographic Memory of Art History Edited by Costanza Caraffa Ca_00_Titelei_1-6_Ca_00_Titelei_1-6 12.05.11 13:00 Seite 2 Italienische Forschungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz Max-Planck-Institut I Mandorli Band 14 Herausgegeben von Alessandro Nova und Gerhard Wolf Ca_00_Titelei_1-6_Ca_00_Titelei_1-6 12.05.11 13:00 Seite 3 Photo Archives and the Photographic Memory of Art History Edited by Costanza Caraffa Ca_00_Titelei_1-6_Ca_00_Titelei_1-6 12.05.11 13:00 Seite 4 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Lektorat: Catherine Framm, Martin Steinbrück Herstellung: Jens Möbius, Jasmin Fröhlich Layout und Satz: Barbara Criée, Berlin Reproduktionen: LVD Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH Druck: AZ Druck und Datentechnik, Berlin Bindung: Stein + Lehmann, Berlin © 2011 Deutscher Kunstverlag GmbH Berlin München ISBN 978-3-422-07029-5 Ca_00_Titelei_1-6_Ca_00_Titelei_1-6 12.05.11 13:00 Seite 5 5 Summary Foreword 7 Dorothea Peters From Prince Albert’s Raphael Collection Photo Archives and the Photographic to Giovanni Morelli: Photography and Memory of Art History: the Project 9 the Scientific Debates on Raphael in the Nineteenth Century 129 Costanza Caraffa From ‘photo libraries’ to ‘photo archives’. Geraldine A. Johnson On the epistemological potential -
Lettere Inedite Di Giovanni Battista Cavalcaselle All'abate Pietro Mugna1869-1878
Giorgio Fossaluzza Lettere inedite di Giovanni Battista Cavalcaselle all’abate Pietro Mugna 1869-1878 Dalle informative feltrine all’edizione italiana della New History of Painting Lettere inedite di Giovanni Battista Cavalcaselle all’abate Pietro Mugna 1869-1878. Dalle informative feltrine all’edizione italiana della New History of Painting Lettere inedite di Questo volume viene Giovanni Battista pubblicato con il contributo Giorgio Fossaluzza Cavalcaselle all’abate del Dipartimento Culture Pietro Mugna 1869-1878. e Civiltà dell’Università Dalle informative feltrine degli Studi di Verona, all’edizione italiana della Fondi F.U.R. New History of Painting di GIORGIO FOSSALUZZA Lettere inedite di Giovanni Battista Cavalcaselle l’autore ringrazia si ringraziano per la Biblioteca civica Bertoliana Strossmayerova galerija starih in modo speciale preziosa e disponibile di Vicenza, Sala riservata majstora. Hrvatska akademija all’abate Pietro Mugna 1869-1878 collaborazione Sergio Merlo, Oreste Palmiero, znanosti i umjetnosti, Zagreb, Elena Necchi Barbara Dalla Pozza, Mattea Ljerka Dulibić Università degli Studi Klaus Kempf Gazzola, Stefano Beni Dalle informative feltrine all’edizione italiana di Pavia, per l’assistenza Corrado Viola Odsjek za povijest umjetnosti, generosa e sagace Tiziana Franco Biblioteca Nazionale Marciana Filozofski fakultet Sveučilišta, della New History of Painting nell’edizione dei documenti Francesca Rossi di Venezia, Susy Marcon Zagreb, Ana Munk Valerio Terraroli Michele Faustini Manuel Boschiero Archivio di Stato di Piacenza