Guida Dello Studente
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ecovillaggi: Esperienze Comunitarie Tra Utopia E Realtà
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Electronic Thesis and Dissertation Archive - Università di Pisa UNIVERSITÀ DI PISA DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA E SOCIOLOGIA DELLA MODERNITÀ Ecovillaggi: esperienze comunitarie tra utopia e realtà CANDIDATA Rossana Guidi TUTOR Prof. Mario Aldo Toscano Ciclo 2007-2009 1 L’utopia del futuro costruisce il presente. (Prigogine) 2 Indice: Introduzione…………………………………………………… p. 5. Parte I: Industrializzazione, capitalismo, modernità………...p. 12. 1.1 Nascita della società capitalistica moderna………………...p. 13. Parte II: Le avventure intellettuali e pratiche della comunità. ……………………………………………………………………p. 26. 2.2.1 Dissoluzione e resistenze della comunità………………... p. 26. 2.2.2 Tracce di comunità……………………………………..... p. 36. 2.2.3 Dalla comunità alla società: il pensiero degli autori classici della sociologia…………………………………..p. 41. Parte III: Il pensiero utopico e le sue realizzazioni……………p. 57 3.1 Socialisti utopisti……………………………………………..p. 57. 3.2 Comunitarismo americano…………………………………...p. 69. 3.3 Movimento Hippy……………………………………………p. 82. 3.4 Sviluppo sostenibile e nascita degli ecovillaggi…………….p. 86. Parte IV: Fenomenologia e geopolitica dell’ecovillaggio……p. 100. 4.1 Definizione di ecovillaggio…………………………… p. 100. 4.2 Ecovillaggi a confronto………………………………... p. 110. 4.2.1 Il metodo decisionale…………………………………...p. 113. 4.3.2 Organizzazione economica……………………………..p. 124. 4.3.3 Accorgimenti ecologici………………………………..p. 130. 3 4.3.4 Orientamento religioso………………………………...p. 138. 4.4 Ecovillaggi: tra utopia e realtà………………………....p. 140. 4.5 Contenuto razionalistico degli ecovillaggi…………….p. 151. 4.6 Breve quadro concettuale sulla disuguaglianza sociale..p. 168. Parte V: Punto applicativo e descrizione di un caso specifico: la comune di Bagnaia……………………………………….……p. -

Tv Shows, Feature Films & Documentaries
TV SHOWS, FEATURE FILMS & DOCUMENTARIES TITLES AVAILABLE DUBBED AND SUBTITLED IN SPANISH. INDEX INDEX TITLES AVAILABLE DUBBED ...And It’s Snowing Outside! 6 Grand Torino (The) 27 Storm (The) 14 Angel Of Sarajevo (The) 6 Hidden Vatican (The) 7 Terra Sancta: Guardians Of Salvation’s Source 25 Assault (The) 10 Imperium: Nero 19 Third Secret Of Fatima (The) 27 Bartali, The Iron Man 16 Imperium: Pompeii 19 Third Truth (The) 28 Borsellino, The 57 Days 12 Imperium: Saint Augustine 20 Turin’s Butterfly 11 Boss In The Kitchen (A) 9 Imperium: Saint Peter 20 Wannabe Widowed 12 Bright Flight 13 Lady Of The Camellias 21 Caravaggio 16 Long Lasting Youth 21 Claire & Francis 17 Maria Goretti 28 Countess Of Castiglione (The) 25 Marriage (A) 8 Curfew - Don Pappagallo (The) 26 Mearshes Intrique (The) 22 Displaced Child (The) 11 My House Is Full Of Mirrors 15 Don Zeno 17 Oro Di Scampia (L’) 7 Fear Of Loving 1, 2 9 Over The Shop 13 Francesco 22 Pompeii, Stories From An Eruption 23 Frederick Barbarossa 15 Resurrection 23 Giovanni Falcone, The Judge 18 Saint Bakhita 24 Girls Of San Frediano (The) 26 Scent Of Love 14 Giuseppe Moscati, 18 Song’e Napule 10 Good Season (A) 8 Star Of Bethlehem 24 Credits not contractual Credits INDEX TITLES AVAILABLE SUBTITLED Anija 36 Lonely Hero (A) 42 Away From Me 33 Smile Of The Leader (The) 35 Balancing Act (The) 37 Song’e Napule 34 Black Souls 31 Triplet (The) 39 Caesar Must Die 36 Viva La Libertà 35 Cardboard Village (The) 40 Chair Of Happiness (The) 34 Darker Than Midnight 31 Dinner (The) 32 Easy 40 Entrepreneur (The) 41 -

Nome DE VREESE LUC PIETER Indirizzo 210/1, VIA DON ZENO
F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome DE VREESE LUC PIETER Indirizzo 210/1, VIA DON ZENO SALTINI, 41123 MODENA, ITALIA Telefono +39 3396447373 E-mail [email protected]; [email protected] Nazionalità Belga (con residenza anagrafica e fiscale in Italia) Data di nascita 23/02/1958 ESPERIENZA LAVORATIVA • Date (da – a) DA MARZO 2016 (ANCORA IN CORSO) • Nome e indirizzo del datore di Fondazione Luigi Boni Onlus, Viale Luigi Cadorna, 4 46029 Suzzara (MN lavoro • Tipo di azienda o settore Terzo Settore: Servizi (semi)residenziali e domiciliari socio-sanitari • Tipo di impiego Medico Libero professionista (fino al 30/09/2016) - Dirigente Medico (CCNL Dirigenti Sanità Pubblica Area IV a tempo indeterminato e a tempo parziale 30 ore settimanali) • Principali mansioni e responsabilità − Medico Referente RSA 2 (p.l. 80) e del Centro Diurno Integrato (20 posti) della Fondazione Luigi Boni Onlus (fino al 31/05/2018) − Direttore Sanitario della Fondazione Luigi Boni Onlus che ha le seguenti U.d.O.: RSA1 (85 p.l.); RSA2 (p.l. 80); CDI (20 posti); ADI; RSA aperta e Poliambulatorio (dal 1/06/2018) Referente COVID (da Aprile 2020) − − Visite psicogeriatriche ambulatoriali o domiciliari in libera professione • Date (da – a) DAL 1/03/2018 AL 31/12/2020 • Nome e indirizzo del datore di Cooperativa Sociale Villa Maria (Disabilità Intellettiva Adulta e Anziana), Via Castelbeseno, 8 lavoro 38060 Calliano (TN) • Tipo di azienda o settore Terzo Settore: Residenze Socio-Sanitarie • Tipo di impiego Direttore Sanitario con contratto libero professionale (fino al 06/01/2020) – Direttore Sanitario a tempo determinato “acausale” – categoria “Q” (Quadri) per una prestazione media complessiva di 8 ore settimanali • Principali mansioni e responsabilità Direttore Sanitario delle 2 residenze socio-sanitarie (Villa Maria a Calliano 42 p.l. -

Michele Ranchetti
Archivio Michele Ranchetti Biografia Marco Pacioni Elenco analitico dei documenti Rita Romanelli Archivio Michele Ranchetti Biografia Marco Pacioni Elenco analitico dei documenti Rita Romanelli SOMMARIO Biografia di Michele Ranchetti (M. Pacioni)1* pag. 7 Bibliografia (M. Pacioni) pag. 15 L’archivio di Michele Ranchetti (R. Romanelli) pag. 21 Elenco analitico dei documenti (R. Romanelli) pag. 23 Corrispondenza pag. 23 Poesie pag. 24 Appunti manoscritti pag. 25 Testi dattiloscritti e a stampa pag. 28 Dattiloscritti su storia e cristianesimo pag. 28 Dattiloscritti su autori e testi pag. 29 Dattiloscritti su Freud e psicanalisi pag. 30 Saggi e articoli di Michele Ranchetti pag. 31 Saggi su Michele Ranchetti e interviste pag. 31 Testi di e su Ranchetti degli ultimi anni pag. 33 Temi di studio pag. 35 Diodati pag. 35 Padri della chiesa pag. 36 Antico e nuovo testamento pag. 37 Storia della Chiesa - Papi, concilii pag. 37 Pascal pag. 38 Catechismi – Schelling – S. Paolo pag. 39 Lutero pag. 41 Modernismo pag. 43 Pensiero religioso – ebraismo pag. 43 Storia della chiesa – Università pag. 45 Legislazione ecclesiastica pag. 45 Filosofia, logica e teologia – autori A-Z pag. 45 Benjamin e Scholem pag. 50 Taubes e Schmidt pag. 51 Heidegger pag. 51 Bultmann e Barth pag. 52 Bonhoeffer pag. 52 Fonti di filosofia e logica pag. 52 Wittgenstein pag. 53 Freud e psicoanalisi pag. 56 Dattiloscritti su Freud pag. 57 Freud e Fliess pag. 58 Freud e Ranck pag. 58 Psicologia e psicoanalisi pag. 58 Copie di saggi editi su Freud pag. 59 1 * La biografia è la versione più estesa della voce Michele Ranchetti scritta da Marco Pacioni per il Dizionario Biografico degli Italiani – Treccani. -

Don Zeno Saltini
DON ZENO SALTINI Fossoli, 30 agosto 1900 - Grosseto, 15 gennaio 1981 è stato il presbitero italiano, fondatore della comunità Nomadelfia. a cura di Lucio Bregoli Circolo Acli - Vittorio Loda - Villaggio Prealpino 1900 - LA FAMIGLIA DI DON ZENO 30 agosto 1900. A Fossoli di Carpi (MO), in una benestante famiglia patriarcale, da Cesare Saltini e Filomena Righi nasce Zeno. È il nono di dodici figli. La famiglia di don Zeno Saltini nel 1916. Zeno è il primo seduto a sinistra Tra questi Marianna, conosciuta come Mamma Nina (1889-1957), farà nascere a Carpi la Casa della Divina Provvidenza che si occupa di ragazze in stato di abbandono. Marianna Saltini con in braccio una piccola abbandonata Il fratello don Vincenzo (1896-1961) darà vita all’Istituto degli Oblati, per formare sacerdoti in grado di divenire educatori nei seminari; Anita entrerà nel monastero delle Clarisse di Carpi con il nome di suor Scolastica. Don Vincenzo Saltini Monastero delle Clarisse di Carpi 1914 - IL RIFIUTO DELLA SCUOLA A 14 anni e mezzo Zeno rifiuta di andare a scuola, strappando il permesso al padre con l’intervento del parroco, don Sisto Campagnoli, che sempre lo comprenderà e lo aiuterà. Sostiene che a scuola inse- gnano cose che non incidono sulla vita. 1912. Zeno in mezzo alla sua classe in 5ª elementare (al centro) Il padre lo manda a lavorare nei poderi della famiglia, vive in mezzo ai braccianti e ne condivide le giuste aspirazioni. Ha così modo di entrare a contatto con la dura realtà dei braccianti da cui imparò le teorie socialiste. Zeno al lavoro nei campi Una delle numerose cooperative agricole dell’Emilia Romagna Mezzo di trasporto preferito dal giovane Zeno 1920 - LA DISCUSSIONE CON L’ANARCHICO A 17 anni è chiamato sotto le armi, durante la prima guerra mondiale, e presta servizio militare fino al marzo del 1919. -

Linda Bimbi a Faith in Human Rights
Chiara Bonifazi Linda Bimbi A Faith in Human Rights Introduction by Luciana Castellina Chiara Bonifazi Linda Bimbi A Faith in Human Rights Introduction by Luciana Castellina Afterword by Sergio Poeta Fondazione Lelio e Lisli Basso ISSOCO © 2016 Via Della Dogana Vecchia n. 5 - 00186 Roma tel. 06/6879953 - fax 06/68307516 www.fondazionebasso.it - [email protected] Front cover: 1966, pupils from the Colégio Helena Guerra in front of the school English translation by Ruth Taylor of the book by Chiara Bonifazi, Linda Bimbi. Una vita tante storie, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2015. Index 5 Introduction by Luciana Castellina 17 Foreword 23 I. The long journey towards rights 25 1. The background to the story 27 2. The true meaning of life 36 3. The tale of the communist nuns 51 4. The transition 61 5. Anonymity 69 6. Two opposite shores 84 7. The dawn of a new age 98 8. The thrill of the future 107 II. References 109 1. Community 114 2. Chronology 120 3. Historical background 133 4. Biographies. Linda’s encounters 157 5. Linda’s writings 159 Afterword, by Sergio Poeta 167 Bibliography 169 A story in images Introduction by Luciana Castellina When I first met LInda, I was totally unprepared. I mean that when I saw and heard her for the first time, I knew nothing about her, and we had never been introduced. And if I hadn’t happened to come across her again, and then got to know her properly, I wouldn’t even have remembered that fleeting encoun- ter years before. -
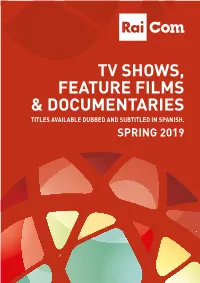
Tv Shows, Feature Films & Documentaries
TV SHOWS, FEATURE FILMS & DOCUMENTARIES TITLES AVAILABLE DUBBED AND SUBTITLED IN SPANISH. SPRING 2019 DUBBED DUBBED 5 DETECTIVE MONTALBANO 1-32 IL COMMISSARIO MONTALBANO 1-32 DIRECTOR: Alberto Sironi Starring: Luca Zingaretti Based on the novel by the Italian writer and sceenwriter Andrea Camilleri, the intriguing crime series “Detective Montalbano” stars Luca Zingaretti in the role of a Sicilian detective acting in the ancient, sunwashed Sicilian province of Ragusa as well as in the breathtaking surrounding countryside. Each episode of the series focuses on Montalbano’s personal war against his professional ideals, his commitment to his beautiful long-distance girlfriend and his constant flirtation with the ultimate temptress, Italian cuisine, making this crime series one of the best product of contemporary Italian fiction. RAI FICTION - PALOMAR DETECTIVE - CRIME - TV MOVIES - HD - 32X100’ - 1999/2018 NOTE DUBBED 7 MATTEO MESSINA DENARO, THE LAST GODFATHER MATTEO MESSINA DENARO DIRECTORS: Riccardo Iacona, Danilo Procaccianti, Fabrizio Lazzaretti An extraordinary investigation into the 21 years of the last standing of the big boss of Mafia, still not brought to justice, Matteo Messina Denaro. Convicted to life sentence for the murders of 1993, he has since then disappeared. The story of his role in the alleged negotiations State-Mafia and his close relationship with Totò Riina, the investigation for his immense assests that allowed the seizure of property for a value of over 4 billion euro, the strikes of law enforcement agencies that have gradually made scorched earth around him, until the dramatic arrest of her sister Patrizia. The story of Matteo Messina Denaro, the boss of Castelvetrano, with exclusive testimonies and previously unpublished documents. -

Orientation Shares Svdp Ministry with Local Parishes After Long Illness from Page 1 of My Life, Because It Aff Ects Our Forming Svdp Groups
ISSN: 0029-7739 $ 1.00 per copy THE BSERVER OOfficial Newspaper of the Catholic Diocese of Rockford Volume 82 | No. 26 http://observer.rockforddiocese.org FRIDAY JUNE 9, 2017 Inside Jubilarians Priests process into the annual Jubilarian Mass. Read the biographies of priests and sisters who are celebrating anniversaries of holy orders or final vows. pages 8-13 Quick News Msgr. Nelson and retiring DPC members DPC Members End (Observer photos/Lynne Conner) Terms at June Meeting Ron Toti and Barb Frampton of St. James, Rockford take part in a small ing an Ozanam Orientation to the St. Vincent de Paul ministry. Holy group discussion with Bob McLaughlin of Holy Family, Rockford, dur- Family Parish hosted the June 3 workshop. Msgr. Glenn Nelson (above left), Vicar General and Moderator of the Curia posed at the June 3 meeting with Diocesan Pastoral Council Orientation Shares SvDP members who are ending their service this year. With him are (from left) Cindy Augustine, representing the Aurora Deanery; Gerri Ministry with Local Parishes Navarro, appointed by Bishop Thomas G. Doran; BY LYNNE CONNER parish are always looking for innovative Beth Swanson, of the Observer Correspondent ways to help the needy. DeKalb Deanery; and Gerry “Since last year, we have had a garden Williamson, representing ROCKFORD—Ministering to the poor to grow fresh vegetables for the needy in the Sterling Deanery. Also while growing spiritually are just two of our area. We also do prison visits to near- concluding their terms the many blessings connected with the out- by correctional facilities, we have a food on the council but not reach of the St. -

The Italian American
The Original “The Strong Voice” Originators of “Festa Italiana” The Italian American in Florida Social Club at Palm Coast, Florida 45 Old Kings Road North ~ Palm Coast, Florida 32137 ~ 386-445-1893 Charter Member Visit our website: www.iascpc.com F.F.I.A.C. Member September/Settembre 2012 Volume XXXVIII, Issue #9 Message from the President In this issue: President’s Message ....... FC* Upcoming Events .......... 2 Hello Members, Birthday/Anniversaries... 3 My board and I want to thank you for attending our general meeting. We finally had a Meeting Highlights ........ 4 quorum to accept our new board members in! Congratulations to Anita, Al and Bob. As you know, we are a working board. We volunteer many hours to making our club be New Members................. 4 efficient for you, the members. Please be patient with us. There are many things that we have to accomplish yet. Health & Welfare ........... 4 I want to welcome Tony Mongone as our Chef. He has made some significant changes Pot of Gold .................... 4 to our menus and received many, many compliments on his food. If you haven’t eaten here since Tony has been with us, please make every effort to do so. You will NOT be Heritage ......................... 5 disappointed. Also, Alberto is our Pizza maker and he is doing a good job. Boosters ......................... 6 The treasurer gave a report that our finances are down for July. However, we will be picking up again come September when many of our members come back to town. Advertisers ..................... 7 We have some fantastic social events coming up also. -

Liberation Theology in Europe La Teología De La Liberación En Europa
Multilingualissue Liberation Theology in Europe La Teología de la Liberación en Europa By: Stefan SILBER & José María VIGIL (coords.), C. Ackermann, F. BArbero, B. Domingues, J. Estermann, B. Forcano, Ph. Geitzhaus, B. Kern, J. Lis, L. Martínez, B. Offenberger, F. Scalia, P. Schönhöffer, S. VIllamayor ecumenical association of third world theologians Volume XL 2017/2 New Series November-December 2017 Liberation Theology in Europe La Teología de la Liberación en Europa VOICES Release 1.0 http://eatwot.net/VOICES Liberation Theology in Europe La Teología de la Liberación en Europa http://eatwot.net/VOICES https://eatwot.academia.edu/EATWOT Ecumenical Association of Third World Theologians Association Oecuménique des Theologiens du Tiers Monde Asociación Ecuménica de Teólogos/as del Tercer Mundo VOICES, Theological Journal of EATWOT, the Ecumenical Association of Third World Theologians New Series, Volume XL Number 2017/2, November-December 2017 Free Digital Printable Multilingual Edition Release 1.0 of December 26, 2017, ISSN: 2222-0763 - Dossier's Editors for this VOICES issue: Stefan Silber and José María Vigil - Lay out by Lorenzo Barría - Cover on original design of Maximino Cerezo Barredo EATWOT's Editorial Team: Gerald Boodoo (USA), Ezequiel Silva (Argentina), Arche Ligo (Philippines), Adam K. arap Checkwony (Kenya), Kemdirim Protus (Nigeria), Intan Darmawati (Indonesia) and Michel Andraos (USA). VOICES' General Editor: José María Vigil If you want to print this whole Journal on paper for a local edition, please, contact the EATWOT asking for full resolution printable originals. All the articles of this issue can be reproduced freely, since given the credit to the source. You can download VOICES freely, at: http://eatwot.net/VOICES or at EATWOT's publications' site: https://eatwot.academia.edu/EATWOT EATWOT Ecumenical Association Of Third World Theologians Asociación ecuménica de Teólogos/as del Tercer Mundo ASETT EATWOT's web addresses: All EATWOT's addresses..................................eatwot.net Institutional:........................ -
BUILDING SOLIDARITIES Racial Justice in the Built Environment
BUILDING SOLIDARITIES Racial Justice in the Built Environment Building Solidarities is a form of mutual pedagogy between the campus and the public, through dialogues on urgent questions about constructed environments, urban life, and ecologies. Building Solidarities: Racial Justice in the Built Environment foregrounds the communities of Minneapolis, Nairobi, and New York, in dialogues between students, activists, artists, and academics. While building mutual solidarities between our campus and our partners, we aim to extend the political imaginaries, community futures, and solidarities that our partners may build with each other. As we study racial and environmental complexities and injustices, we remain vigilantly reflexive about the relationship between our campus and our neighbors, in Harlem and elsewhere. The series is supported by the course “Colonial Practices,” taught by Anooradha Iyer Siddiqi. Web/podcasts are hosted by community organizations. To receive a research guide and link to attend, register by emailing the event title and date to [email protected]. Institutional Inhabitations 4:30-5:30 PM EST, September 23 2020 Guests: The GoDown Arts Centre and Navatman On structuring cultural institutions and critical communities of black-brown solidarity in the African and South Asian diasporas of Nairobi and New York. Web/podcast by the GoDown Arts Centre (www.thegodownartscentre) and Navatman (www.navatman.org). Building Historical Consciousness 4:30-5:30 PM EST, October 14 2020 Guests: Chris Cornelius, Elsa Hoover, and Nick Estes Indigenous thinking on infrastructure and architecture as sites for historical consciousness and contemporary creative practice in North America. Web/podcast by The Red Nation (www.therednation) Monumental Landscapes 4:30-5:30 PM EST, November 11 2020 Guests: Kate Beane, Lydia Muthuma, and Bhakti Shringarpure A consideration of landscapes of monumentality through iconoclasm, replacement, and renaming of built and natural structures in Nairobi and Minneapolis. -

Biografia Di Zeno Saltini a Cura Di Remo Rinaldi Don Zeno Saltini, Uno Dei Grandi Preti D'avam
Biografia di Zeno Saltini a cura di Remo Rinaldi www.testimonidelnostrotempo.it Don Zeno Saltini, uno dei grandi preti d’avamposto della stagione preconciliare, è anche il più misconosciuto. Nasce a Fossoli di Carpi (Modena) nel 1900, in una ricca famiglia di agricoltori e proprietari terrieri. Nella prima adolescenza abbandona gli studi, ritenuti estranei alla vita, per dedicarsi al lavoro nei poderi di famiglia, a contatto con i problemi reali dei braccianti e degli operai. Ben presto constata la miseria di gran parte del popolo e vive in modo conflittuale la propria condizione di figlio di ricchi possidenti terrieri. Durante il servizio militare di leva, a Firenze, sostiene una violenta discussione con un commilitone anarchico, il quale afferma che Cristo e la Chiesa sono di ostacolo al progresso e i cristiani non sono coerenti con il Vangelo. Zeno non riesce a controbattere efficacemente, perché l’anarchico ha studiato, porta esempi storici. Profondamente umiliato, si isola in una stanza a piangere e a riflettere. Lì ha una folgorazione, non del tutto spiegabile psicologicamente: subisce un tremendo “pizzico di Dio sulla coscienza”. Da questo momento Zeno decide di cambiare civiltà iniziando da se stesso. Congedato, riprende gli studi. Il parroco di Fossoli lo aiuta e lo addestra a considerare i problemi sociali nell’ottica evangelica. Conseguita la maturità, si iscrive a giurisprudenza. Nel contempo si dedica, per alcuni anni, a un’intensa attività di apostolato tra i giovani. E’ presidente diocesano della Gioventù cattolica. Il vescovo di Carpi, Giovanni Pranzini, lo aiuta a risolvere i problemi religiosi e sociali che lo agitano.