ITALIANO & OLTRE 2000 N. 5
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Neapel, Fotbollen Och Språket Översättning Av Kulturella Referenser Och Dialekt
EXAMENSARBETE VT 2013 MAGISTER I ÖVERSÄTTNING DEL 2: ANALYS Språk- och litteraturcentrum Översättarutbildningen Neapel, fotbollen och språket Översättning av kulturella referenser och dialekt Författare: Handledare: Kristoffer Petersson Mari Mossberg, svenska Verner Egerland, italienska Sammandrag Denna magisteruppsats grundar sig på två kapitel samt förordet i boken Il Napoli di Maradona. Cronistoria di un sogno: il primo scudetto av Gigi Garanzini och Marco Bellinazzo. Uppsatsen inleds med en analys av källtexten som utgår ifrån Hellspong & Ledins analysmodell (1997). Därefter följer en kortare redogörelse för de överväganden jag gjort inför översättningsarbetet, med utgångspunkt i Lita Lundquists lokala och globala översättningstrategier (2005), samt en översättningskommentar, där jag behandlar dialektala inslag och mottagaranpassning. Nyckelord Gigi Garanzini, Marco Bellinazzo, Neapel, dialekt, neapolitanska, kulturkontext, napoletanità, mottagaranpassning Engelsk titel Naples, language and football – perspectives on cultural context and dialect in translation 2 Innehåll 1. Inledning..........................................................................................................................................4 2. Källtextanalys.................................................................................................................................4 2.1 Presentation av källtexten..........................................................................................................4 2.2 Sändare och mottagare..............................................................................................................5 -

Esimio Prof. Zangrillo, Ma Il Coronavirus Non Era Clinicamente Morto? Di Redazione 4 Settembre 2020
THEVISION.COM Data 04-09-2020 Pagina Foglio 1 / 8 ESIMIO PROF. ZANGRILLO, MA IL CORONAVIRUS NON ERA CLINICAMENTE MORTO? DI REDAZIONE 4 SETTEMBRE 2020 Share Tweet Negli ultimi giorni sta diventando sempre più chiaro che la pandemia di COVID-19 è ben lontana dalla sua conclusione: alcune aree del mondo, come gli Stati Uniti e il Brasile, sono ancora nel pieno della prima ondata, anche e soprattutto a causa di politiche confuse o volutamente assenti sul contenimento dei contagi. In Europa, invece, Spagna, Germania e Francia registrano un aumento di nuovi casi che potrebbe presagire l’inizio della seconda ondata. Anche in Italia si registrano sviluppi preoccupanti: dopo un periodo in cui i nuovi contagi si erano stabilizzati sul centinaio di casi giornalieri, con pochi focolai subito individuati e tenuti sotto 130589 controllo, nell’ultimo mese si è verificato un nuovo aumento, tanto che dal 13 agosto, con i suoi 523 casi registrati a livello nazionale, siamo passati in meno di tre settimane ai 1397 nuovi casi giornalieri del 3 settembre. THEVISION.COM Data 04-09-2020 Pagina Foglio 2 / 8 Una delle cause è di sicuro il maggior movimento di persone in un periodo tradizionalmente legato agli spostamenti e alle ferie estive, che hanno comportato anche un progressivo rilassamento nell’utilizzo delle tre principali misure di prevenzione del contagio: il lavaggio frequente delle mani, il distanziamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione. Il caldo e l’atmosfera delle ferie però non bastano per giustificare questa tendenza; la vera minaccia per gli sforzi fatti nei primi mesi dell’anno si chiama negazionismo. -

Distrarsi E Divertirsi 79
LEZIONE 3 DistrarsiDistrarsi ee divertirsidivertirsi a vita di tutti i giorni è frenetica e faticosa. Ognuno dovrebbe trovare del tempo da L dedicare al proprio corpo e allo spirito. Fare una passeggiata in centro e distrarsi facendo compere. Incontrare gli amici al caffè e fare due chiacchiere. Rilassarsi in casa con un bel libro o davanti ad un film. Andare in palestra ed allenare il corpo. Ognuno è diverso e dà sfogo allo stress della routine in modo diverso. Tu che cosa preferisci? Quale attività ti rilassa e ti dà la carica giusta per affrontare una nuova giornata piena di impegni? intit_l03_lo_pp78_79_sl.indd 78 8/31/2009 9:08:54 AM INTIT PDF PAGES SL 03 SOMMARIO 82 CORTOMETRAGGIO Cosa determina la nostra identità? Quali caratteristiche ci rendono unici? Un bambino delle elementari con un talento particolare cerca le risposte in Bulli si nasce, del regista Massimo Cappelli. 88 IMMAGINA Firenze e la Toscana sono uno dei tuoi 85 sogni? Finalmente farai una gita nella capitale dell’arte rinascimentale, scoprirai come nasce la Vespa e navigherai tra le isole dell’Arcipelago Toscano. 105 CULTURA È noto che gli italiani amano il calcio. Ma sapevi che la passione per uno sport può a volte influenzare la cultura, la politica e la mentalità di un’intera nazione? Leggi l’articolo Rete! e vivi la passione. 106 109 LETTERATURA Nel racconto La chitarra magica, Stefano Benni propone una fiaba con un finale a sorpresa. 80 PER COMINCIARE 90 STRUTTURE 3.1 The passato prossimo with avere and essere Destinazione: 3.2 The imperfetto Toscana 3.3 The passato prossimo vs. -

Sommario Rassegna Stampa
Sommario Rassegna Stampa Pagina Testata Data Titolo Pag. Rubrica Legavolley - stampa 43 Alto Adige 30/01/2017 LORENZETTI: "NON E' FACILE SPINGERSI OLTRE IL LIMITE" 3 45 La Stampa 30/01/2017 TRENTO SCHIACCIATA GRAZIE AGLI EX CIVITANOVA SI PRENDE LA 4 COPPA DEL VOLLEY (R.Condio) Rubrica Volley: A1 e A2 maschile 42/43 Alto Adige 30/01/2017 FESTEGGIA LA LUBE CIVITANOVA E' TROPPA PER QUESTA DIATEC 5 42 Alto Adige 30/01/2017 STOKR E' L'ULTIMO AD ARRENDERSI, BENE GIANNELLI ED I 7 CENTRALI 43 Alto Adige 30/01/2017 LA BATTUTA, SEMPRE PIU' DECISIVA 8 43 Alto Adige 30/01/2017 SETTIMA FINALE DI COPPA, EPOPEA UNICA IN ITALIA 9 35 Corriere della Sera 30/01/2017 JUANTORENA DOMINA CIVITANOVA BATTE TRENTO E SOLLEVA LA 10 COPPA ITALIA LA FESTA DEL C.T. BLENGINI (E.Cozzari) 19 Corriere delle Alpi 30/01/2017 VOLLEY, CIVITANOVA BRINDA IN COPPA 11 27 Corriere dello Sport Stadio 30/01/2017 LA LUBE FESTEGGIA LA SUA CINQUINA IN COPPA ITALIA 12 42 Gazzetta di Modena Nuova 30/01/2017 COPPA ITALIA ALLA LUBE, LA TERZA PER CASADEI 13 24 Il Gazzettino 30/01/2017 COPPA ITALIA. TRENTO SI ARRENDE LA LUBE BRINDA PER LA 14 QUINTA VOLTA 23 Il Giornale 30/01/2017 COPPA ITALIA A CIVITANOVA BATTUTA TRENTO IN 4 SET 15 43 Il Piccolo 30/01/2017 DIATEC SCONFITTA CUCINA LUBE VINCE LA COPPA ITALIA 16 17 Il Resto del Carlino 30/01/2017 SPORT - CIVITANOVA, QUINTA SINFONIA 17 1 La Gazzetta dello Sport 30/01/2017 COMANDA JUANTORENA LA COPPA ITALIA A CIVITANOVA 18 1 L'Adige 30/01/2017 DIATEC, NIENTE DA FARE COPPA ITALIA ALLA LUBE 22 21 L'Adige 30/01/2017 LUBE, OSMANY SULLA COPPA 25 23 -

Italian Politics & Society
Italian Politics & Society The Review of the Conference Group on Italian Politics and Society #70 |Spring 2012 General Editor Christophe Roux (University of Montpellier 1, France) [email protected] CEPEL – Faculté de droit et de science politique |39 rue de l’Université 34060 Montpellier cedex 2 (France) | Ph.: +33-434432842 | Fax: +33-434432857 Book Review Editor Jeffrey Hamill, University of Florida [email protected] Department of Political Science | 234 Anderson Hall | P.O. Box 117325 Gainesville, FL 32611 (USA) | Ph: 352 392-0262 | Fax: 352 392-8127 Managing Editors Alessandro Cagossi (West Virginia University), Jeffrey Hamill, Christophe Roux CONGRIPS President Simona Piattoni (University of Trento, Italy) [email protected] Vice-President Amie Kreppel (University of Florida) [email protected] Executive Secretary Richard Katz (The Johns Hopkins University) [email protected] Program Chair (until 2012) James Newell (University of Salford, UK) [email protected] Executive Committee Mabel Berezin (Cornell University) Maurizio Carbone (University of Glasgow, UK) Vincent Della Sala (University of Trento, Italy) Daniel Ziblatt (Harvard University) Eleonora Pasotti (University of California, Santa Cruz) Gianfranco Pasquino (ex-officio as SISP President, University of Bologna, Italy) Group Liaison Officers with European Politics/Policy Groups For North America: Raffaella Nanetti (Illinois University at Chicago, USA) [email protected] For Europe: Marco Brunazzo (University of Trento, Italy) [email protected] CONGRIPS -

Rassegna Del 15/04/2019
Rassegna del 15/04/2019 CAMPIONATO SUPERLEGA 15/04/19 Adige 25 Candellaro: «Siamo pronti» Baldo Nicola 1 15/04/19 Alto Adige 45 Itas agile in semifinale da domani con la Lube ... 3 15/04/19 Dolomiten 36 Fokussiert zum Minimalziel - Concentrato sull'obiettivo minimo ah 4 15/04/19 Gazzetta di Modena 41 Domani gara 1 a Trento tra Itas e Lube ... 5 15/04/19 Trentino 24 L'Itas non si vuole accontentare Di Giangiacomo Maurizio 6 15/04/19 Tuttosport 44 Kovacevic ritrovato la Haak è esplosiva ... 8 WEB 14/04/19 IT.WORLDPRONEWS.C 1 Volley, Perugia e Trento non sbagliano la bella: è semifinale ... 9 OM 14/04/19 MARCHENOTIZIE.IT 1 Volley, Lube-Trento sarà la Semifinale Scudetto ... 11 15-APR-2019 da pag. 25 Dir. Resp.: Alberto Faustini foglio 1 / 2 www.datastampa.it Tiratura: 25445 - Diffusione: 20463 - Lettori: 198000: da enti certificatori o autocertificati Superficie: 60 % 4 art CAMPIONATO SUPERLEGA 1 15-APR-2019 da pag. 25 Dir. Resp.: Alberto Faustini foglio 2 / 2 www.datastampa.it Tiratura: 25445 - Diffusione: 20463 - Lettori: 198000: da enti certificatori o autocertificati Superficie: 60 % 4 CAMPIONATO SUPERLEGA 2 15-APR-2019 da pag. 45 Dir. Resp.: Alberto Faustini foglio 1 www.datastampa.it Tiratura: 11241 - Diffusione: 9509 - Lettori: 120000: da enti certificatori o autocertificati Superficie: 5 % 4 art CAMPIONATO SUPERLEGA 3 15-APR-2019 da pag. 36 Dir. Resp.: Toni Ebner foglio 1 www.datastampa.it Tiratura: 44286 - Diffusione: 43010 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati Superficie: 6 % 4 art CAMPIONATO SUPERLEGA 4 15-APR-2019 da pag. -

Tuttosport 21 Febbraio 2020
Fondatore RENATO CASALBORE Venerdì 21 febbraio 2020 ANNO 75 · N. 51 € 1,50* IN ITALIA WWW.TUTTOSPORT.COM FINALMENTE ERIKSEN E LA ROMA SCOPRE PEREZ EUROPA LEAGUE, ANDATA SEDICESIMI: L’INTER VINCE IN BULGARIA COL PRIMO GOL DEL DANESE E IL RIGORE DI LUKAKU (2-0). 1-0 GIALLOROSSO CONTRO IL GENT FIRMATO DAL RINFORZO DI GENNAIO Christian Eriksen, 28 anni CARINA, MASINI, PASQUINO, SCACCHI, SCURATI E IL COMMENTO DI DAMASCELLI ALLE PAGG. 2/3/4/5 Carles Perez, 22 anni ATALANTA DA APPLAUSI: IMPRESE E NUOVE RISORSE L’ORO DELLA DEA CHAMPIONS, GIÀ 50 MILIONI ALTRI 13 SONO A UN PASSO GENNARI, LANZO, SABATINI ALLE PAGG. 6/7 RAMSEY CHIAVE PER La formazione dell’Atalanta che ha travolto il Valencia 4-1 IL PRESIDENTE GRANATA: «NON CEDO LA SOCIETÀ» «BELOTTI RESTA» TORO, CAIRO PROMETTE «IL GALLO NON VA A NAPOLI» POGBA BARETTI, FORTE, GERVASI, PAVAN ALLE PAGG. 20/21/22/23 IL MANCHESTER UNITED PIOMBA SUL GALLESE, CHE PUÒ DIVENTARE UN’IMPORTANTE CONTROPARTITA TECNICA PER IL FRANCESE. ESCLUSIVA CON IL PRESIDENTE DEL LIONE: «SE LA Andrea Belotti, 26 anni, 178 partite e 85 gol con il Toro JUVE CI BATTE, VINCE LA CHAMPIONS» Aaron Ramsey, 29 anni, 20 presenze RIVOLUZIONE MILAN e 2 gol nella Juve PUÒ TORNARE BRAIDA BALDINI, CORNACCHIA, GALOSSO, PIRISI, SALVETTI, VACIAGO DA PAG. 8 A PAG. 15 CIULLINI, MASINI, MAZZARA ALLE PAGG. 24/25 OGGI BRESCIA-NAPOLI ORE 20.45 SKY DOMANI BOLOGNA-UDINESE ORE 15 SKY SPAL-JUVENTUS ORE 18 SKY A FIORENTINA-MILAN ORE 20.45 DAZN DOMENICA GENOA-LAZIO ORE 12.30 DAZN ATALANTA-SASSUOLO ORE 15 SKY TORINO-PARMA ORE 15 SKY VERONA-CAGLIARI ORE -

List of Papers
BENEDETTO DE VIVO Pubblicazioni con Peer Reviews/Peer Reviewed Publications Citazioni da Scopus 4238: 23.5.2018 1975 P001 CIVITA M., DE VIVO B. e PIERATTINI D., 1975. Lineamenti idrogeologici e caratteristiche delle acque sotterranee della provincia di Khartoum (Sudan). L'Industria Mineraria, Gennaio: 1- 19. P002 DE VIVO B., 1975. Risorse minerarie della provincia di Khartoum, Sudan. L'Industria Mineraria, Marzo: 106-115. P003 BONI M. e DE VIVO B., 1975. Le risorse minerarie del Sudan. L'Industria Mineraria, Marzo:171-179. 1978 P004 DE VIVO B., LORENZONI S., ORSI G. e ZANETTIN LORENZONI E., 1978. Inquadramento delle mineralizzazioni metallifere ed a grafite nelle unità tettoniche della Calabria. Primo contributo: la Sila e le Serre. L'Industria Mineraria, XIX(2): 108-120. P005 DE VIVO B., LORENZONI S., ORSI G. e ZANETTIN LORENZONI E., 1978. Le risorse minerarie della Sila e delle Serre in Calabria. Energia e Materie Prime, 1: 27-31. 1979 P006 CIVETTA L., DE VIVO B., GIUNTA G., IPPOLITO F., LIMA A., ORSI G., PERRONE V. and ZUPPETTA A., 1979. Geological and structural outlines of the Southern Sudan. Atti Acc. Naz. Lincei, "Geodinamic evolution of the Afro-Arabian rift system". 175-183, Roma. 1980 P007 DE VIVO B., IPPOLITO F. e LIMA A., 1980. Mineralizzazioni e tettonica a zolle. L'Industria Mineraria, 5: 1-12. P008 DE VIVO B., LORENZONI S., ORSI G. e ZANETTIN LORENZONI E., 1980. Le mineralizzazioni nel basamento cristallino dell'Aspromonte (Calabria). Boll. Soc. Geol. It., 99: 289-302. P009 DE VIVO B., GIUNTA G., IPPOLITO F., LIMA A., ORSI G., PERRONE V. -

L'altro Giornale
L’ALTRO GIORNALE EDIZIONE GARDA BALDO WhatsApp 331 9003743 www.laltrogiornaleverona.it ANNO XXXIII - N.2 - FEBBRAIO 2018 - Stampato il 22/02/2018 - Via dell’Industria 22 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR) - Tel. 0457152777 - Fax 0456703744 Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma1, DCB VERONA Registrazione Tribunale di Verona n° 725 del 13.11.1986. ISCRIZIONE AL ROC N. 18663 4 MARZO. TUTTI AL VOTO! CASTION E CAVAION. LAVORI IN PIAZZA Piazze in primo piano a Castion e Cavaion. Nei gior- di RICCARDO REGGIANI ni scorsi le Amministrazioni comunali di Costerma- no e di Cavaion hanno presentato alla cittadinanza i Domenica 4 marzo gli italiani aventi diritto saranno chiamati ad esprimere la propria preferenza politica progetti che restituiranno “giovinezza” a due piazze con il voto, attraverso il quale verrà eletto il nuovo del territorio. Il progetto di riqualificazione della piaz- Governo che guiderà l’Italia per i prossimi cinque za comunale Vittorio Veneto e del sagrato della chie- anni. sa parrocchiale di S.Maria Maddalena a Castion è Archiviata la vecchia legge elettorale, il nuovo stato presentato lo scorso 25 gennaio, mentre il 13 sistema di voto si baserà sul “Rosatellum-bis”, febbraio è stato illustrato il progetto di riqualificazio- approvato nell’autunno scorso dalle Camere. Una legge elettorale che ha generato non poche polemi- ne della piazza della Chiesa di Cavaion. che e che solo dopo le elezioni dimostrerà o meno Pagine 14 e 16 il suo valore. Stefano Passarini Sabrina Tramonte Non intendo approfondire i singoli programmi pro- posti, né le mille promesse (molte delle quali dav- vero fantasiose) che ci vengono quotidianamente ALA “BANDIERA ARANCIONE” LEGITTIMA DIFESA propinate e che in questa campagna elettorale di Riconoscimento E’ un tema caldo, di particolare attualità e certo non sono mancate! convalidato per Ala risalto mediatico, quello della legittima Voglio invece sottolineare l’importanza di recarsi che può vantarsi difesa. -

Rassegna Stampa Apertura Consolato Russo a Napoli Via Partenope, 1
RASSEGNA STAMPA APERTURA CONSOLATO RUSSO A NAPOLI VIA PARTENOPE, 1 - 10 LUGLIO 20015 CZC0054/SXR ONA03669_SXR_QBXO R POL S44 QBXO Napoli: apre sede consolato Federazione Russa Cerimonia preceduta incontro con istituzioni a Palazzo S.Giacomo (ANSA) - NAPOLI, 8 LUG - Sarà inaugurata venerdì prossimo, a Napoli, la sede del Consolato della Federazione Russa nel capoluogo campano. La cerimonia cade in una giornata in cui le istituzioni campane incontreranno quelle della Federazione Russa: alle ore 10, infatti, nella Sala della Giunta comunale, a Palazzo San Giacomo, è programmata una conferenza stampa alla quale parteciperanno l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Federazione Russa in Italia Sergey Razov, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e Vincenzo Schiavo, console onorario della Federazione Russa in Napoli con circoscrizione della Regione Campania. A seguire, alle 12, ci sarà il "taglio del nastro" del Consolato che si trova in via Partenope 1. "L'apertura dell'ufficio del Console a Napoli - dice Schiavo - è una grande opportunità per i tanti russi residenti in Campania. Inoltre sarà una garanzia e tutela anche per le migliaia di imprese campane che avranno l'opportunità di utilizzare un interlocutore certo sul territorio per sviluppare o arricchire rapporti commerciali con la Russia". (ANSA). COM-PIO 08-LUG-15 20:55 NNNN ZCZC0047/SXR ONA03797_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO DOMANI IN CAMPANIA (ANSA) - NAPOLI, 9 LUG - Avvenimenti previsti per domani in Campania: 3) NAPOLI - Palazzo San Giacomo - ore 10:30 Inaugurazione del Consolato della Federazione Russa a Napoli: conferenza con gli interventi ambasciatore straordinario e Plenipotenziario Federazione Russa in Italia Sergey Razov, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris; alle ore 12.00 "taglio del nastro" al Consolato, via Partenope 1. -

«Se Non Giochi Nel Napoli E Non Conosci La Pazzia Della Sua Gente Per La Squadra, Non Puoi Sapere Cos’È Il Calcio»
ANGELO ROSSI LE LEGGENDE DEL NAPOLI DIARKOS AUTORE Angelo Rossi TITOLO Le leggende del Napoli SOTTOTITOLO Una città, un popolo, una squadra COLLANA Grande sport PAGINE 256 PREZZO 17,00€ FORMATO 14 x 21 cm LEGATURA Brossura con bandelle EAN 9788836160372 «Se non giochi nel Napoli e non conosci la pazzia della sua gente per la squadra, non puoi sapere cos’è il calcio». Diego Armando Maradona ANGELO ROSSI LE LEGGENDE DEL NAPOLI DIARKOS CONTENUTO Napoli è il Napoli, passando attraverso i napoletani: nessun club ha un intreccio così solido, viscerale ed eterno come quello nato sotto il Vesuvio quasi un secolo fa. Il fenomeno ha una sua logica: a differenza di Milano, Torino, Roma, Genova (e finanche Verona), Napoli è l’unica grande città ad avere una sola squadra. Due scudetti, cinque Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa Uefa, milioni e milioni di tifosi sparsi per il mondo: questa è la società calcistica meridionale più titolata a livello nazionale e internazionale e anche la più presente nei campionati di serie A. Da Sallustro a Mertens incrociando Vinicio, Sivori, Juliano, Pesaola, Ferrara, Careca, Maradona, Hamsik, Cavani, ecco la storia azzurra raccontata con aneddoti e gesta dei suoi personaggi più rappresentativi. Passione, sogni, speranze, miracoli e delusioni: il Napoli è Napoli, e viceversa. Una città, un popolo, una squadra. AUTORE Angelo Rossi è un giornalista, professionista dal 1988. Scrive prevalentemente di sport con tappe presso «Napoli notte», «il Giornale di Napoli», «Roma», «Repubblica», «Il Domani», «Tuttosport», «Il Mattino», «il Giornale». Collabora con emittenti televisive, autore di programmi sportivi e di alcuni cortometraggi: Napoli campione, La favola più bella, Napoli il giorno dopo. -
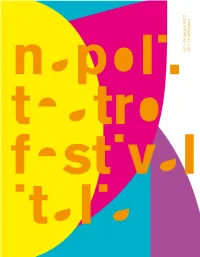
MAGAZINE NTFI 2012.Pdf
1 Progetto co-finanziato con POR FESR 2007-2013 “la cultura come risorsa” Soggetto attuatore Progetti: Napoli Teatro Festival Italia; La Campania dei Festival verso il Forum universale delle culture Con il patrocinio di Regione Campania Presidente / President Stefano Caldoro Fondazione Campania dei Festival Consiglio di Amministrazione / Administrative Council Caterina Miraglia Presidente / President Luigi Grispello Lucio d’Alessandro Direttore Artistico / Artistic Director Napoli Teatro Festival Italia Luca De Fusco Comitato d’Onore / Committee of Honour Pietrangelo Buttafuoco Anselma Dell’Olio Alessandra Ferri Collegio dei Revisori dei Conti / Council of Accounting Paolo Russo Silvio de Simone INDICE/INDEX BENVENUTI AL FESTIVAL/ WELCOME TO THE FESTIVAL 6 impegno, determinazione e rigore 6 di caterina miraglia/ effort, determination and rigour by caterina miraglia 10 festival 2012: una profonda leggerezza di luca de fusco/ festival 2012: a deep lightness THE MAKROPULOS CASE THE SUIT ORGUEIL, POURSUITE by luca de fusco ET DÉCAPITATION QUANDO ERAVAMO LUPI TRAVAUX D’A- GRANDISSEMENT DE LA FOSSE EXILS PASOLINI PLAU- TO IL VANTONE IFIGENIA IN AULIDE L’ISOLA DI ARTURO YO, EL HEREDERO LA CASA MORTA A BOCCA PIENA CARTELLONE/PLAYBILL WONDERLAND UN GIORNO TUTTO QUESTO SARÀ TUO IL TEATRO IN CUCINA: SARTÙ TAKING CARE OF BABY THE 12 i colori del festival/the colours of the festival RERUM NATURA IGIENE DELL’ASSASSINO TOMMY... NON 12 APRO!!! SUMMER LOS HIJOS SE HAN DORMIDO ESPÍA A UNA MUJER QUE SE MATA EL TIEMPO TODO ENTERO EL VIENTO EN UN VIOLÍN LA OMISIÓN DE LA FAMILIA CO- LEMAN TERCER CUERPO WELCOME ON BOARD RAM- ANTEPRIMA FESTIVAL/ BLAS L’ANGELO DELLA CASA NAPOLI.