Correva L'anno 1850, Di Primavera
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Turismo in Saccisica ……………………………………………...43
Corso di Laurea Magistrale in Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici ordinamento D.M. 270/04 Tesi di Laurea Far turismo nella bassa pianura veneta, tra laguna e Colli Euganei. Una sfida possibile? Il caso studio della Saccisica. Relatore Ch. Prof. Francesco Vallerani Laureando Davide Quaglio Matricola 845945 Anno Accademico 2017 / 2018 INDICE INTRODUZIONE …………………………………………………………….1 1)RURALITÀ E TURISMO RURALE ………………………………………3 1.1 - Il territorio rurale ………………………………………………………………………………..3 1.1.1 – Categorizzazione geografica del territorio rurale ……………………………………3 1.1.2 – Paesaggio Rurale ………………………………………………………………………7 1.2 - L’urbanizzazione della campagna e la trasformazione della ruralità …………………….9 1.3 – Turismo rurale ………………………………………………………………………………..13 1.3.1 – Inquadramento del turismo rurale …………………………………………………...14 1.3.2 - L’importanza delle risorse produttive di una comunità rurale ……………………..16 1.3.3 – Agriturismo e turismo rurale ………………………………………………………….17 1.3.4 – Ittiturismo e pescaturismo ....…………………………………………………………18 1.3.5 – Turismo rurale in continua crescita ………………………………………………….19 1.3.6 – Perché scegliere il turismo rurale ……………………………………………………20 1.4 - Turismo rurale come mezzo di sviluppo di una comunità rurale: benefici e rischi …….22 2) IL TERRITORIO DELLA SACCISICA ………………………………...27 2.1 – Caratteri fisici …………………………………………………………………………………27 2.2 – Idrografia ……………………………………………………………………………………...28 2.3 – Cenni storici …………………………………………………………………………………..33 2.3.1 – Origine del nome Saccisica ……………………………………………………….. 35 2.4 – I comuni -

Padova E Provincia in Bicicletta: Itinerari Ed Escursioni. Le Ciclovie Della Provincia Di Padova
icicletta. Padova e provincia in bicicletta: itinerari ed escursioni. Le ciclovie della Provincia di Padova. a provincia di Padova è uno scrigno di straordinaria ricchezza: città d’arte, colline, laghi, Llagune, castelli medioevali, borghi rurali e aree termali, il tutto collegato da una fitta rete di vie d’acqua. La sola chiave di accesso alla completa rivelazione di questo tesoro è la bicicletta. Nessun altro mezzo di locomozione offre infatti al viaggiatore la velocità ideale per cogliere la multiforme bellezza dei paesaggi, la libertà di spostamento e la gratificazione fisica che può dare una piacevole escursione su due ruote. on questa nuova pubblicazione la Provincia di Padova e l’azienda Turismo Padova Terme CEuganee invitano tutti, dai ciclisti più allenati alle famiglie con bambini, a scoprire i migliori percorsi cicloturistici del padovano. Un ampio ventaglio di proposte che stanno diventando vere e proprie piste ciclabili. Queste sono ideali per praticare lo slow bike ovvero la dimensione dolce, lenta e curiosa del cicloturismo, quella che per essere vissuta ha bisogno di una bicicletta scorrevole ed affidabile e di strade pianeggianti, prive di traffico, dove sia possibile incontrare persone, visitare città e scoprire paesaggi e specialità gastronomiche. I percorsi qui descritti infatti seguono per lo più gli argini dei fiumi e dei canali che bagnano in lungo e in largo la provincia. Tale peculiarità offre al cicloturista la possibilità di raggiungere Padova dalle principali destinazioni turistiche padovane e venete, pedalando su strade panoramiche e pianeggianti. razie al cicloturismo la Provincia di Padova intende valorizzare la fruizione dei corsi Gd’acqua dando a questi una nuova ragione ambientale e ricreativa. -
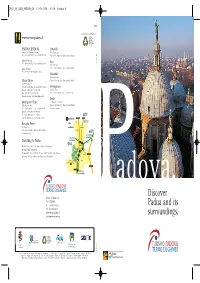
Discover Padua and Its Surroundings
2647_05_C415_PADOVA_GB 17-05-2006 10:36 Pagina A Realized with the contribution of www.turismopadova.it PADOVA (PADUA) Cittadella Stazione FS / Railway Station Porta Bassanese Tel. +39 049 8752077 - Fax +39 049 8755008 Tel. +39 049 9404485 - Fax +39 049 5972754 Galleria Pedrocchi Este Tel. +39 049 8767927 - Fax +39 049 8363316 Via G. Negri, 9 Piazza del Santo Tel. +39 0429 600462 - Fax +39 0429 611105 Tel. +39 049 8753087 (April-October) Monselice Via del Santuario, 2 Abano Terme Tel. +39 0429 783026 - Fax +39 0429 783026 Via P. d'Abano, 18 Tel. +39 049 8669055 - Fax +39 049 8669053 Montagnana Mon-Sat 8.30-13.00 / 14.30-19.00 Castel S. Zeno Sun 10.00-13.00 / 15.00-18.00 Tel. +39 0429 81320 - Fax +39 0429 81320 (sundays opening only during high season) Teolo Montegrotto Terme c/o Palazzetto dei Vicari Viale Stazione, 60 Tel. +39 049 9925680 - Fax +39 049 9900264 Tel. +39 049 8928311 - Fax +39 049 795276 Seasonal opening Mon-Sat 8.30-13.00 / 14.30-19.00 nd TREVISO 2 Sun 10.00-13.00 / 15.00-18.00 AIRPORT (sundays opening only during high season) MOTORWAY EXITS Battaglia Terme TOWNS Via Maggiore, 2 EUGANEAN HILLS Tel. +39 049 526909 - Fax +39 049 9101328 VENEZIA Seasonal opening AIRPORT DIRECTION TRIESTE MOTORWAY A4 Travelling to Padua: DIRECTION MILANO VERONA MOTORWAY A4 AIRPORT By Air: Venice, Marco Polo Airport (approx. 60 km. away) By Rail: Padua Train Station By Road: Motorway A13 Padua-Bologna: exit Padua Sud-Terme Euganee. Motorway A4 Venice-Milano: exit Padua Ovest, Padua Est MOTORWAY A13 DIRECTION BOLOGNA adova. -

Palazzo Pinato Valeri a Piove Di Sacco 4 INDICE
Palazzo Pinato Valeri a Piove di Sacco 4 INDICE Giorgio Bovo Presentazione pag. 7 Giorgio Meneghetti Il Recupero di un simbolo pag. 9 Fabio Zecchin Il Progetto di Restauro pag. 11 Romina Cattelan La Storia pag. 15 5 6 (…) O città che raggi laggiù nella nebbia il tuo alone lucente che vuoi da me? Certamente le tue vie le tue case la tua gente non mi conoscono più. Non per te son io ritornato, città di passato ! Ma qui riconosco la mia vita, qui ritrovo la mia poesia qui qui dovevo tornare da tanta inutile guerra, da tanta speranza fallita: a questo recinto di terra dove sento sboccare la lunga mia nostalgia, dov’è tutto quanto posso salvare, ancòra, dell’anima mia. [Diego Valeri, Il figliol prodigo] Sulla facciata del palazzo al civico 62 di via Garibaldi un’iscrizione lapidea ricorda che “ Il 25 gennaio 1887 nasceva in questa casa Diego Valeri, saggista e poeta …….”. Finora era questo il luogo di partenza di un ideale itinerario valeriano nella sua città natale che proseguiva poi nel Municipio ad ammirare il sipario di Alessio Valerio con il ritratto della madre Giovanna Elvira Fontana che acco - glie festante un capitano dell’esercito regio nel momento del passaggio della città dalla dominazione austriaca al Regno d’Italia, continuava presso il San - tuario mariano delle Grazie, luogo di devozione caro alla madre, e giungeva a conclusione presso la tomba di famiglia nel cimitero del Capoluogo dove il poeta riposa con la moglie Maria Minozzi e la figlia Giovanna. Le notizie contenute in questo libro, frutto delle ricerche e dell’accurato lavoro d’indagine e di scavo d’archivio compiuti dall’architetto Romina Cattelan, ci obbligano a rivoluzionare questo itinerario memoriale e a mettervi al primo posto il palazzo Pinato Valeri, finora identificato con l’anonima denomina - 7 zione di Palazzo neogotico. -

Landscapes Along the Great Rivers Be Bike and Boat Itineraries Tween the Brenta, Rs Adige and Po Rive
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali Landscapes along the great rivers be Bike and boat itineraries tween the Brenta, rs Adige and Po rive Provincia di Padova Venezia Legenda Index map Verona Padova Mira Campolongo 6 3 Maggiore Lago di Garda Lova di Battaglia Campagna Terme Bovolenta 5 Lupia How to use this guide Key Information About this book p. 2 Roverchiara 2 4 Montagnana Este Monselice Chioggia Transit network IAT (tourist information) This guide was designed to fit in 1 From the Alps to the Adriatic Sea p. 6 1 main road marina Villa the map pocket of the bicycle’s Mantova Bartolomea 2 The Walled Cities’ Loop p. 8 Lendinara Rosolina handlebar bag. railway line Castagnaro main docking point Adria Porto Levante Melara 7 Rovigo All maps display the compass rose, river/canal The Euganean Hills Loop (E2) p. 10 navigable waterway 3 Trecenta 10 Porto showing their orientation. 8 Viro lock 4 From Sugar to Salt p. 12 11 The double slash symbol Berra Itineraries on land Polesella Porto 9 indicates that the route continues connection between riverbanks Tolle The Brenta Bridleway p. 16 Mesola Scardovari cycling itineraries 5 in the following chart after the railway station Goro The Taglio Nuovissimo Canal p. 18 Ferrara same symbol. itinerary extension 6 starting point/arrival point Maps may not be completely up- From the river Adige to the Po p. 20 Itineraries on water main towns 7 to-date, due to recent changes; minor towns The Road to the Sea (I3.1) p. -

L'economia Industriale
GIORGIO ROVERATO L'ECONOMIA INDUSTRIALE estratto da a cura di Andrea Caracausi Mestrino-Padova, Peruzzo Editoriale & BCC di Piove di Sacco, 2011 GIORGIO ROVERATO L'ECONOMIA INDUSTRIALE 121 GIORGIO ROVERATO La zona industriale di Piove di Sacco, collocata tra il Comune capoluogo della Saccisica e Arzergrande 122 L'ECONOMIA INDUSTRIALE Quel ricco tessuto manifatturiero, fatto di botteghe, nomici dei dieci comuni del distretto appariva del tutto mercanti e attività proto-industriali che tra il XVI secolo e simbolica. Il che non impedì tuttavia alla Giuria della il XVIII aveva inserito la Saccisica – e in particolare Piove Sezione VI, quella dedicata ai prodotti manifatturieri, di di Sacco – in una fitta rete di relazioni con le aree più vivaci redigere un giudizio elogiativo per le «tele in cotone qua- del Veneto centrale 1, andò rapidamente deteriorandosi in drigliate a colori» presentate dalla Ditta Fratelli Bocchini, seguito alla dissoluzione della Repubblica veneziana e ai azienda storica di Piove cui la Serenissima aveva concesso mutamenti delle direttrici dei traffici commerciali indotti nella seconda metà del Settecento una serie di privilegi dai nuovi assetti istituzionali: marginalmente con il napo- ed esenzioni fiscali in virtù della qualità delle sue produ- leonico Regno d’Italia, più decisamente con la nascita del zioni 3. Regno Lombardo-Veneto. Nemmeno Alberto Errera, il primo sistematico stu- Il dominio asburgico segnò infatti, privilegiando la dioso dell’economia manifatturiera veneta, autore in nascente industria lombarda in un disegno di (parziale) quell’anno di un corposo lavoro sulle «industrie venete» 4, integrazione con le altre aree manifatturiere dell’Impero, si soffermò su questa landa del padovano, troppo preso la progressiva marginalizzazione delle produzioni venete dall’attenzione dedicata ai lanifici dell’Alto vicentino e alle ai soli mercati locali. -

Il Ciclo Idrico Integrato Nella Saccisica
> Gruppo AcegasAps < IL CICLO IDRICO INTEGRAto Area Saccisica iServizi Supplemento Iniziative per lo Sviluppo Sostenibile NUOVA EDIZIONE 2013 iQuaderni CONTENUTI 3 L'80% del corpo umano è composto d'acqua 4 La quantità d'acqua sul pianeta è sempre la stessa da millenni 6 L'Acquedotto della Saccisica serve oltre 66.000 persone 8 Il ciclo idrico integrato 10 La qualità è garantita da 15 mila controlli l'anno 11 I dati delle analisi dell'acqua consultabili ogni mese on line 12 La depurazione dei reflui a tutela dell'uomo e dell'ambiente 14 L'acqua nel mondo 16 Acqua in bottiglia una scelta poco sostenibile 17 Acqua di rubinetto quattro buoni motivi per berla 18 Consigli per il risparmio e per la sicurezza L'80% DEL CORPO UMANO È COMPOSTO D'ACQUA Il Pianeta blu Se osserviamo la Terra in una foto L’acqua è fonte di vita. Miliardi di anni fa i primi organismi viventi iniziarono satellitare, vediamo a svilupparsi proprio al suo interno, dando inizio a un lunghissimo cam- predominare le zone mino evolutivo. L'acqua è ovunque intorno e soprattutto dentro di noi. Il blu degli oceani e corpo umano è composto per circa l’80% da questo elemento, reintegrato azzurre dei mari e quotidianamente attraverso le bevande e i cibi dei quali ci alimentiamo. la grande ragnatela Anche nella vita dei vegetali l’acqua ha un ruolo imprescindibile. Piante, di fiumi e laghi che alberi e foglie traggono il loro nutrimento dalla “fotosintesi clorofilliana”, un tagliano i continenti. sofisticato processo durante il quale, in presenza di luce l’acqua si combina La presenza di acqua con la CO2 producendo sostanze nutritive e ossigeno vitale per la soprav- è una caratteristica vivenza del pianeta. -
Agriturismi E... Revisione Ed Aggiornamento ARTMOSFERA S.N.C
Provincia di PADOVA ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA Piazza Antenore, 3 - 35121 PADOVA Provincia di Padova Tel. 049 8201282 - fax 049 8201377 Assessorato all’Agricoltura SERVIZIO “AGRICOLTURA” Piazza Virgilio Bardella, 2 - 35129 PADOVA Tel. 049 8201842 - fax 049 8201898 [email protected] Progetto, studio, realizzazione e cura del Servizio “Agricoltura” Foto DI CORTE MATTOSCHI COMUNICAZIONE s.r.l. (Padova) - mail: [email protected] per il Servizio “Agricoltura” della Provincia di Padova IN CORTE (copyright: Provincia di Padova - Servizio “Agricoltura”) Progetto grafico AchAB TRIVENETO s.r.l. - Scorzè (Ve) - Tel. 041 5845003 - www.achabgroup.it Agriturismi e... Revisione ed aggiornamento ARTMOSFERA s.n.c. - Scorzè (Ve) - Tel. 041 5845071 - www.artmosfera.it Stampa MArcA PRINT - Quinto di Treviso (Tv) - Tel. 0422 470055 - www.marcaprint.it La campagna padovana, Con l’adesione delle Associazioni Agrituristiche: se un tempo ci ha sfamato, oggi alimenta in noi l’orgoglio e l’impegno di esserne i custodi e di offrirla, a chi la vuole apprezzare, come una parte di noi stessi. VIETATA LA RIPRODUZIONE. Tutti i diritti sono riservati alla Provincia di Padova - Servizio “Agricoltura” PUBBLICATO NEL MARZO 2008 REVISIONE, AGGIORNAMENTO E RISTAMPA: FEBBRAIO 2009 Ulteriori informazioni sulle Aziende Agrituristiche sono rintracciabili al sito interprovinciale www.veneto-agriturismo.it COPIA OMAGGIO Cittadella L’Alta Camposampiero PADOVA Il Periurbano Vò I Colli Piove di Sacco Monselice La Bassa Est Este Conselve La Bassa Ovest La Provincia di Padova, in collaborazione con le Associazioni agrituristiche padovane, da tempo persegue l’affermazione dell’identi- tà storica, culturale, ambientale, economica e sociale del proprio territo- rio anche mediante la promozione di un’offerta turistica integrata, co- struita sulla qualità dei prodotti e dei servizi incentivando, valorizzando e promuovendo in senso turistico le produzioni agricole ed agroalimen- tari, le specialità enogastronomiche e le produzioni dell’economia eco- compatibile. -

Parere Comune Di Legnaro
COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PARERE n. 92 del 16 dicembre 2010 (o.d.g. 7 del 16 dicembre 2010) OGGETTO: Comune di Legnaro (PD). Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio. PREMESSO CHE – ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull’ambiente al fine di “promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente”; – La Commissione Regionale VAS, individuata ex art.14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 16 dicembre 2010 come da nota n. 645835/45.06 del 10.12.2010 del Dirigente della Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV), segretario della commissione; – Il Comune di Legnaro (PD), con note n. 10929 del 12.11.07, n.13481 del 29.12.09 n.2055 del 22.02.10 n.12236 del 22.11.2010 ha fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS; – Il Comune ha approvato con DGC n. 190 del 30.11.2006 il “Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione” ai sensi dell’art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale; In data 22.07.2008 è stato sottoscritto l’accordo di pianificazione tra Ragione, Comune e Provincia. In applicazione dell’art. -

Piove Di Sacco, Parte “Saccisica In
Piove di Sacco, parte “Saccisica in Mostra 2015” Incontri e riunioni. Parte un percorso di arte, storia, cultura, imprenditoria, enogastronomia e turismo: da sabato 17 ottobre, per una settimana, andrà in scena in piazzale Bachelet a Piove di Sacco la 52^ edizione della manifestazione “Saccisica in Mostra”. La fiera espositiva, vetrina per le attività produttive dei territori locali, ha infranto la barriera dei 40 stand di partecipanti provenienti dai più svariati ambienti sociali: imprese, aziende, commercianti, artigiani, associazioni, professionisti e scuole. Il primo cittadino piovese Davide Gianella, pieno di orgoglio, scrive sui social: «Piove città delle riforme, della Cultura e di manifestazioni che fanno crescere il territorio. […] “Saccisica in Mostra 2015” ancora più ricca di contenuti ed espositori, la riforma nei lavori pubblici e nell’organizzazione della macchina comunale. Grazie a chi ci crede, e grazie ai cittadini e volontari che la rendono unica e meravigliosa». Fra concerti, convegni, spettacoli e intrattenimento verranno messe in risalto le qualità e le realtà della produzione sociale e formativa delterritorio . Aderiranno, oltre al comune di Piove di Sacco, anche i paesi di limitrofi diArzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Polverara, Pontelongoe Sant’Angelo di Piove. Programma di “Saccisica in Mostra 2015” Sabato 17 ottobre 18.30: inaugurazione e taglio del nastro con le autorità. Presentazione del logo “Piove di Shoppin”. Brindisi per tutti 21.30: cover band Jovanotti “Safari Live” Domenica 18 ottobre 21.00: cabaret con Bepy & Maria Show Lunedì 19 ottobre 18.30: tavola rotonda a cura di “Fabbrica del Sociale” 21.30: Spettacolo teatrale “Il re dai tempo” Martedì 20 ottobre 21.30: cover band Vasco Rossi “Infrarossi” Mercoledì 21 ottobre 9.00: laboratorio “Con le mani, con il cibo” 18.30: incontro con il nutrizionista 21.00: sfilata a moda a cura di “Piove è Moda” Giovedì 22 ottobre 21.30: Dante Expo Festival. -

Ciclovie Nella Provincia Di Padova Bicycle Paths in The
vandura BRENTA tergola GALLIERA VENETA MUSON vecchio N S MARTINO DI LUPARI MUSON dei sassi TREVISO ASTICO → CITTADELLA TOMOBOLO CARMIGNANO DI BRENTA SILE FONTANIVA PIOMBINO DESE CICLOVIE GRANTORTO TREBASELEGHE S GIORGIO IN BOSCO NELLA PROVINCIA LOREGGIA VILLA DEL CONTE DI PADOVA CAMPOSAMPIERO BICYCLE PATHS S GIUSTINA IN COLLE MASSANZAGO IN THE PROVINCE CAMPO S MARTINO PIAZZOLA OF PADOVA SUL BRENTA S GIORGIO DELLE PERTICHE BORGORICCO CURTAROLO VILLAFRANCA BRENTA (Tratto nord) → 38 KM PADOVANA BRENTA (North path) CAMPODORO CAMPODARSEGO COMPLETAMENTO BRENTA → 8 KM BRENTA PATH WORK in progress LIMENA VIGODARZERE TERGOLA-MUSON DEI SASSI → 30 + 27 KM CADONEGHE VIGONZA VICENZA ← VEGGIANO BACCHIGLIONE MUSON VECCHIO → 18 KM CERVARESE tergola S CROCE NOVENTA SELVAZZANO PADOVANA DENTRO SACCOLONGO PADOVA INTERBIKE → 1,35 KM treviso-OSTIGLIA 32 KM PONTE S NICOLO’ → ROVOLON ABANO TERME torreglia ALBIGNASEGO TEOLO MONTEGROTTO TERME ANELLO FLUVIALE PADOVA-BRENTELLA-PIOVEGO → 47 KM The Padova River Ring vo’ MASERA’ DI PADOVA CAsalserugo galignano DUE BACCHIGLIONE-CERESONE 59 KM CARRARE polverara → COLLI EUGANEI Capagna Lupia BATTAGLIA caGNOLA VENEZIA TERME → PIOVE DI SACCO COLLEGAMENTO BACCHIGLIONE ANELLO COLLI → 4 KM cinto euganeo COLLI euganei ring - bacchiglione river path work in progress arua’ petrarca cartura bovolenta arergrande codevigo terassa ANELLO COLLI EUGANEI → 64 KM pontelongo COLLI EUGANEI RING baone padovana MEGLIADINO S FIDENZIO este onselice correola Chioggia MONTAGNANA saletto ospedaletto conselve BATTAGLIA-BIANCOLINO-CAGNOLA → 24 -

IL MERCATINO A13 RIVIERA DEL BRENTA PADOVA STRA• Di Villa Roberti
103 105 VENEZIA IL MERCATINO A13 RIVIERA DEL BRENTA PADOVA STRA• di Villa Roberti SS 516 PIOVESE A13 ABANO PIOVE DI TERME • DUE CARRARE • SACCO • BRUGINE• CHIOGGIA A13 MONSELICE TARIFFE INGRESSO ROVIGO Ingresso € 2,5 Ridotto € 2 (over 65, Legambiente, Fai, Unpli) Dopo le ore 13 e Residenti € 1 IL MERCATINO COME ARRIVARE Gratuito bambini fino a 12 anni • IN AUTO Autostrada A4 uscita Padova Est indicazioni Piove di Sacco SOSTIENE, Autostrada A13 uscita Terme Euganee e • IN TRENO Linea Venezia-Adria, Stazione di Piove di Sacco, a 4 km dal Mercatino. FA CONOSCERE E VIVERE Per info-biglietteria 049 5840265, treni ogni ora con servizio trasporto bici. VILLA ROBERTI Collegamento al Mercatino con Autobus di linea o Servizio taxi Piove di Sacco 337 505965 • IN BICI Pista ciclabile E 2.2 Chioggia – Abano Montegrotto Terme. La via del sale e dello Villa Roberti, splendente MANGIARE zucchero fino a Bovolenta. Lungo il canale Bacchiglione. Da Bovolenta a Brugine strade interne testimonianza del Rinascimento VISITE GUIDATE DENTRO AL MERCATINO: STREET FOODER www.veneto.eu Veneto, affascina i visitatori La domenica NEI DINTORNI: PARCHEGGIARE del Mercatino • Via Roma 119, Brugine 049 580 6001 con il celebre ciclo di affreschi Trattoria Al Bosco • Piazza Falcone (centro), angolo via Arzerini, al Cimitero, di fronte Barchessa opera di Veronese e Zelotti, le cucine ore 11 e 15 • Pasticceria Fiorin Via Roma 40, Brugine 049 580 6535 (durata 45min circa) € 5 IL MERCATINO originali, gli antichi arredi, gli stucchi • Agriturismo Caresà via Ospitale, Brugine del Settecento, la Torre e le rovine Puoi prenotare la visita • L’Operaio dei Fornelli via Trieste 16, Polverara 049 5855363 in segreteria in barchessa • Trattoria Da la Mora via Monte Rosa 1, Piove di Sacco 049 9702954 di Villa Roberti del Castello Medievale su cui si erge.