Turismo in Saccisica ……………………………………………...43
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Padova E Provincia
venerdì 12 giugno 2015 - Pagina 1 Autore Zamboni Roberto - www.dimenticatidistato.com - Tratto da “Elenco nazionale - comune di nascita” Le fonti principali dalle quali sono stati tratti i dati riportati di seguito sono: 1) Ministero della Difesa - Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra (Onorcaduti): (1a) Elenco digitale dei 16.079 Caduti italiani della 2a Guerra mondiale (civili e militari), sepolti nei cimiteri militari italiani di Amburgo, Berlino, Bielany, Francoforte sul Meno, Monaco di Baviera e Mauthausen (elenco ottenuto da Onorcaduti nel marzo del 2009); (1b) Elenco alfabetico digitale e posizioni di sepoltura dei Caduti sepolti nei cimiteri militari italiani di Amburgo, Francoforte sul Meno e Monaco di Baviera (Onorcaduti - 5 ottobre del 2001). 2) Archivium Secretum Vaticanum / Cav 52: (2a) «Inter Arma Caritas» - L'Ufficio Informazioni Vaticano per i prigionieri di guerra, istituito da Pio XII (1939-1947) - A cura di Francesca Di Giovanni e Giuseppina Roselli. Presentazione di Sergio Pagano (2004) - Volume 1 / Inventario, volume 2 / Documenti; (2b) Schedario digitalizzato (schede di ricerca in formato digitale, dei militari e dei civili di cui si chiesero notizie tra il 1939 e il 1947). 3) Archivio privato Zamboni - Elenco digitalizzato delle posizioni tombali del Cimitero Militare Italiano di Mauthausen (tratto dal registro delle sepolture del cimitero di Mauthausen). 4) Associazione Nazionale Ex Deportati (Milano) - Presidenza Nazionale - «Archivio Tibaldi» - Elenco digitalizzato dei deportati italiani -

Correva L'anno 1850, Di Primavera
e Vallonga si scoprì romana Cesarina Foresti Correva l’anno 1850, di primavera. Si era conclusa solo l’anno precedente la prima guerra di indipendenza (1848/49) contro l’Austria. Nel conflitto che aveva riguardato anche il Veneto, il territorio di Arzergrande non aveva sofferto di particolari vicissitudini, ma l’assedio e la caduta di Venezia erano sicuramente ben noti alla popolazione locale, ancora molto legata alla storia della Repubblica Serenissima. L’imperial Regio Governo austriaco, desideroso di dimostrare la sua volontà di riappacificazione, diede corso ad una politica di interventi nei lavori pubblici, mirata al patrimonio cui gli abitanti dei piccoli centri erano particolarmente legati: nel nostro caso la chiesa parrocchiale di Arzergrande. Si decise che i progetti, ancora visibili presso l’Archivio Storico del comune di Arzergrande, sarebbero stati elaborati dagli uffici governativi, la comunità avrebbe contribuito procurando materiali adatti ad interventi di manutenzione, consolidamento, in qualche caso di ampliamento degli edifici religiosi. Iniziarono così attività di scavo di notevole entità, che rivelarono testimonianze comprovanti l’importanza di Vallonga in epoca romana Vennero portati alla luce reperti che l’abate Valentinelli, archeologo di fama, presente come altre volte nel territorio della Saccisica, così descrive “ grossi macigni che nella loro forma irregolare conservano tracce non equivoche di rotaie”,ma soprattutto rocchi di colonna, basi capitelli, cornici, tutti materiali disposti senza un preciso ordine. -

Padova E Provincia in Bicicletta: Itinerari Ed Escursioni. Le Ciclovie Della Provincia Di Padova
icicletta. Padova e provincia in bicicletta: itinerari ed escursioni. Le ciclovie della Provincia di Padova. a provincia di Padova è uno scrigno di straordinaria ricchezza: città d’arte, colline, laghi, Llagune, castelli medioevali, borghi rurali e aree termali, il tutto collegato da una fitta rete di vie d’acqua. La sola chiave di accesso alla completa rivelazione di questo tesoro è la bicicletta. Nessun altro mezzo di locomozione offre infatti al viaggiatore la velocità ideale per cogliere la multiforme bellezza dei paesaggi, la libertà di spostamento e la gratificazione fisica che può dare una piacevole escursione su due ruote. on questa nuova pubblicazione la Provincia di Padova e l’azienda Turismo Padova Terme CEuganee invitano tutti, dai ciclisti più allenati alle famiglie con bambini, a scoprire i migliori percorsi cicloturistici del padovano. Un ampio ventaglio di proposte che stanno diventando vere e proprie piste ciclabili. Queste sono ideali per praticare lo slow bike ovvero la dimensione dolce, lenta e curiosa del cicloturismo, quella che per essere vissuta ha bisogno di una bicicletta scorrevole ed affidabile e di strade pianeggianti, prive di traffico, dove sia possibile incontrare persone, visitare città e scoprire paesaggi e specialità gastronomiche. I percorsi qui descritti infatti seguono per lo più gli argini dei fiumi e dei canali che bagnano in lungo e in largo la provincia. Tale peculiarità offre al cicloturista la possibilità di raggiungere Padova dalle principali destinazioni turistiche padovane e venete, pedalando su strade panoramiche e pianeggianti. razie al cicloturismo la Provincia di Padova intende valorizzare la fruizione dei corsi Gd’acqua dando a questi una nuova ragione ambientale e ricreativa. -

Provincia Di Padova Piano Provinciale Della Viabilita
II ysxgse2hs2ehye ettore2iilità esponsile2del2proedimentoX222ingF2ierluigi2gorzz sexy2ysxgsevi2hivve2sefsvse9 eqqsyxewixy2PHHS xF2ivefyey swe2ywwese2hiqvs2sxiswixs2 II pywey2eR E PE hHHIHIPFdo eepimento2emendmenti2ll9pprovzione QIGHVGHT wFxeri Ffmp wFwttezzi Felrdi Ffldo IEhHHIHIIFdo eepimento2osservzioni PSGHUGHT wFxeri Ffmp wFwttezzi Felrdi Ffldo HE hHHIHIHFdo PWGHWGHS wFfettio Ffmp Fssnnin Felrdi Ffldo evF xome2file hesrizione ht edtto erifFespF y gontrFg epprFespF isto2w gywwie pei yie hyg wixy eyve issyxs H R I W x E E E E E E E E h H H I H I H I P E sl2hirettore2enio sl2rogettist i2queroD2IP2E2QSHRQ2wonselie2@hA sl2presente2doumentoD2elorto2per2rovini2di2dov2d2xet2engineeringD2non2può2essere2riprodotto2o2omunito22terzi2senz2preventiv2utorizzzione2sritt PT0419N – Aggiornamento del Piano della Viabilità della Provincia di Padova STIMA SOMMARIA DEGLI INVESTIMENTI INDICE 1 PREMESSA ................................................................................................... 2 2 QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO................................................... 5 3 STIMA SOMMARIA DEGLI INVESTIMENTI ............................................... 11 4 STIMA SOMMARIA ALTRI INTERVENTI ................................................... 12 PT0419N -- -- ---- D RT 001 01 01 2- PT0419N--------DRT0010101_2-.doc Pagina 1 di 90 PT0419N – Aggiornamento del Piano della Viabilità della Provincia di Padova STIMA SOMMARIA DEGLI INVESTIMENTI 1 PREMESSA La stima degli investimenti necessari alla realizzazione del Piano è stata sviluppata in -

Avviso Di Deposito Variante N. 32 Al P.I
Città di Piove di Sacco Provincia di Padova SETTORE V – EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, AMBIENTE Orario di apertura al pubblico: martedì 15.30-18.00, mercoledì e venerdì 11.30-13.00 Protocollo Generale n. 270 AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE N. 32 AL PIANO DEGLI INTERVENTI IL RESPONSABILE DEL SETTORE V VISTI: l’articolo 18 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 così come successivamente modificata ed integrata; il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) denominato “Tra Brenta e Bacchiglione” tra i comuni di Arzergrande, Brugine, Piove di Sacco, Pontelongo, approvato dalla Conferenza di Servizi il 31 luglio 2008 e ratificata con deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2377 dell’8 agosto 2008; RENDE NOTO CHE: il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 73 del 22 dicembre 2020, ha adottato la Variante n. 32 al Piano degli Interventi per la ripianificazione delle aree di trasformazione ed espansione soggette a PUA decaduti, nonché per la previsione di una nuova disciplina per le aree oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, per le quali non sono state approvate le relative opere pubbliche;. Gli atti relativi, sono depositati, a disposizione del pubblico, dal 5 gennaio 2021 per 30 giorni e cioè fino al 4 febbraio 2021, presso la Segreteria Generale del Comune di Piove di Sacco; Nei successivi 30 giorni e cioè fino al 6 marzo 2021, chiunque può formulare osservazioni sulla variante adottata; Entro 60 giorni dalla scadenza di cui al comma precedente, il Comune con propria deliberazione di Consiglio Comunale si esprime sulle osservazioni presentate ed approva la variante in oggetto; La variante diventerà efficace 15 giorni dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dell’avviso di avvenuta approvazione. -
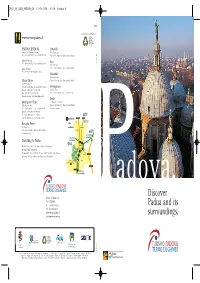
Discover Padua and Its Surroundings
2647_05_C415_PADOVA_GB 17-05-2006 10:36 Pagina A Realized with the contribution of www.turismopadova.it PADOVA (PADUA) Cittadella Stazione FS / Railway Station Porta Bassanese Tel. +39 049 8752077 - Fax +39 049 8755008 Tel. +39 049 9404485 - Fax +39 049 5972754 Galleria Pedrocchi Este Tel. +39 049 8767927 - Fax +39 049 8363316 Via G. Negri, 9 Piazza del Santo Tel. +39 0429 600462 - Fax +39 0429 611105 Tel. +39 049 8753087 (April-October) Monselice Via del Santuario, 2 Abano Terme Tel. +39 0429 783026 - Fax +39 0429 783026 Via P. d'Abano, 18 Tel. +39 049 8669055 - Fax +39 049 8669053 Montagnana Mon-Sat 8.30-13.00 / 14.30-19.00 Castel S. Zeno Sun 10.00-13.00 / 15.00-18.00 Tel. +39 0429 81320 - Fax +39 0429 81320 (sundays opening only during high season) Teolo Montegrotto Terme c/o Palazzetto dei Vicari Viale Stazione, 60 Tel. +39 049 9925680 - Fax +39 049 9900264 Tel. +39 049 8928311 - Fax +39 049 795276 Seasonal opening Mon-Sat 8.30-13.00 / 14.30-19.00 nd TREVISO 2 Sun 10.00-13.00 / 15.00-18.00 AIRPORT (sundays opening only during high season) MOTORWAY EXITS Battaglia Terme TOWNS Via Maggiore, 2 EUGANEAN HILLS Tel. +39 049 526909 - Fax +39 049 9101328 VENEZIA Seasonal opening AIRPORT DIRECTION TRIESTE MOTORWAY A4 Travelling to Padua: DIRECTION MILANO VERONA MOTORWAY A4 AIRPORT By Air: Venice, Marco Polo Airport (approx. 60 km. away) By Rail: Padua Train Station By Road: Motorway A13 Padua-Bologna: exit Padua Sud-Terme Euganee. Motorway A4 Venice-Milano: exit Padua Ovest, Padua Est MOTORWAY A13 DIRECTION BOLOGNA adova. -

Elenco Seggi 2019
ELEZIONI 2019 - UBICAZIONE DEFINITIVA SEGGI COMUNE RECAPITO COMUNE SEGGIO N. SEGGIO SEDE SEGGIO VIA N. CIVICO PR AVVISO CASA DELLE ABANO TERME 1 VIA DIAZ 98 ABANO TERME PD ASSOCIAZIONI CASA DELLE ABANO TERME 2 VIA DIAZ 98 ABANO TERME PD ASSOCIAZIONI SEDE MUNICIPALE - ALBIGNASEGO 3 VIA MILANO 7 ALBIGNASEGO PD SALA RIUNIONI SEDE MUNICIPALE - ALBIGNASEGO 4 VIA MILANO 7 ALBIGNASEGO PD SALA RIUNIONI ARZERGRANDE - SALA RIUNIONI C/O 5 VIA BASSA 3 ARZERGRANDE PD PONTELONGO CENTRO S. ANTONIO BOVOLENTA 6 SALA CONSILIARE VIA MAZZINI 17 BOVOLENTA PD BRUGINE 7 CENTRO AUSER PIAZZA UNGHERIA 14 BRUGINE PD CENTRO CULTURALE VIA PAPA GIOVANNI CASALSERUGO 8 2 CASALSERUGO PD HANGAR 9 XXIII CERVARESE S. BIBLIOTECA CROCE - 9 VIA MONTEMERLO 1 CERVARESE S. CROCE PD COMUNALE VEGGIANO 1 ELEZIONI 2019 - UBICAZIONE DEFINITIVA SEGGI COMUNE RECAPITO COMUNE SEGGIO N. SEGGIO SEDE SEGGIO VIA N. CIVICO PR AVVISO CODEVIGO - MUNICIPIO SALA VIA VITTORIO 10 33 CODEVIGO PD CORREZZOLA CONSILIARE EMANUELE III DUE CARRARE - BIBLIOTECA BATTAGLIA 11 COMUNALE - SALA VIA ROMA 95 DUE CARRARE PD TERME ALDO SIMONATO SALA FABRIZIO DE LEGNARO 12 VIA ROMA 20 LEGNARO PD ANDRE' SEDE MUNICIPALE - LIMENA 13 VIA ROMA 44 LIMENA PD SALA BARCHESSINA MASERA' DI SALA POLIVALENTE PADOVA - 14 VIA CONSELVANA 97 MASERA' DI PADOVA PD "CORTE DA ZARA" CARTURA MONTEGROTTO SEDE MUNICIPALE - 15 PIAZZA ROMA 1 MONTEGROTTO TERME PD TERME SALA MORRI NOVENTA AUDITORIUM SCUOLA PADOVANA - 16 MEDIA STATALE VIA VALMARANA 33 NOVENTA PADOVANA PD VIGONZA G.SANTINI SALA "A" PRESSO PADOVA Zona 17 SEDE DEL CONSIGLIO PIAZZA NAPOLI 40 PADOVA PD Centro DI QUARTIERE N. 5 PADOVA Cap = 18 SALA COMMISSIONI VIA GUASTI 12/C PADOVA PD 35124, 35125 2 ELEZIONI 2019 - UBICAZIONE DEFINITIVA SEGGI COMUNE RECAPITO COMUNE SEGGIO N. -

Mappa Delle Linee Extraurbane
MAPPA DELLE LINEE EXTRAURBANE Abano T. Piazza Fontana Padova Arcella Abano T. Villa Rigoni Padova Autostazione Abano Terme Stazione Padova Bassanello A B C D E F G H i Adria Padova Brusegana Aeroporto Marco Polo Padova Camin LEGENDA SCHEMA DELLE CORSIE DELL’AUTOSTAZIONE DI PADOVA INTERURBAN BUS TERMINAL Agna Padova Chiesanuova KEYS Viale della Pace, 1 - GPS: 45.4162111,11.8833668 e 029 Agripolis Campus Padova Corso Milano 1 e 036 1 Agugliaro Padova Guizza e 071 Capolinea e 038 Albignasego Padova Mandria Corsia 1 Corsia 3 Corsia 5 Corsia 7 Corsia 9 Corsia 11 First/last stop Platform 1 Platform 3 Platform 5 Platform 7 Platform 9 Platform 11 Corsia 13 Anguillara Veneta Padova Montà Linea 53E Platform 13 Arquà Petrarca Padova Ospedale Civile e 003 e 037 e 007 e 071 e 017 e A e071 Linea in transito e 041 Arre Padova Piazza Mazzini Running line e 006 e 033 e 073 e 018 e AT e 035 e 019 e ATL Arsego Padova Pontevigodarzere TSF e 060 Arzercavalli Padova Riviere Fermata di interscambio e 021 Bassano del Grappa e 040 e 020 e M Corsia 14 e 021 TSF Platform 14 Arzerello Padova S.Carlo Connection stop e 026 e T e 074 Arzergrande Padova Sacro Cuore Linea 101 e 031_6 e TL Padova Stanga Rosà e 001 VCE Linea feriale e festiva e 080 e 015 Badia Polesine Padova via Giotto Weekdays and Holydays e 002 e 010 Bus a lunga percorrenza Bagnoli di Sopra Padova via Toti 2 e 004 e 013 e 062 Long-distance buses 2 Baone Padova Voltabarozzo Linea prolungata Linea 208 e 005 e 016 Linea 80 e 063 Barbano Vicentino Padova Zona Industriale Cusinati Barbarano Palugana Extension -

Palazzo Pinato Valeri a Piove Di Sacco 4 INDICE
Palazzo Pinato Valeri a Piove di Sacco 4 INDICE Giorgio Bovo Presentazione pag. 7 Giorgio Meneghetti Il Recupero di un simbolo pag. 9 Fabio Zecchin Il Progetto di Restauro pag. 11 Romina Cattelan La Storia pag. 15 5 6 (…) O città che raggi laggiù nella nebbia il tuo alone lucente che vuoi da me? Certamente le tue vie le tue case la tua gente non mi conoscono più. Non per te son io ritornato, città di passato ! Ma qui riconosco la mia vita, qui ritrovo la mia poesia qui qui dovevo tornare da tanta inutile guerra, da tanta speranza fallita: a questo recinto di terra dove sento sboccare la lunga mia nostalgia, dov’è tutto quanto posso salvare, ancòra, dell’anima mia. [Diego Valeri, Il figliol prodigo] Sulla facciata del palazzo al civico 62 di via Garibaldi un’iscrizione lapidea ricorda che “ Il 25 gennaio 1887 nasceva in questa casa Diego Valeri, saggista e poeta …….”. Finora era questo il luogo di partenza di un ideale itinerario valeriano nella sua città natale che proseguiva poi nel Municipio ad ammirare il sipario di Alessio Valerio con il ritratto della madre Giovanna Elvira Fontana che acco - glie festante un capitano dell’esercito regio nel momento del passaggio della città dalla dominazione austriaca al Regno d’Italia, continuava presso il San - tuario mariano delle Grazie, luogo di devozione caro alla madre, e giungeva a conclusione presso la tomba di famiglia nel cimitero del Capoluogo dove il poeta riposa con la moglie Maria Minozzi e la figlia Giovanna. Le notizie contenute in questo libro, frutto delle ricerche e dell’accurato lavoro d’indagine e di scavo d’archivio compiuti dall’architetto Romina Cattelan, ci obbligano a rivoluzionare questo itinerario memoriale e a mettervi al primo posto il palazzo Pinato Valeri, finora identificato con l’anonima denomina - 7 zione di Palazzo neogotico. -

Sostegno Ai Centri Estivi 2021
SOSTEGNO AI CENTRI ESTIVI 2021 CENTRI ESTIVI AMMESSI A CONTRIBUTO (elencati in base all’Amministrazione Comunale che ne ha fatto richiesta) Il sostegno economico ai Centri Estivi è composto da un contributo fisso e da un contributo variabile, calcolato in base all’effettiva durata e partecipazione dei bambini/ragazzi al Centro Estivo. I dettagli e le modalità di erogazione saranno forniti attraverso una specifica comunicazione che verrà inviata agli Enti destinatari del contributo. CONTRIBUTO COMUNE RICHIEDENTE PROVINCIA COMPLESSIVO MASSIMO Comune di Adria RO 2.005,00 € Comune di Albignasego PD 3.180,00 € Comune di Anguillara Veneta PD 1.860,00 € Comune di Ariano nel Polesine RO 2.220,00 € Comune di Arquà Petrarca PD 2.040,00 € Comune di Arquà Polesine RO 3.228,00 € Comune di Arre PD 2.000,00 € Comune di Arzergrande PD 5.244,00 € Comune di Badia Polesine RO 3.200,00 € Comune di Barbona PD 1.884,00 € Comune di Borgo Veneto PD 5.340,00 € Comune di Bosaro RO 3.420,00 € Comune di Bovolenta PD 2.652,00 € Comune di Brugine PD 4.860,00 € Comune di Campo San Martino PD 5.340,00 € Comune di Campodoro PD 1.932,00 € Comune di Camposampiero PD 2.892,00 € Comune di Canda RO 1.884,00 € Comune di Carceri PD 1.980,00 € Comune di Carmignano di Brenta PD 6.396,00 € Comune di Cartura PD 2.940,00 € Comune di Casalserugo PD 4.620,00 € 1/3 SOSTEGNO AI CENTRI ESTIVI 2021 CONTRIBUTO COMUNE RICHIEDENTE PROVINCIA COMPLESSIVO MASSIMO Comune di Castelbaldo PD 2.820,00 € Comune di Castelguglielmo RO 3.348,00 € Comune di Castelmassa RO 3.180,00 € Comune di Ceregnano -

Landscapes Along the Great Rivers Be Bike and Boat Itineraries Tween the Brenta, Rs Adige and Po Rive
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali Landscapes along the great rivers be Bike and boat itineraries tween the Brenta, rs Adige and Po rive Provincia di Padova Venezia Legenda Index map Verona Padova Mira Campolongo 6 3 Maggiore Lago di Garda Lova di Battaglia Campagna Terme Bovolenta 5 Lupia How to use this guide Key Information About this book p. 2 Roverchiara 2 4 Montagnana Este Monselice Chioggia Transit network IAT (tourist information) This guide was designed to fit in 1 From the Alps to the Adriatic Sea p. 6 1 main road marina Villa the map pocket of the bicycle’s Mantova Bartolomea 2 The Walled Cities’ Loop p. 8 Lendinara Rosolina handlebar bag. railway line Castagnaro main docking point Adria Porto Levante Melara 7 Rovigo All maps display the compass rose, river/canal The Euganean Hills Loop (E2) p. 10 navigable waterway 3 Trecenta 10 Porto showing their orientation. 8 Viro lock 4 From Sugar to Salt p. 12 11 The double slash symbol Berra Itineraries on land Polesella Porto 9 indicates that the route continues connection between riverbanks Tolle The Brenta Bridleway p. 16 Mesola Scardovari cycling itineraries 5 in the following chart after the railway station Goro The Taglio Nuovissimo Canal p. 18 Ferrara same symbol. itinerary extension 6 starting point/arrival point Maps may not be completely up- From the river Adige to the Po p. 20 Itineraries on water main towns 7 to-date, due to recent changes; minor towns The Road to the Sea (I3.1) p. -

Qualità Dell'aria 2019 Relazione Tecnica Provincia
QUALITÀ DELL’ARIA 2019 RELAZIONE TECNICA PROVINCIA DI PADOVA Progetto e realizzazione Dipartimento Provinciale di Padova Responsabile: A. Benassi Servizio Monitoraggio e Valutazioni Responsabile: C. Gabrieli R.Millini, P. Baldan, E. Cosma, C. Lanzoni, A. Pagano, S. Rebeschini Con la collaborazione di: Dipartimento Regionale Laboratori Responsabile: F. Daprà È consentita la riproduzione di testi, tabelle, grafici ed in genere del contenuto del presente rapporto esclusivamente con la citazione della fonte. 22 giugno 2020 2 Indice 1 Introduzione 6 2 Quadro normativo7 2.1 Limiti e valori di riferimento............................... 7 2.2 Zonizzazione della Provincia di Padova ......................... 8 3 Informazioni sulla strumentazione e sulle analisi 10 3.1 Inquinanti misurati .................................... 10 3.2 Informazioni sulla strumentazione e sulle analisi..................... 11 3.3 Limiti di rivelabilità della strumentazione automatica.................. 11 4 Rete fissa di monitoraggio 13 4.1 Configurazione della rete................................. 13 4.2 Metadati delle stazioni di qualità dell’aria........................ 14 5 Rete mobile di monitoraggio 16 5.1 Configurazione della rete................................. 16 5.2 Campagne effettuate nel 2019 .............................. 16 5.3 Campagne effettuate nel periodo 2009-2019....................... 17 6 Analisi meteorologica 2019 19 6.1 Precipitazioni....................................... 19 6.2 Condizioni di dispersione degli inquinanti........................ 21 6.3 Condizioni che favoriscono elevate concentrazioni di Ozono .............. 23 6.4 Inversione termica e PM10 elevati ............................ 24 6.4.1 Evento 04-14/01/2019 .............................. 25 6.4.2 Evento 14-22/02/2019 .............................. 26 6.4.3 Evento 25/02/2019-07/03/2019 ......................... 27 6.4.4 Evento 05-10/12/2019 .............................. 28 7 Qualità dell’Aria nel 2019 29 7.1 Biossido di Zolfo....................................