Scuola E Ricerca 2017.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Download Report 2010-12
RESEARCH REPORt 2010—2012 MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR WISSENSCHAFTSGESCHICHTE Max Planck Institute for the History of Science Cover: Aurora borealis paintings by William Crowder, National Geographic (1947). The International Geophysical Year (1957–8) transformed research on the aurora, one of nature’s most elusive and intensely beautiful phenomena. Aurorae became the center of interest for the big science of powerful rockets, complex satellites and large group efforts to understand the magnetic and charged particle environment of the earth. The auroral visoplot displayed here provided guidance for recording observations in a standardized form, translating the sublime aesthetics of pictorial depictions of aurorae into the mechanical aesthetics of numbers and symbols. Most of the portait photographs were taken by Skúli Sigurdsson RESEARCH REPORT 2010—2012 MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR WISSENSCHAFTSGESCHICHTE Max Planck Institute for the History of Science Introduction The Max Planck Institute for the History of Science (MPIWG) is made up of three Departments, each administered by a Director, and several Independent Research Groups, each led for five years by an outstanding junior scholar. Since its foundation in 1994 the MPIWG has investigated fundamental questions of the history of knowl- edge from the Neolithic to the present. The focus has been on the history of the natu- ral sciences, but recent projects have also integrated the history of technology and the history of the human sciences into a more panoramic view of the history of knowl- edge. Of central interest is the emergence of basic categories of scientific thinking and practice as well as their transformation over time: examples include experiment, ob- servation, normalcy, space, evidence, biodiversity or force. -
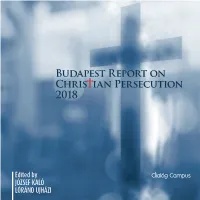
Budapest Report on Chris Ian Persecution 2018
“ e Budapest Report, presenting the situation of persecuted Christian communities in the world is published in 2018 for the second time. e Hungarian Government initiated the publication of a summary report in 2017 with the aim of familiarizing the Hungarian general and scienti c community with the traditions, life and prospects of speci c Christian communities in a credible manner every year. e report was also published in English last year making it accessible for the international community as well. […] e publication does not simply provide comprehensive information on persecuted Christians, but it also aims at promoting solidarity and assistance to persecuted communities.” Budapest Report on Cardinal Péter Erdő the Primate of Hungary, Archbishop of Esztergom–Budapest Chris ian Persecution “ e foundations of our program are common sense and social 2018 solidarity […] In the near future, our intent is to make more people realize: the transformation of the faulty Western aspect and the stability of the crisis regions may bring about change in the protection of the persecuted Christians and all communities living in the a ected countries. Our cause, in which we can also count on the help of the Visegrád countries, is a noble one. […] I wish that reports on persecuted Christians would become redundant as soon as possible, in which respect we have a lot to do together. I trust that this book will make benevolent people act, so that the peace we have promised may come true.” Zsolt Semjén 2018 ON CHRISTIAN PERSECUTION REPORT BUDAPEST Deputy -

Stoney Road out of Eden: the Struggle to Recover Insurance For
Scholarly Commons @ UNLV Boyd Law Scholarly Works Faculty Scholarship 2012 Stoney Road Out of Eden: The Struggle to Recover Insurance for Armenian Genocide Deaths and Its Implications for the Future of State Authority, Contract Rights, and Human Rights Jeffrey W. Stempel University of Nevada, Las Vegas -- William S. Boyd School of Law Sarig Armenian David McClure University of Nevada, Las Vegas -- William S. Boyd School of Law, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholars.law.unlv.edu/facpub Part of the Contracts Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, Law and Politics Commons, National Security Law Commons, and the President/Executive Department Commons Recommended Citation Stempel, Jeffrey W.; Armenian, Sarig; and McClure, David, "Stoney Road Out of Eden: The Struggle to Recover Insurance for Armenian Genocide Deaths and Its Implications for the Future of State Authority, Contract Rights, and Human Rights" (2012). Scholarly Works. 851. https://scholars.law.unlv.edu/facpub/851 This Article is brought to you by the Scholarly Commons @ UNLV Boyd Law, an institutional repository administered by the Wiener-Rogers Law Library at the William S. Boyd School of Law. For more information, please contact [email protected]. STONEY ROAD OUT OF EDEN: THE STRUGGLE TO RECOVER INSURANCE FOR ARMENIAN GENOCIDE DEATHS AND ITS IMPLICATIONS FOR THE FUTURE OF STATE AUTHORITY, CONTRACT RIGHTS, AND HUMAN RIGHTS Je:jrev' W. Stempel Saris' ArInenian Davi' McClure* Intro d uctio n .................................................... 3 I. The Long Road to the Genocide Insurance Litigation ...... 7 A. The Millet System of Non-Geographic Ethno-Religious Administrative Autonomy ........................... -

Thorny Geopolitical Problems in the Palace G Archives. the Ebla Southern Horizon, Part One: the Middle Orontes Basin
Syria Archéologie, art et histoire IV | 2016 Le fleuve rebelle Thorny Geopolitical Problems in the Palace G Archives. The Ebla Southern Horizon, Part One: the Middle Orontes Basin Marco Bonechi Electronic version URL: http://journals.openedition.org/syria/4985 DOI: 10.4000/syria.4985 ISSN: 2076-8435 Publisher IFPO - Institut français du Proche-Orient Printed version Date of publication: 1 December 2016 Number of pages: 29-87 ISBN: 978-2-35159-725-5 ISSN: 0039-7946 Electronic reference Marco Bonechi, « Thorny Geopolitical Problems in the Palace G Archives. The Ebla Southern Horizon, Part One: the Middle Orontes Basin », Syria [Online], IV | 2016, Online since 01 December 2018, connection on 07 May 2020. URL : http://journals.openedition.org/syria/4985 ; DOI : https://doi.org/ 10.4000/syria.4985 © Presses IFPO SUPPLÉMENT IV SOMMAIRE VOLUME DE TEXTES SUPPLÉMENT IV Liste des contributeurs....................................................................................................................................................................3 Le fleuve rebelle Parayre.(D.),.Introduction............................................................................................................................................................5 d’Ebla à l’époque médiévale Al.Dbiyat..(M.),.L’Oronte, un fleuve de peuplement séculaire dans un milieu contrasté.....................................................................9 Le moyen Oronte au fil du temps : textes, objets, images Géographie historique du moyen Oronte Bonechi.(M.),.Thorny -

La Città. I Labirinti Sotterranei Sono La Più Grande Insidia
Sabato 29 Ottobre 2016 MONDO 15 La resa dei conti IL PREMIER CURDO tedesco “Bild”. «Ma quando Mosul sarà liberata noi ci riuniremo con i nostri Barzani: dopo la conquista partner a Baghdad per parlare della nostra indipendenza. Abbiamo aspettato Gli ostaggi sarebbero «si tratterà l’indipendenza» troppo a lungo; dopo il 2003 (anno stati «posizionati» intorno dell’invasione dell’Iraq di Saddam Il premier curdo-iracheno Nechirvan Hussein da parte della coalizione Usa, ai presidi militari Barzani ha detto che, una volta conclusa ndr) pensavamo che ci sarebbe stato un dei fondamentaliste per frenare la battaglia di Mosul e ripresa la città dai nuovo inizio per un nuovo Iraq jihadisti dello Stato islamico, bisognerà democratico. Ma questo Iraq ha fallito», l’avanzata dell’esercito cominciare a parlare di indipendenza del ha proseguito il capo del governo curdo. e dei curdi. «Chi si rifiuta, Kurdistan, regione autonoma dell’Iraq. «È «Qui noi non siamo arabi, ma una nazione da tanto ormai che i tempi sono maturi curda. La comunità internazionale deve viene fucilato sul posto» per l’indipendenza, ma per il momento anche vedere le cose in modo realistico», E i combattenti sciiti si dicono concentriamoci sulla battaglia contro il ha insistito il leaderdel Kurdistan Daesh», ha dichiarato Barzani al tabloid iracheno Barzani. pronti all’assalto a Tal Afar Profughi fuggiti ad Hassaké dalla città di Mosul nelle mani del Daesh (LaPresse/Reuters) «A Mosul 8mila famiglie scudi umani» La denuncia dell’Onu: il Daesh fa razzie nei villaggi vicini «Ormai è imminente» l’attacco finale alla capitale jihadista LUCA MIELE a Mosul – il fianco meridionale, orien- dal sobborgo di Nimrud e dal distretto gi si contano 11.753 persone che han- tale e settentrionale – avanzano i sol- di al-Hamdaniya». -

Guida-Siria Italiano.Pdf
ASSAFRICA & MEDITERRANEO Banca UBAE, nata nel 1972 come “Unione È l’Associazione specializzata del Sistema delle Banche Arabe ed Europee”, è un’im- Confindustria che rappresenta e supporta le presa bancaria a capitale italo-arabo. imprese italiane operanti o interessate a svilup- Gli azionisti di Banca UBAE includono parsi nei 70 Paesi del Mediterraneo, Africa e importanti banche: Libyan Foreign Bank, Medio Oriente. National Société Générale Bank, Bank Al- Unica Associazione intersettoriale e specializza- Maghrib, Banque Marocaine du Commerce ta per area geografica del Sistema Confindustria Extérieur, UniCredit, Monte dei Paschi di e suo principale centro specialistico per l’inter- Siena (Sansedoni), Intesa Sanpaolo e grandi nazionalizzazione delle imprese in tali mercati, imprese italiane: Gruppo ENI (SOFID) e Assafrica & Mediterraneo associa grandi gruppi Telecom Italia. industriali, banche e piccole e medie imprese. Queste due caratteristiche portano l’Asso- La missione ciazione ad effettuare un costante ed approfon- che Banca UBAE si pone è dito monitoraggio sull’evoluzione economica quella di diventare il consulente di fiducia ed industriale della regione e delle opportunità e il partner privilegiato per le aziende dei suoi mercati, per supportare adeguatamente ed istituzioni finanziarie che vogliono l’attività delle imprese italiane e soddisfarne la introdurre o incrementare relazioni, domanda di business e partenariato imprendito- commerciali, industriali, economiche e riale in collegamento con le organizzazioni finanziarie tra l’Europa ed i Paesi del imprenditoriali degli altri Paesi dell’area. Your Partner in Trade Banking Nord Africa e del Medio Oriente. Assafrica & Mediterraneo è anche l’unica An- Banca UBAE offre un’ampia gamma di tenna italiana per il settore privato del CDE, servizi e vanta una specializzazione unica l’Agenzia per lo Sviluppo delle PMI nei Paesi in tutte le forme di assistenza creditizia ACP (Africa, Carabi e Pacifico), affiancandosi verso i suoi paesi di riferimento: finanzia- all’ICE per l’area pubblica. -

Si Può Restare Indifferenti?
Pontificia Accademia delle Scienze Workshop on Siria 126.000 morti e 300.000 bambini orfani in trentasei mesi di conflitto si può restare indifferenti? Syria With a death toll of 126,000 and 300,000 orphans in 36 months of war, can we remain indifferent? 13 Gennaio 2014 • Casina Pio IV • Città del Vaticano Il contesto p. 3 • Background p. 4 • Programme p. 6 • Observers p. 7 • Biographies of Participants p. 8 • Memorandum p. 11 Digiuno per la Siria, 7 settembre 2013 • Fast for Syria, 7 September 2013 Purtroppo – afferma nel messaggio indirizzato a Vladimir Putin in quanto presidente di turno – duole constatare che troppi intere“ssi di parte hanno prevalso da quando è iniziato il conflitto siriano, impedendo di trovare una soluzione che evitasse l’inutile massacro a cui stiamo assistendo. [ ... ] è un dovere morale di tutti i governi del mondo favorire ogni iniziativa volta a promuovere l’assistenza umanitaria a chi soffre a causa del conflitto dentro e fuori dal Paese. (Papa Francesco, lettera a Vladimir Putin in occasione del Vertice del G20 di San Pietroburgo, 4 settembre 2013) It is regrettable that, from the very beginning of the conflict in Syria – he affirmed in his letter to Vladimir Putin, the rotating president of the G20 – one-sided interests have prevailed and in fact hindered the search for a solution that would have avoided the senseless massacre now unfolding. [... ] all governments have the moral duty to do everything possible to ensure humanitarian assistance to those suffering because of the conflict, both within and beyond the country’s borders. -

Ebla's Hegemony and Its Impact on the Archaeology of the Amuq Plain
Ebla’s Hegemony and Its Impact on the Archaeology of the Amuq Plain in the Third Millennium BCE by Steven Edwards A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Near and Middle Eastern Civilizations University of Toronto © Copyright by Steven Edwards, 2019 Ebla’s Hegemony and Its Impact on the Archaeology of the Amuq Plain in the Third Millennium BCE Steven Edwards Doctor of Philosophy Department of Near and Middle Eastern Studies University of Toronto 2019 Abstract This dissertation investigates the emergence of Ebla as a regional state in northwest Syria during the Early Bronze Age and provides a characterization of Ebla that emphasizes its hegemonic rather than imperial features. The texts recovered from the Royal Palace G archives reveal that Ebla expanded from a small Ciseuphratean kingdom into a major regional power in Upper Mesopotamia over the course of just four or five decades. To consolidate and maintain its rapidly growing periphery, Ebla engaged in intensive diplomatic relations with an array of client states, semi-autonomous polities, and independent kingdoms. Often, political goals were achieved through mutual gift-exchange and interdynastic marriage, but military activity became increasingly common towards the end of the period covered by the texts. However, apart from installing palace officials at some cities, Ebla did not appear to have invested heavily in building infrastructure, such as roads or forts, along its periphery, preferring instead to leave matters of defense up to client and allied states. As a result, the archaeological impact of Ebla’s political hegemony along parts of its periphery was minimal. -

© in This Web Service Cambridge University
Cambridge University Press 978-0-521-76443-8 - Mobile Pastoralism and the Formation of Near Eastern Civilizations: Weaving Together Society Anne Porter Index More information INDEX ab x áš, 232, 233, 310 an, 151 See also dingiv Abarsal, 248 Anatolia, 14, 19, 77, 81, 157 Abi-Sare, 315 ancestor, 189 aboveground monuments, 166, 175, 176, 177, ancestor (ancestral), 34, 42, 49, 56, 57, 60, 79, 180, 197, 228 118, 133–34, 142, 146, 150, 152–61, 174, abu Amurrim, 317 180, 189–97, 209, 213, 217, 218, 219, 226, abu Emutbala, 317 228–31, 233, 236–38, 257, 267–72, 276, Abu Salabikh, 83, 88, 125, 134, 140, 158 277, 287, 319, 321 Abur-Li’m, 214 apical, 61, 277 accession ritual, 213, 229, 230, 231. See also group, 60–63, 134, 157, 173, 175, 177, 195, wedding ritual 196, 197, 198, 306, 307, 318, 322, 325, Ada, 238 326–28 ’Adabal, 217, 220, 221, 222, 310 house, 133, 156, 174–98, 229 Adams, Robert McC., 5, 245, 246 temple, 190 Addu-Duri, 32 traditions, 133, 138, 174, 190, 195, 228, 229, Adgar-kidug, 294 230, 234 Aga, 258, 277 Andarig, 318 agency, 2, 40, 46, 62, 77, 189, 246 Anderson, Benedict, 46, 57 Agu, 216 animal husbandry, 1, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20, Ah Purattim, 34 23, 114, 138, 140, 144, 153, 174, 240–47, 324 Akkad (Agade), 34, 79, 268, 269, 278, 284, Aniru, 214 292, 323 Anshan, 296, 303–05, 307, 308, 321 Curse of, 288, 290, 292, 323 anthropological archaeology, 37–41, 42, 71, 100, Akkadian(s), 4, 37, 62, 81, 162, 194, 252, 259–60, 105, 129, 198, 202, 240 263, 266–71, 279, 288, 291, 300, 309, 314, Anu terrace, 123, 127. -

223175118.Pdf
L’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, con sede in Roma, in conformità alla Legge 23 ottobre 2003, n. 293 e secondo i suoi fini istituzionali, promuove e incoraggia studi nelle discipline giuridiche, economiche ed umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche e linguistiche, nonché, più in generale, alle discipline che analizzano i problemi della società contem- poranea. Presidenza: Piazza Navona, 93 – 00186 Roma tel: 06/6865904 fax: 06/6878252 Ufficio Ricerca Scientifica: Corso Rinascimento, 19 – 00186 Roma tel: 06/6879580 fax: 06/68300090 e-mail: [email protected]; [email protected]. Ricerca a cura di Domenico Melidoro e Simone Sibilio, realizzata dall’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, dal Dipartimento di Scienze Politiche della LUISS “Guido Carli” e dal Ministero degli Affari Esteri. ISBN 978-88-7233-112-5 Copyright 2014 Editrice APES S.r.l. Piazza Navona, 93 – 00186 ROMA È vietata la riproduzione, anche parziale con qualsiasi mezzo effettuata, com- presa la fotocopia, anche ad uso interno e didattico, non autorizzata. Domenico Melidoro e Simone Sibilio (a cura di) Voci dal mondo arabo Cronache e testimonianze delle transizioni in Egitto, Siria, Tunisia e Yemen Premessa di Sebastiano Maffettone Postfazione di Francesca M. Corrao Con contributi di Sadeq Abu Hamed Mohamed Haddad Hanin Hanafi Nadia al-Saqqaf Editrice APES 2014 4 A cura di Domenico Melidoro e Simone Sibilio Voci dal mondo arabo 5 Indice PREMESSA di Sebastiano Maffettone ........................................................11 -

The River Qoueiq and Its Importance for Ebla (Syria) at the Time of the Archives (Xxiv Cent
THE RIVER QOUEIQ AND ITS IMPORTANCE FOR EBLA (SYRIA) AT THE TIME OF THE ARCHIVES (XXIV CENT. BC): SOME OBSERVATION Maria Giovanna Biga-Ahmad Karbotly (Sapienza Università di Roma) ABSTRACT The river Qoueiq (which flows close to the big city of Aleppo) has been important in the history of Syria already in the third millennium BC. Along its valley there are many tells, studied mostly in surveys from the 1970s; some of them are certainly to be dated to the third millennium BC and their name could be present in the Ebla texts. They are not yet identified with ancient cities. Tell Tuqan, on the lake Matkh in which the river disappears, or Tell Hader in the river valley, can likely be identified with NIrar of the Ebla texts. KEY WORDS: River Qoueiq, surveys, lake Matkh, Tell Tuqan, Tell Hader, kingdom of NIrar. RIASSUNTO Il fiume Qoueiq (che scorre presso la città di Aleppo) è stato importante anche nella storia della Siria del III millennio a.C. Nella sua valle ci sono molti tell, studiati per lo più in surveys a partire dagli anni ‘70. Alcuni di loro sono certamente da datare al III millennio a.C., ma non è possibile identificarli con toponimi menzionati nei testi di Ebla. Tell Tuqan, sul lago Matkh nel quale il fiume si getta, o Tell Hader possono essere identificati tentativamente con la città di NIrar dei testi di Ebla. PAROLE CHIAVE Fiume Qoueiq, surveys, lago Matkh, Tell Tuqan, Tell Hader, regno di NIrar. 1. Introduction The capital city of Ebla (modern Tell Mardikh, Syria, around 60 kms South West of Aleppo) was in internal Syria and not on a river or on a lake. -

182 Israel, Hizbollah and Iran-Preventing Another War in Syria
Israel, Hizbollah and Iran: Preventing Another War in Syria Middle East Report N°182 | 8 February 2018 Headquarters International Crisis Group Avenue Louise 149 • 1050 Brussels, Belgium Tel: +32 2 502 90 38 • Fax: +32 2 502 50 38 [email protected] Preventing War. Shaping Peace. Table of Contents Executive Summary ................................................................................................................... i I. Introduction ..................................................................................................................... 1 II. Israeli Policy toward Syria ................................................................................................ 2 A. Israel’s Red Lines ....................................................................................................... 2 B. Enter Hizbollah .......................................................................................................... 5 III. The Russians Are Coming! ............................................................................................... 7 A. Russia to Assad’s Rescue ........................................................................................... 7 B. Israel’s Updated Red Lines ........................................................................................ 9 IV. U.S. Rollback or Russian Balancing? ............................................................................... 15 V. Preventing the Next War .................................................................................................