Relazione Idrologica ANAS S.P.A
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lo Stato Di Attuazione Del Programma
XVII LEGISLATURA servizio studi LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE Dalla “legge obiettivo” alle opere prioritarie XVII LEGISLATURA servizio studi Lo stato di attuazione del Programma 10° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione n. 234 - 2016 servizio studi XVII LEGISLATURA servizio studi LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE Dalla “legge obiettivo” alle opere prioritarie Lo stato di attuazione del Programma 10° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione n. 234 parte seconda - maggio 2016 Documentazione e ricerche: Le infrastrutture strategiche - Dalla “legge obiettivo” alle opere prioritarie” – 10° Rapporto per la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici: - Nota di sintesi e focus tematici, n. 234 Parte prima, maggio 2016; - Lo stato di attuazione del Programma, n. 234 Parte seconda, maggio 2016. Il presente Rapporto è stato predisposto dal Servizio Studi a seguito della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici del 29 luglio 2015, in collaborazione con l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Istituto di ricerca CRESME. La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. Servizio responsabile: SERVIZIO STUDI Dipartimento Ambiente 066760-9253 [email protected] CD_ambiente INDICE CAPITOLO PRIMO Evoluzione del Programma e scenari di riferimento 1 1.1. -
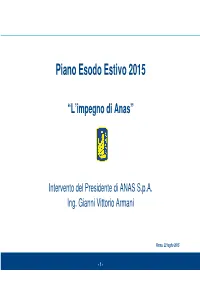
(Microsoft Powerpoint
Piano Esodo Estivo 2015 “L’impegno di Anas” Intervento del Presidente di ANAS S.p.A. Ing. Gianni Vittorio Armani Roma, 22 luglio 2015 - 1 - Il Piano Esodo 2015 è elaborato da Anas in collaborazione con: - 2 - Cosa vuole chi viaggia GLI ITALIANI IN VACANZA Vedere risolte le difficoltà Ricevere assistenza e le emergenze ed aiuto nei casi nel più breve di problemi tempo possibile meccanici o in caso di necessità Un viaggio sicuro, Essere informato senza difficoltà sul traffico - 3 - Le risposte di Anas • Risolvere le emergenze di viabilità: Viadotto Italia della A3 • Monitorare 24 ore su 24 il traffico sulla rete stradale nazionale dedicando risorse e mezzi • Individuare e ridurre i cantieri presenti sulla rete stradale autostradale di competenza, in particolare sugli itinerari dell vacanze • Predisporre, ove possibile, un piano di viabilità alternativ in corrispondenza dei cantieri inamovibili e comunque di gestion delle criticità • Predisporre - assieme agli altri attori della mobilità - il calendari del traffico con i “giorni critici” • Predisporre il piano di comunicazione per i viaggiator rafforzando i canali di informazione - 4 - Il monitoraggio e le risorse umane 1 Sala Operativa Nazionale (in funzione h24) 20 Sale Operative Compartimentali In turnazione, circa 2.500 addetti per la sorveglianza, il pronto intervento, l’assistenza ai clienti, il coordinamento delle attività tecniche e di gestione e la comunicazione 1070 automezzi, 1800 telecamere, 300 pannelli a messaggio variabile - 5 - Il monitoraggio dei tratti critici A3 Salerno-Reggio -

Regolamento Dell'operazione a Premio PAYBACK Gennaio 2014
Regolamento dell’operazione a premio PAYBACK gennaio 2014 – febbraio 2017 1. Introduzione Il presente documento (“Regolamento del Programma PAYBACK”) disciplina il funzionamento dell’operazione a premio multi-partner denominata PAYBACK gennaio 2014 – febbraio 2017 (il “Programma”) e le condizioni di partecipazione al Programma, compresa l’assegnazione di punti PAYBACK® e l’attribuzione di premi ai partecipanti. Una copia del Regolamento del Programma PAYBACK può essere richiesta gratuitamente al Servizio Clienti PAYBACK® al seguente numero verde 800 93 00 93 da rete fissa o al numero 099 2320880 da rete mobile (costi e tariffe in funzione dell’operatore utilizzato), attivo dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 21.00 ed è disponibile sul sito www.payback.it. 2. Programma PAYBACK Il Programma è organizzato e gestito da PAYBACK Italia S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza Mignanelli 25 (“PAYBACK”) in associazione con: GS S.p.A. e le società Diperdì S.r.l. e S.S.C. Società di Sviluppo Commerciale S.r.l., tutte con sede legale in Milano, Via Caldera 21 nonché i titolari dei punti vendita a insegna del gruppo Carrefour aderenti elencati nell’allegato C, Esso Italiana S.r.l., con sede legale in Roma, Via Castello della Magliana 25 e le stazioni di servizio a marchio Esso aderenti elencati nell’allegato D, Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno 8, Alitalia S.p.A., con sede legale in Fiumicino (RM), Piazza Almerico da Schio Pal. RPU, Alitalia Loyalty S.p.A., con sede legale in Fiumicino (RM), Via Alberto Nassetti snc, American Express Services Europe Limited, sede secondaria per l’Italia, con sede legale in Roma, Largo Caduti di El Alamein 9, Seri Jakala S.r.l., con sede legale in Milano, Via Carlo Tenca 14, H3G S.p.A., con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leonardo da Vinci 1, Carrefour Banque Succursale Italiana, con sede legale in Milano, Via Caldera 21, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto 119 (insieme con PAYBACK, i “Promotori”). -

Rassegna Stampa Di G [Orno
Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE RASSEGNA STAMPA DI G [ORNO 14-4-2017 A cura di Sandro Cuzari Responsabile Ufficio Stampa CAS Quotidiano Data 14-04-2017 GIORNALE DI SICILIA Pagina 1 +4/5 PALERMO ePROVINCIA Foglio 1/3 LA BUFERA SUI CAS. I «furbetti dell'incentivo» I FURBETTI DELL'INCENTIVO Autostrade & affari ILSISTEMA PER POTER SPARTIRE UN MILIONE £300 MILA EURC Ecco tutti i lavori Una «miniera» finiti sotto inchiesta SULLA MESSINA-PALERMO dalle autostrade, IN CODA PER I TANTI CANTIERI ANSALONI E BARBERA ALLE PAGINE 4 E 5 così il Consorzio accontentava tutti O Nelle carte dell'inchiesta l'elenco dei lavori «fantasma» Liquidati 32.944 euro per un progetto della Siracusa-Gela Altri 35.262 per uno spartitraffico della Messina-Catania recati negli uffici del consorzio auto- 2012 riguarda i lavori per il ripristino stradale per chiedere quali fossero i delle barriere di sicurezza danneggia- Letìzia Barbera progetti a sostegno di quegli incentivi te a seguito di incidenti lungo la Messi- MbSSINA mainaicunicasi nonhanno trovato al- na-Palermo. L'incentivo complessi- •••II ripristino di barriere a seguito di cun progetto che potesse giustificare vamente liquidato fu dÌ33.128euro. La incidenti stradali, la stabilizzazione di quegli incentivi mentre in altri casi i documentazione a supporto risulta frane, le opere per rimuovere condi- progetti c'erano ma, sulla scorta di una assente. Il decreto 201 del 2012 riguar- zioni di pericolo lungo i Eratti autostra- consulenza tecnica, sono risultati dava lavori di manutenzione straordi- dali, lavori di manutenzione agli im- mancanti di alcuni documenti. naria di rifacimento della pavimenta- pianti elettrici e di pavimentazione. -

Allegato "A" Al D.D.G. N° 968 Del 26/10/2020 - Elenco Sedi Disponibili Per Il 3° Interpello
Allegato "A" al D.D.G. n° 968 del 26/10/2020 - Elenco sedi disponibili per il 3° interpello DESCRIZIONE N. PROGRESSIVO DESCRIZIONE DELLA SEDE TIPO SEDE CRITERIO TOPOGRAFICO PREVISTA INDENNITA' DESCRIZIONE PROVINCIA CODICE ISTAT COMUNE COMUNE COMUNE FARMACEUTICA FARMACEUTICA DELLA SEDE FARMACEUTICA DI AVVIAMENTO Campobello di Comprende le frazioni di "Tre Fontane" e Trapani 81004 4 Vacante SI NO Mazara "Torretta Granitola". Zona di Sperone interessando le vie: Assieni da Piazza Sperone, fino alla intersezione con la Via Zara, Via Sperone e Scucina fino all'intersezione NO NO Trapani 81007 Custonaci 2 con Via Zara, Via S. Vito, da Piazza Sperone fino Di nuova istituzione alla Via Valderice. Zara e traverse, S. Vito e traverse fino all'intersezione di Via Valderice. Trapani 81009 Favignana 3 Isola di Marettimo Vacante NO SI Trapani 81011 Marsala 21 C.de Bosco-Pecorume, Ciappola e Dara. Di nuova istituzione NO NO Quartiere "Mazara 2" - con l'esclusione del tratto NO NO Trapani 81012 Mazara del Vallo 14 Via Degli Archi. Di nuova istituzione Zona Trasmazzaro/Tonnarella - tratto di Via del Mare (dal Lungomare Fata Morgana a Via NO NO Trapani 81012 Mazara del Vallo 15 America), Via America, con esclusione del tratto Di nuova istituzione di Via Bessarione. Zona Bocca Arena/Falcone-Borsellino - Via California, tratto della Via Napoli (da Via California a Via Belluno), Via Belluno, Strada Provinciale Mazara - Torretta Granitola (da Via NO NO Trapani 81012 Mazara del Vallo 16 California fino al confine del Comune di Di nuova istituzione Campobello, ed agglomerato urbano di Torretta Granitola, con l'esclusione del tratto Lungomare San Vito e tratto Viale Africa). -

2007, Pp. 127-145 CARTA GEOMORFOLOGICA DEL BACINO
Naturalista sicil., S. IV, XXXI (3-4), 2007, pp. 127 -145 VALERIO AGNESI , C HIARA CAPPADONIA & C HRISTIAN CONOSCENTI CARTA GEOMORFOLOGICA DEL BACINO IDROGRAFICO DEL RIO SPINASANTA E NOTE ILLUSTRATIVE (SICILIA CENTRO-SETTENTRIONALE) RIASSUNTO Le presenti note illustrative accompagnano la Carta Geomorfologia del Rio Spinasanta, nella quale sono descritte le forme del rilievo presenti nel bacino e vengono individuati i processi morfo - genetici in atto. Il Rio Spinasanta è un affluente del Fiume Imera Settentrionale (o Fiume Grande), di cui occupa le porzioni di testata, lungo lo spartiacque regionale che ne divide il bacino da quello del Fiume Imera Meridionale (o Fiume Salso); per la redazione della carta è stata utilizzata, come base topografica, la Sezione n° 621040 (Monte Piombino) della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000. La carta geomorfologica del bacino è stata realizzata tramite l’integrazione di differenti meto - dologie , quali il rilevamento diretto di tipo geologico e geomorfologico, l’analisi aerofotogramme - trica di foto aeree ed ortofoto. La caratterizzazione geomorfologica dell’area è stata inoltre suppor - tata dall’analisi delle caratteristiche pluviometriche e dall’analisi spaziale delle forme, eseguita tramite l’ausilio di un software GIS; quest’ultima ha permesso di produrre delle tabelle relative alla distribuzione delle forme del rilievo in relazione alle caratteristiche litologiche e fisiografiche, quali esposizione e pendenza dei versanti. Lo studio condotto ha evidenziato come le diverse combinazioni di questi fattori influenzino la distribuzione spaziale delle forme del rilievo e l’intensità dei processi in atto, causando, inoltre, una differenziazione del paesaggio all’interno del bacino tra le aree poste in destra idrografica e quelle situate nelle zone centrali ed in sinistra idrografica. -

Industria Di Marca Distribuzione Moderna
INDUSTRIA DI MARCA | DISTRIBUZIONE MODERNA Mappatura Offerta di Trasporto Ferroviario Novembre 2016 Indice1 ECR Italia .............................................................................................................................. 6 Introduzione .......................................................................................................................... 7 Imprese ferroviarie ................................................................................................................ 8 *Captrain Italia S.r.l. ............................................................................................................................. 8 ChemOil Logistics AG – Filiale Italiana .............................................................................................. 10 Compagnia Ferroviaria Italiana .......................................................................................................... 11 DB Schenker Rail Italia Services S.r.l. ............................................................................................... 12 *ERS Railways B.V. ........................................................................................................................... 13 Nordcargo S.r.l. .................................................................................................................................. 15 Oceanogate Italia S.p.A. .................................................................................................................... 16 Rail Cargo Italia S.r.l. ........................................................................................................................ -

Partiamo Dopo Pranzo, Circa Alle 15, Ed Entriamo Nell'autostrada A1 Da Arezzo in Direzione Sud, Verso Civitavecchia Dove Ci As
Partiamo dopo pranzo, circa alle 15, ed entriamo nell’autostrada A1 da Arezzo in direzione sud, verso Civitavecchia dove ci aspetta il traghetto. Usciamo quindi ad Attigliano, in quanto vi erano code per uscire ad Orte, ed entriamo dentro Bomarzo. Ci fermiamo poco dopo il paese per una pausa, e riprendiamo la strada, entrando così nella SS675 in direzione Viterbo. Dopo Vetralla la 4 corsie finisce e prendiamo così la SS1bis, che ci conduce fino a Tarquinia, lungo la quale i molti cantieri fanno pensare ad un allungamento della 4 corsie verso il mare. Qui prendiamo l’A12 ed usciamo a Civitavecchia Porto, da dove con la E840 arriviamo al porto. Siamo in anticipo, e dopo svariati tentativi nella ricerca del cartello con scritto Termini Imerese, ci viene indicato che quello giusto è per Tunisi. Ci mettiamo così in coda aspettando che venga aperto il cancello per entrare nell’area d’imbarco, ma al momento dell’apertura ci viene detto che prima dobbiamo fare il check-in, ossia cambiare il biglietto acquistato online con quello effettivo, che noi ovviamente non sapevamo. Possiamo così entrare nell’area d’imbarco, e mangiando i nostri panini aspettiamo di essere chiamati per salire sulla nave. Al nostro momento veniamo fatti salire nel piano superiore, al garage D, e da qui una volta parcheggiato il camper possiamo salire a bordo. Ci vengono consegnate le chiavi per la cabina, che troviamo subito, dopo aver individuato con un po’ di difficoltà il terzo letto, andiamo a visitare il traghetto GNV. Andiamo subito sopra, da dove vediamo il tramonto sul mare e l’Argentario, e Civitavecchia che pian piano entra nella notte, intanto parte un traghetto Tirrenia per la Sardegna. -

The 2015 Scillato Landslide (Sicily, Italy): Deformational Behavior Inferred from Satellite & Terrestrial SAR Interferometry
The 2015 Scillato Landslide (Sicily, Italy): deformational behavior inferred from Satellite & Terrestrial SAR Interferometry Moretto S. NHAZCA S.r.l., spin-off of “Sapienza” University of Rome, Via Vittorio Bachelet 12, Rome, 00185, Italy, [email protected] Bozzano F. “Sapienza” University of Rome, Department of Earth Sciences, P.le Aldo Moro 5, Rome, 00185, Italy, [email protected] NHAZCA S.r.l., spin-off of “Sapienza” University of Rome, Via Vittorio Bachelet 12, Rome, 00185, Italy CERI, Centro di Ricerca di Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici, P.le Aldo Moro 5, Rome, 00185, Italy Brunetti A. NHAZCA S.r.l., spin-off of “Sapienza” University of Rome, Via Vittorio Bachelet 12, Rome, 00185, Italy, [email protected] Della Seta M. “Sapienza” University of Rome, Department of Earth Sciences, P.le Aldo Moro 5, Rome, 00185, Italy, [email protected] Majetta S. ANAS S.p.A., Via L. Pianciani 16, 00185, Rome, Italy, [email protected] Mazzanti P. NHAZCA S.r.l., spin-off of “Sapienza” University of Rome, Via Vittorio Bachelet 12, Rome, 00185, Italy, [email protected] “Sapienza” University of Rome, Department of Earth Sciences, P.le Aldo Moro 5, Rome, 00185, Italy Rocca A. NHAZCA S.r.l., spin-off of “Sapienza” University of Rome, Via Vittorio Bachelet 12, Rome, 00185, Italy, [email protected] Valiante M. “Sapienza” University of Rome, Department of Earth Sciences, P.le Aldo Moro 5, Rome, 00185, Italy, [email protected] FMGM 2018 SUMMARY: This paper is focused on a landslide occurred the 10th April, 2015 in Northern Sicily (Southern Italy), involving the lower portion of a slope on the left bank of the Imera River. -

S S E G a M. O
v*-j \ Consorzio per AUTOSTRADE SICILIANE S S E G A M. O IORN 9-5-2017 A cura di Sandro Cuzari Responsabile Ufficio Stampa CAS L'intervista al presidente dell'Arias che ieri è stato in città <(Per l'Alta velocità serve il Ponte» Armani; finanziabile dalle Ferrovie. L'unione col Cas è una chance di sviluppo na. Lei porta avanti il piano dì Alessandro Turnlno tenziosi nati nel rapporto tra oltre il 50% in manutenzioni mento delle Ferrovie. Proprio il imprese e stazioni appaltanti. straordinarie, il che significa fusione Fs-Anas come grande Ponte è l'esempio migliore di Compie due anni la sua presi- Quanto al personale siamo in- autorizzazioni più semplici, occasione per dare all'estre- come le opere più importanti denza dell'Anas, la società delle tervenuti dove necessario, eli- progettazione e cantierabffità mo Sudun nuovo futuro. Mail siano il frutto di un'ottica pro- strade e autostrade italiane, da minando certi compromessi po- molto più immediata. Ma so- Def del Governo blocca l'Alta gettuale integrativa. Il collega- luì assunta il 18 maggio 2015. litici con il territorio, utilizzan- prattutto attuiamo un nuovo velocità a Salerno ed in Sicilia mento autostradale non giusti- Gì Unasfida che definire delicata è do le tecnologie, sbloccando modo di procedere: non più un proponesolo studi di fattibili- fica un pedaggio sufficiente- > eufemistico, al timone di quel- l'assunzione di un migliaio di lotto gigantesco alla volta, ma tà sull'Alta velo cita rìdottaPa- mente remunerativo per il ge- N l'ente chiamato a gestire al me- tecnici e ripristinando le figure opere lungo tutta una direttri- lermo-Catania, e la revisione store che sia, al contempo, ac- glio oltre 26.000 chilometri, territoriali. -

3. Contatto Culturale E Interrelazioni Tra Greci E Indigeni Nel Territorio Di Himera
Henri Tréziny (dir.) Grecs et indigènes de la Catalogne à la mer Noire Actes des rencontres du programme européen Ramses2 (2006-2008) Publications du Centre Camille Jullian 3. Contatto culturale e interrelazioni tra Greci e indigeni nel territorio di Himera Oscar Belvedere Editore: Publications du Centre Camille Jullian, Éditions Errance Luogo di pubblicazione: Aix-en-Provence Anno di pubblicazione: 2010 Data di messa in linea: 13 febbraio 2020 Collana: Bibliothèque d’archéologie méditerranéenne et africaine ISBN digitale: 9782957155729 http://books.openedition.org Edizione cartacea Data di pubblicazione: 1 giugno 2010 Notizia bibliografica digitale BELVEDERE, Oscar. 3. Contatto culturale e interrelazioni tra Greci e indigeni nel territorio di Himera In: Grecs et indigènes de la Catalogne à la mer Noire: Actes des rencontres du programme européen Ramses2 (2006-2008) [online]. Aix-en-Provence: Publications du Centre Camille Jullian, 2010 (creato il 03 avril 2020). Disponibile su Internet: <http://books.openedition.org/pccj/241>. ISBN: 9782957155729. 3. Contatto culturale e interrelazioni tra Greci e indigeni nel territorio di Himera Oscar Belvedere a prospezione archeologica del territorio ime- rese ha interessato le valli dei fiumi Imera settentrionale (alla cui foce sorge la colonia greca),L Torto e S. Leonardo, che costituiscono le princi- pali vie di comunicazione dalla costa verso l’entroterra (fig. 42) 1. La prospezione è stata condotta con metodo intensivo e sistematico nell’area tra l’Imera e il Torto, immediatamente alle spalle della città ; tra l’Imera e il torrente Roccella, a Est della colonia ; nella bassa valle del Torto e nella media valle del S. Leonardo, ad Ovest 2 ; e ancora sul versante occidentale dell’Imera e nell’area di spartiacque tra quest’ultimo e il Salso. -

BILANCIO 2019 RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2019 Anas S.P.A
BILANCIO 2019 RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2019 Anas S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002) Capitale Sociale: euro 2.269.892.000,00 i.v. Sede Legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma Codice Fiscale e Registro delle Imprese: 80208450587 R.E.A.: 1024951 Partita IVA: 02133681003 Sito web: www.stradeanas.it Umbria – Direttrice Perugia-Ancona, strada statale 318 ‘di Valfabbrica’ Anas Bilancio 2019 Anas Bilancio 2019 MISSIONE DELLA SOCIETÀ ORGANI SOCIALI Anas S.p.A. gestisce la rete stradale e autostradale italiana non a pedaggio di interesse nazionale ed è sottoposta Consiglio di Amministrazione*: al controllo e alla vigilanza tecnica e operativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Grazie al Presidente Dott. Claudio Andrea Gemme notevole bagaglio di esperienza accumulato in oltre 90 anni di attività e alle competenze del personale, Anas Amministratore Delegato Ing. ha ampliato la gamma dei servizi offerti, svolgendo attività di supporto agli enti pubblici e offrendosi come Massimo Simonini elemento catalizzatore in Italia e all’estero nei servizi di progettazione, costruzione e manutenzione della rete Consigliere Arch. Ivo Roberto Cassetta viaria. Consigliere Dott.ssa Vera Fiorani L’impegno della Società nella progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture stradali si concentra Consigliere Avv. Antonella D’Andrea sulla sicurezza della rete, tutela dell’ambiente, efficienza energetica nonché sulla salvaguardia del patrimonio paesaggistico del nostro territorio. L’obiettivo di Anas è quello di garantire la realizzazione del Contratto di Programma, nel rispetto dei tempi e Collegio Sindacale**: dei costi preventivati, la continuità territoriale della rete e una viabilità sempre più sicura ed efficiente, anche Presidente Dott.ssa Antonella Bientinesi attraverso lo studio e l’uso di tecnologie innovative.