Analisi Della Fauna Ittica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

S Italy Is a Contracting Party to All of the International Conventions a Threat to Some Wetland Ibas (Figure 3)
Important Bird Areas in Europe – Italy ■ ITALY FABIO CASALE, UMBERTO GALLO-ORSI AND VINCENZO RIZZI Gargano National Park (IBA 129), a mountainous promontory along the Adriatic coast important for breeding raptors and some open- country species. (PHOTO: ALBERTO NARDI/NHPA) GENERAL INTRODUCTION abandonment in marginal areas in recent years (ISTAT 1991). In the lowlands, agriculture is very intensive and devoted mainly to Italy covers a land area of 301,302 km² (including the large islands arable monoculture (maize, wheat and rice being the three major of Sicily and Sardinia), and in 1991 had a population of 56.7 million, crops), while in the hills and mountains traditional, and less resulting in an average density of c.188 persons per km² (ISTAT intensive agriculture is still practised although land abandonment 1991). Plains cover 23% of the country and are mainly concentrated is spreading. in the north (Po valley), along the coasts, and in the Puglia region, A total of 192 Important Bird Areas (IBAs) are listed in the while mountains and hilly areas cover 35% and 41% of the land present inventory (Table 1, Map 1), covering a total area of respectively. 46,270 km², equivalent to c.15% of the national land area. This The climate varies considerably with latitude. In the south it is compares with 140 IBAs identified in Italy in the previous pan- warm temperate, with almost no rain in summer, but the north is European IBA inventory (Grimmett and Jones 1989; LIPU 1992), cool temperate, often experiencing snow and freezing temperatures covering some 35,100 km². -

Iberian Cyprinids: Habitat Requirements and Vulnerabilities
Session 1 Cyprinid species: ecology and constraints Iberian cyprinids: habitat requirements and vulnerabilities 2nd Stakeholder Workshop – Iberia – Lisboa, Portugal 20.03.2019 Francisco Godinho Hidroerg 20/03/2018 Francisco Godinho 1 Setting the scene 22/03/2018 Francisco Godinho 2 Relatively small river catchmentsIberian fluvial systems Douro/Duero is the largest one, with 97 600 km2 Loire – 117 000 km2, Rhinne -185 000 km2, Vistula – 194 000 km2, Danube22/03/2018 – 817 000 km2, Volga –Francisco 1 380 Godinho 000 km2 3 Most Iberian rivers present a mediterranean hydrological regime (temporary rivers are common) Vascão river, a tributary of the Guadiana river 22/03/2018 Francisco Godinho 4 Cyprinidae are the characteristic fish taxa of Iberian fluvial ecosystems, occurring from mountain streams (up to 1000 m in altitude) to lowland rivers Natural lakes are rare in the Iberian Peninsula and most natural freshwater bodies are rivers and streams 22/03/2018 Francisco Godinho 5 Six fish-based river types have been distinguished in Portugal (INAG and AFN, 2012) Type 1 - Northern salmonid streams Type 2 - Northern salmonid–cyprinid trans. streams Type 3 - Northern-interior medium-sized cyprinid streams Type 4 - Northern-interior medium-sized cyprinid streams Type 5 - Southern medium-sized cyprinid streams Type 6 - Northern-coastal cyprinid streams With the exception of assemblages in small northern, high altitude streams, native cyprinids dominate most unaltered fish assemblages, showing a high sucess in the hidrological singular 22/03/2018 -
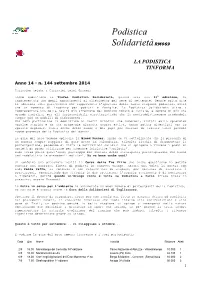
Podistica Solidarietàrm069
Podistica Solidarietà RM069 LA PODISTICA TINFORMA Anno 14 - n. 144 settembre 2014 Carissime amiche e Carissimi amici Orange, anche quest’anno il Trofeo Podistica Solidarietà , giunto alla sua 11 a edizione , ha rappresentato uno degli appuntamenti di riferimento del mese di settembre. Sempre molto alte le adesioni alla gara/evento che rappresenta l’apertura della nuova stagione podistica oltre che un momento di incontro per podisti e famiglie. La Podistica Solidarietà oltre a rappresentare una delle realtà più affermate del podismo romano e laziale, è sempre di più una grande famiglia, per gli irrinunciabili caratteristiche che la contraddistinguono rendendola sempre più un modello di riferimento. Una nota particolare la dedichiamo ai nostri Arancini che numerosi, aiutati dalla splendida cornice storica e da una gradevole giornata ancora estiva, hanno potuto divertirsi con lo spirito migliore. Tanti occhi delle mamme e dei papà per cercare di trovare tante piccole nuove promesse della Podistica del domani. Le gare del mese vedono spiccare la Blood Runner , anche se va sottolineato che la presenza di un numero sempre maggiore di gare messe in calendario, talvolta rischia di frammentare la partecipazione, perdendo di vista le motivazioni solidali che si spingono a vincere i premi di società da poter utilizzare per numerose iniziative “solidali”. Buon terzo posto quest’anno, purtroppo ben lontani dalle straripanti partecipazioni che hanno contraddistinto le precedenti edizioni. Ma va bene anche così! Si conferma una piacevole realtà la Corsa delle Tre Ville che anche quest’anno ha potuto vantare una numerosa flotta di podisti in canotta Orange. Ancora una volta la Nostra Top Lady Paola Patta , si conferma e non finisce mai di stupire, per costanza di risultati e prestazioni, conquistando due vittorie in due settimane; l'augurio ovviamente è di continuare a ripetersi, perché quando un'Orange vince è tutta la Podistica a farlo (frase presa in prestito, grazie Forrest ). -

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE Dipartimento Di Studi Umanistici
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE Dipartimento di Studi Umanistici Dottorato di ricerca in Storia, territorio e patrimonio culturale XXXII ciclo Tesi di Dottorato TRASFORMAZIONI DELL’USO E DELLA COPERTURA DEL SUOLO, DINAMICHE TERRITORIALI E RICOSTRUZIONI GIS NEI POSSEDIMENTI PONTINI DELLA FAMIGLIA CAETANI (XIX- XXI SECOLO) Dottorando: Diego Gallinelli Tutor: Prof.ssa Carla Masetti Anno Accademico 2019-2020 1 INDICE Introduzione p. 6 1 Approccio teorico-metodologico 1.1 L’analisi geostorica per studiare le trasformazioni del territorio p. 12 1.2 Gli strumenti GIS per la ricostruzione degli assetti territoriali del passato p. 19 1.3 Le fonti d’archivio della Fondazione Camillo Caetani p. 21 2 Aspetti generali della Pianura Pontina 2.1 Inquadramento territoriale p. 25 2.2 Inquadramento storico e politico p. 45 2.3 Il ruolo della famiglia Caetani p. 52 3 Le risorse della palude 3.1 Un ambiente complesso ma ricco di opportunità p. 64 3.2 La pesca nelle acque pontine p. 78 3.3 Le peschiere dei Caetani: il caso di Fogliano p. 92 3.4 I conflitti per la gestione delle acque p. 100 4 Le bonifiche nel corso dei secoli 4.1 I tentativi di bonifica precedenti a Pio VI p. 108 4.2 La bonifica di Pio VI p. 129 4.3 La bonifica del Novecento p. 150 5 Cisterna di Latina: storia ed evoluzione p. 165 2 6 Ricostruzioni GIS dell’uso e della copertura del suolo nell’antico territorio di Cisterna p. 177 6.1 Uso e copertura del suolo attraverso le mappe del Catasto Gregoriano 6.1.1 Le mappe del Catasto Gregoriano p. -

Piano Del Parco Relazione Generale Tomo 3 Indirizzi Ed Azioni
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO PIANO DEL PARCO RELAZIONE GENERALE TOMO 3 INDIRIZZI ED AZIONI SOMMARIO I. INDIRIZZI ED AZIONI DEL PIANO 5 A. Introduzione 5 1. Struttura degli elaborati 6 2. Dimensione strategico-strutturale del Piano 7 B. INDIRIZZI ED AZIONI PER GLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE: Identificazione di grandi aree di naturalità omogenee 8 1. Indirizzi ed Azioni per la conservazione della foresta demaniale (SIC IT6040014 “Foresta Demaniale del Circeo”) 9 2. Indirizzi e azioni per la Conservazione del complesso dei Laghi Costieri (SIC IT6040012 “Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell’Inferno”) 10 3. indirizzi e azioni per la Conservazione del Lago di Paola (SIC IT6040013 “Lago di Sabaudia” ) 20 4. indirizzi e azioni per la Conservazione del Promontorio del Circeo (SIC IT6040016 “Promontorio del Circeo - Quarto Caldo”, IT6040017 “Promontorio del Circeo - Quarto Freddo”) 21 5. indirizzi e azioni per la Conservazione dell’Isola di Zannone (SIC IT6040020 “Isole di Palmarola e Zannone”) 24 6. Indirizzi e azioni per la conservazione degli ambiti marini limitrofi al Parco Nazionale del Circeo 27 7. indirizzi e azioni per la Conservazione del Sistema Dunale (SIC IT6040018 “Dune del Circeo”) 27 8. Conservazione della rete ecologica sulla rete dei canali, delle frangivento e delle aree agricole 28 9. Indirizzi per le attività di prevenzione incendi e per il Piano Antincendi del Parco 28 10. Indirizzi di gestione ecosistemica per il Piano di Gestione della ZPS (Zona di Protezione Speciale “Parco Nazionale del Circeo”) 28 C. Conservazione di specie ed habitat di interesse nazionale, comunitario ed internazionale 29 1. Reintroduzione del Capriolo italico (e del Gatto selvatico) 29 2. -

1 Serena Zaccara 2 Department of Theoretical and Applied
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Bournemouth University Research Online 1 Correspondence: 2 Serena Zaccara 3 Department of Theoretical and Applied Sciences, University of Insubria, Via J. H. 4 Dunant, 3 – 21100 – Varese (VA), Italy. 5 Phone: +39 0332 421422 6 E-mail: [email protected] 7 8 Morphologic and genetic variability in the Barbus fishes (Teleostei, Cyprinidae) of 9 Central Italy 10 11 12 ZACCARA SERENA1, QUADRONI SILVIA1, VANETTI ISABELLA1, CAROSI 13 ANTONELLA2, LA PORTA GIANANDREA2, CROSA GIUSEPPE1, BRITTON ROBERT 14 3, LORENZONI MASSIMO2 15 16 1Department of Theoretical and Applied Sciences, University of Insubria, Varese (VA) - 17 Italy 18 2Department of Chemistry, Biology and Biotechnology, University of Perugia, Perugia 19 (PG) - Italy 20 3Centre for Conservation Ecology and Environmental Change, Bournemouth University, 21 Poole, Dorset - UK 22 23 Running title: Barbels dispersion in central Italy 24 Zaccara et al. 25 Zaccara et al. 1 26 Zaccara, S. (2018) New patterns of morphologic and genetic variability of barbels 27 (Teleostei, Cyprinidae) in central Italy. Zoologica Scripta, 00, 000-000. 28 29 Abstract 30 31 Italian freshwaters are highly biodiverse, with species present including the native 32 fishes Barbus plebejus and Barbus tyberinus that are threatened by habitat alteration, 33 fish stocking and invasive fishes, especially European barbel Barbus barbus. In central 34 Italy, native fluvio-lacustrine barbels are mainly allopatric and so provide an excellent 35 natural system to evaluate the permeability of the Apennine Mountains. Here, the 36 morphologic and genetic distinctiveness was determined for 611 Barbus fishes collected 37 along the Padany-Venetian (Adriatic basins; PV) and Tuscany-Latium (Tyrrhenian 38 basins; TL) districts. -

Actinopterygii, Cyprinidae) En La Cuenca Del Mediterráneo Occidental
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS TESIS DOCTORAL Filogenia, filogeografía y evolución de Luciobarbus Heckel, 1843 (Actinopterygii, Cyprinidae) en la cuenca del Mediterráneo occidental MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Miriam Casal López Director Ignacio Doadrio Villarejo Madrid, 2017 © Miriam Casal López, 2017 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Facultad de Ciencias Biológicas Departamento de Zoología y Antropología física Phylogeny, phylogeography and evolution of Luciobarbus Heckel, 1843, in the western Mediterranean Memoria presentada para optar al grado de Doctor por Miriam Casal López Bajo la dirección del Doctor Ignacio Doadrio Villarejo Madrid - Febrero 2017 Ignacio Doadrio Villarejo, Científico Titular del Museo Nacional de Ciencias Naturales – CSIC CERTIFICAN: Luciobarbus Que la presente memoria titulada ”Phylogeny, phylogeography and evolution of Heckel, 1843, in the western Mediterranean” que para optar al grado de Doctor presenta Miriam Casal López, ha sido realizada bajo mi dirección en el Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales – CSIC (Madrid). Esta memoria está además adscrita académicamente al Departamento de Zoología y Antropología Física de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Considerando que representa trabajo suficiente para constituir una Tesis Doctoral, autorizamos su presentación. Y para que así conste, firmamos el presente certificado, El director: Ignacio Doadrio Villarejo El doctorando: Miriam Casal López En Madrid, a XX de Febrero de 2017 El trabajo de esta Tesis Doctoral ha podido llevarse a cabo con la financiación de los proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación. Además, Miriam Casal López ha contado con una beca del Ministerio de Ciencia e Innovación. -

Guide to Monogenoidea of Freshwater Fish of Palaeartic and Amur Regions
GUIDE TO MONOGENOIDEA OF FRESHWATER FISH OF PALAEARTIC AND AMUR REGIONS O.N. PUGACHEV, P.I. GERASEV, A.V. GUSSEV, R. ERGENS, I. KHOTENOWSKY Scientific Editors P. GALLI O.N. PUGACHEV D. C. KRITSKY LEDIZIONI-LEDIPUBLISHING © Copyright 2009 Edizioni Ledizioni LediPublishing Via Alamanni 11 Milano http://www.ledipublishing.com e-mail: [email protected] First printed: January 2010 Cover by Ledizioni-Ledipublishing ISBN 978-88-95994-06-2 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted or utilized in any form or by any means, electonical, mechanical, photocopying or oth- erwise, without permission in writing from the publisher. Front cover: /Dactylogyrus extensus,/ three dimensional image by G. Strona and P. Galli. 3 Introduction; 6 Class Monogenoidea A.V. Gussev; 8 Subclass Polyonchoinea; 15 Order Dactylogyridea A.V. Gussev, P.I. Gerasev, O.N. Pugachev; 15 Suborder Dactylogyrinea: 13 Family Dactylogyridae; 17 Subfamily Dactylogyrinae; 13 Genus Dactylogyrus; 20 Genus Pellucidhaptor; 265 Genus Dogielius; 269 Genus Bivaginogyrus; 274 Genus Markewitschiana; 275 Genus Acolpenteron; 277 Genus Pseudacolpenteron; 280 Family Ancyrocephalidae; 280 Subfamily Ancyrocephalinae; 282 Genus Ancyrocephalus; 282 Subfamily Ancylodiscoidinae; 306 Genus Ancylodiscoides; 307 Genus Thaparocleidus; 308 Genus Pseudancylodiscoides; 331 Genus Bychowskyella; 332 Order Capsalidea A.V. Gussev; 338 Family Capsalidae; 338 Genus Nitzschia; 338 Order Tetraonchidea O.N. Pugachev; 340 Family Tetraonchidae; 341 Genus Tetraonchus; 341 Genus Salmonchus; 345 Family Bothitrematidae; 359 Genus Bothitrema; 359 Order Gyrodactylidea R. Ergens, O.N. Pugachev, P.I. Gerasev; 359 Family Gyrodactylidae; 361 Subfamily Gyrodactylinae; 361 Genus Gyrodactylus; 362 Genus Paragyrodactylus; 456 Genus Gyrodactyloides; 456 Genus Laminiscus; 457 Subclass Oligonchoinea A.V. -

Regione Lazio Deliberazione N
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 474 DEL 15/01/2020 Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI STRUTTURA Area: QUALITA' DELL'AMBIENTE PROPONENTE Prot. n. ___________________ del ___________________ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Revoca della D.G.R. 15 febbraio 2013 n. 44 e individuazione della nuova rete di monitoraggio qualitativo dei corpi idrici superficiali della Regione Lazio. DL.vo 152/2006 e s.m.i.. ___________________________(PISTONI SILVIA) ___________________________(RODOLICO SILVANA) ___________________________(P. ZANGARA) ___________________________(F. TOSINI) ___________________________ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E PROPONENTE RISORSE NATURALI ___________________________(Onorati Enrica) L'ASSESSORE DI CONCERTO ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ IL DIRETTORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni ___________________________ SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 27/02/2020 prot. 89 ISTRUTTORIA: ____________________________________ ____________________________________ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE ____________________________________ -

LATIUM Kunst Und Kultur Im Mittelalter
Otto Lehmann-Brockhaus LATIUM Kunst und Kultur im Mittelalter herausgegeben von Gerhard Wiedmann Bibliotheca Hertziana Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte INHALT VORWORT DES HERAUSGEBERS 4 Editorische Notiz 5 Die Provinzen in Latium 5 I. GESCHICHTE UND GEOGRAPHIE 6 Der Name Latium im Wandel der Geschichte 6 Geographie 9 Die Gebirge 9 · Die Ebenen und ihre Umgestaltung 17 II. BEVÖLKERUNG UND BILDUNG 26 Die Gesellschaft im Wandel der Geschichte 26 Bevölkerung 26 · West- und Ostgoten 27 · Langobarden (568 – 774) 27 · Sarazenen 29 · Das fortschreitende Mittelalter 32 · Neuzeit 33 · Juden 35 · Diözesen 39 · Latiale Päpste im 1. Jahrtausend 41 Bildung und Kultur in Latium 42 Bildung und Persönlichkeiten 42 · Bibliotheken und Akademien 52 · Dichtung und Musik 58 · Buchdruck 59 III. DIE KUNST IM 1. JAHRTAUSEND 62 Katakomben 62 Architektur 75 Krypten 88 · Urbanistik und Stadtbefestigungen 89 Plastik 92 Frühchristliche Sarkophage 93 · Weitere Reliefplastik 100 Malerei 121 Einzelstücke von Kunstwerken 126 IV. DIE KUNST IM MITTELALTER NACH DEM JAHRE 1000 129 Architektur der Kirchen und Klöster 133 11. Jahrhundert und Beginn des 12. Jahrhundert 133 · 12. Jahrhundert und Übergang zum 13. Jahrhundert 161 · 13. Jahrhundert und Übergang zum 14. Jahrhundert 241 · 14. Jahrhundert 279 Die Baukunst des Zisterzienserordens 290 Krypten 309 Kreuzgänge bis zum Jahre 1500 329 Weltliche Architektur im Mittelalter 339 Burgen, Stadtbefestigungen, Türme 345 Paläste 366 Hospitäler, Brücken, Gefängnisse 381 Wohnbau 383 Plastik 388 Grabmonumente 402 Arbeiten mit Marmorsteinchen (Cosmaten arbeiten) 411 11. bis 14. Jahrhundert 411 Malerei 427 11. Jahrhundert 427 · 12. Jahrhundert und Übergang zum 13. Jahrhundert 442 · 13. Jahrhundert und Übergang zum 14. Jahrhundert 464 · 14. Jahrhundert und Übergang zum 15. -

D.1.1 Guidance on Stream Barrier Surveying and Reporting. Part A: Locating, Surveying and Prioritising Mitigation Actions for Stream Barriers
Ref. Ares(2016)6721952 - 01/12/2016 D.1.1 Guidance on Stream Barrier Surveying and Reporting. Part A: Locating, Surveying and Prioritising Mitigation Actions for Stream Barriers. This is version 1.0 of Guidance on Stream Barrier Surveying and Reporting. Part A: Locating, Surveying and Prioritising Mitigation Actions for Stream Barriers. This document is a deliverable of the AMBER project, which has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Programme for under Grant Agreement (GA) #689682. D1.1: Guidance on Stream Barrier Surveying and Reporting. Part A: Locating, Surveying and Prioritising Mitigation Actions for Stream Barriers. November, 2016. Author(s): James Kerr (SOTON), Andrew Vowles (SOTON), Jesse O’Hanley (IBK), Paul Kemp (SOTON) for The AMBER Consortium. November 2016 DISCLAIMER The opinion stated in this report reflects the opinion of the authors and not the opinion of the European Commission. All intellectual property rights are owned by the AMBER consortium members and are protected by the applicable laws. Except where otherwise specified, all document contents are: “©AMBER Project - All rights reserved”. Reproduction is not authorized without prior written agreement. The commercial use of any information contained in this document may require a license from the owner of that information. All AMBER consortium members are also committed to publish accurate and up to date information and take the greatest care to do so. However, the AMBER consortium members cannot accept liability for any inaccuracies or omissions nor do they accept liability for any direct, indirect, special, consequential or other losses or damages of any kind arising out of the use of this information. -

International Standardization of Common Names for Iberian Endemic Freshwater Fishes Pedro M
Limnetica, 28 (2): 189-202 (2009) Limnetica, 28 (2): x-xx (2008) c Asociacion´ Iberica´ de Limnolog´a, Madrid. Spain. ISSN: 0213-8409 International Standardization of Common Names for Iberian Endemic Freshwater Fishes Pedro M. Leunda1,∗, Benigno Elvira2, Filipe Ribeiro3,6, Rafael Miranda4, Javier Oscoz4,Maria Judite Alves5,6 and Maria Joao˜ Collares-Pereira5 1 GAVRN-Gestion´ Ambiental Viveros y Repoblaciones de Navarra S.A., C/ Padre Adoain 219 Bajo, 31015 Pam- plona/Iruna,˜ Navarra, Espana.˜ 2 Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Biolog´a, Departamento de Zoolog´a y Antropolog´a F´sica, 28040 Madrid, Espana.˜ 3 Virginia Institute of Marine Science, School of Marine Science, Department of Fisheries Science, Gloucester Point, 23062 Virginia, USA. 4 Universidad de Navarra, Departamento de Zoolog´a y Ecolog´a, Apdo. Correos 177, 31008 Pamplona/Iruna,˜ Navarra, Espana.˜ 5 Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciencias,ˆ Centro de Biologia Ambiental, Campo Grande, 1749-016 Lis- boa, Portugal. 6 Museu Nacional de Historia´ Natural, Universidade de Lisboa, Rua da Escola Politecnica´ 58, 1269-102 Lisboa, Portugal. 2 ∗ Corresponding author: [email protected] 2 Received: 8/10/08 Accepted: 22/5/09 ABSTRACT International Standardization of Common Names for Iberian Endemic Freshwater Fishes Iberian endemic freshwater shes do not have standardized common names in English, which is usually a cause of incon- veniences for authors when publishing for an international audience. With the aim to tackle this problem, an updated list of Iberian endemic freshwater sh species is presented with a reasoned proposition of a standard international designation along with Spanish and/or Portuguese common names adopted in the National Red Data Books.