L'ospizio Di Pollegio Nel Quattrocento
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
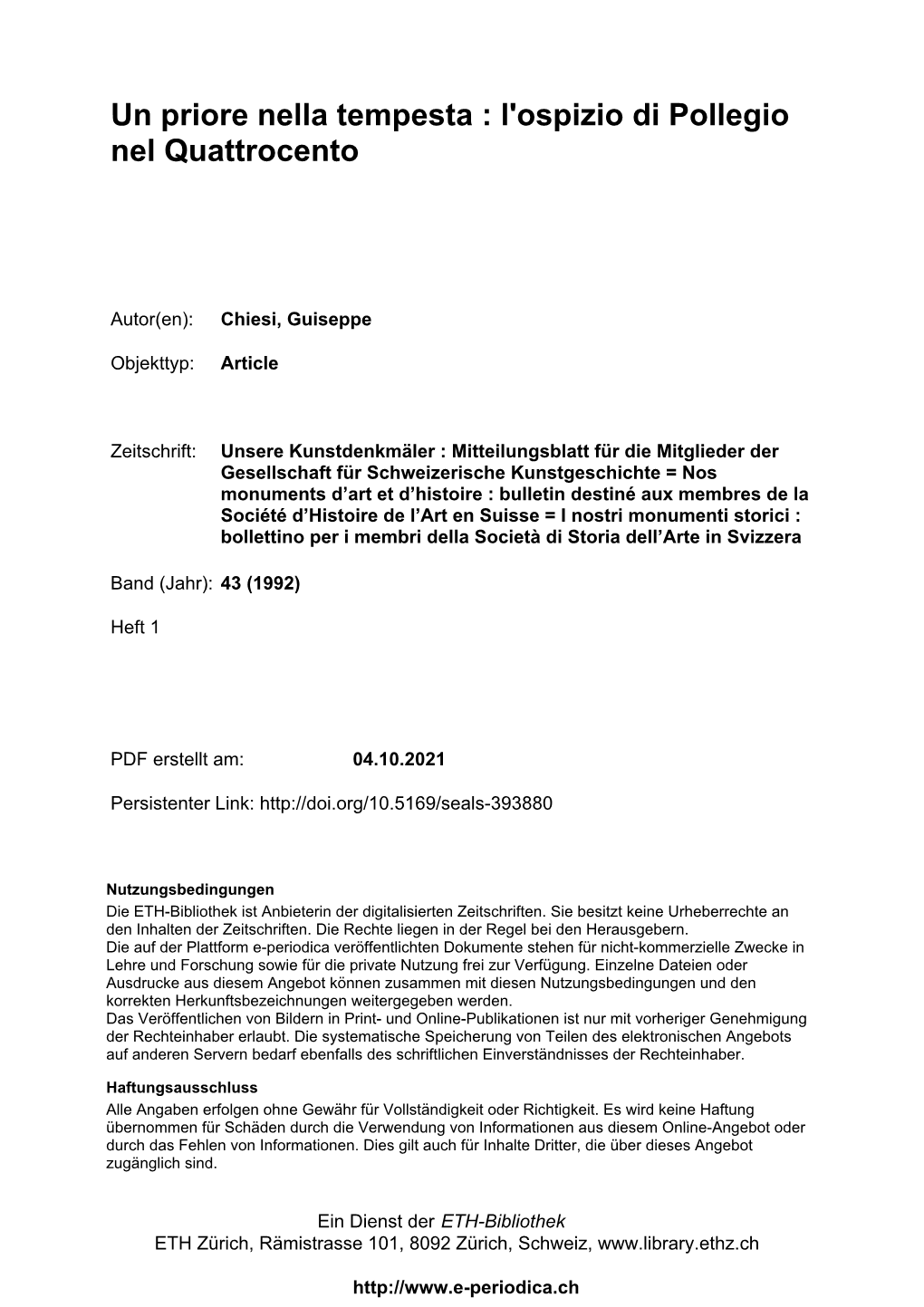
Load more
Recommended publications
-

Da Acquarossa Al Fronte Più Di Cento Anni Fa Covid-19, Intervista Al Medico Giuseppe Allegranza Emigrazione Bleniese E Ticinese
Mensile vallerano Maggio 2020 - Anno LI - N. 5 GAB - 6715 DONGIO - Fr. 5.– Una bella storia iniziata Da Acquarossa al fronte più di cento anni fa Covid-19, intervista al medico Giuseppe Allegranza Emigrazione bleniese e ticinese quiete degli ospedali di Acquarossa e Faido – dei quali è primario – per dare una mano nell’emergenza. “Quando mi hanno chiamato, sono stato contento. Già nei giorni pre- cedenti, vedendo l’evoluzione dei casi, quasi mi dispiaceva non poter essere d’aiuto. E quando poi sono arrivato a Locarno mi ha stupito come fossero riusciti a riorganizzare tutto in modo così rapido”. Molte incognite Poi, però, “è chiaro che questo virus ha qualcosa che spaventa, anzitutto i pazienti. In particolare il fatto che il suo decorso sia difficile da prevedere. E poi, come stiamo capendo col pas- sare del tempo, la polmonite è solo Verso il traguardo, il dr. Allegranza sulla Cima dell’Uomo foto Teto Arcioni uno dei suoi effetti: ci sono persone che sviluppano problemi al cuore, ai di Lorenzo Erroi e Red scorrere del tempo, l’intervista realizza- reni, embolie e trombosi. Mentre al- di Nivardo Maestrani ta dal collega Lorenzo Erroi al medico tri contagiati quasi non se ne accorgo- primario del nostro ospedale di valle, no”. Poi, dietro ai tubi e ai malanni, ai Come già lo scorso mese di aprile, anche Giuseppe Allegranza. numeri e alle complicazioni, ci sono Tra i ricordi della famiglia materna in questo mese stiamo vivendo all’inse- Redazione i singoli individui. “Una cosa che ho trovato la testimonianza del ma- gna dell’incertezza, sia personale sia per spaventa sempre è quando manca trimonio della zia Dora Fontana, ce- quanto riguarda la salute pubblica e il Chissà cosa dev’essere, fare il medi- il respiro. -

17A MAESTRIA PAC Faido Torre
2019 17 a MAESTRIA PAC Leventinese – Bleniese Faido Torre 8 linee elettroniche 8 linee elettroniche 6 – 8.12.2019 Fabbrica di sistemi Fabbrica di rubinetteria d’espansione, sicurezza e sistemi sanitari / e taratura riscaldamento e gas Fabbrica di circolatori e pompe Fabbrica di pompe fecali/drenaggio e sollevamento d’acqua Bärtschi SA Via Baragge 1 c - 6512 Giubiasco Tel. 091 857 73 27 - Fax 091 857 63 78 Fabbrica di corpi riscaldanti e www.impiantistica.ch Fabbrica di bollitori, cavo riscaldante, impianti di ventilazione e-mail: [email protected] caldaie, serbatoi per nafta, controllata impianti solari e termopompe Fabbrica di scambiatori di calore Fabbrica di diffusori per l’immissione a piastre, saldobrasati e a e l’aspirazione dell’aria, clappe fascio tubiero tagliafuoco e regolatori di portata DISPOSIZIONI GENERALI Organizzazione: Tiratori Aria Compressa Blenio (TACB) – Torre Carabinieri Faidesi, Sezione AC – Faido Poligoni: Torre vedi piantina 8 linee elettroniche Faido vedi piantina 8 linee elettroniche Date e Orari: 29.11.19 aperto solo se richiesto 30.11.19 dalle ore 14.00 – 19.00 1.12.19 6.12.19 dalle 20.00 alle 22.00 7.12.19 dalle 14.00 alle 19.00 8.12.19 dalle 14.00 alle 18.00 Un invito ai tiratori ticinesi e del Moesano, ma anche ad amici provenienti da fuori cantone, a voler sfruttare la possibilità di fissare un appuntamento, per telefono ai numeri sotto indicati. L’appuntamento nei giorni 29–30–01 è possibile solo negli orari indicati. Appuntamenti: Contattare i numeri telefonici sotto indicati. Iscrizioni: Mediante formulari ufficiali, entro il 19.11.2019 Maestria – TORRE: Barbara Solari Via Ponte vecchio 3 6742 Pollegio 076 399 75 16 [email protected] Maestria – FAIDO: Alidi Davide Via Mairengo 29 6763 Mairengo 079 543 78 75 [email protected] Formulari e www.tacb.ch piano di tiro: www.carabinierifaidesi.ch Regole di tiro: Fanno stato il regolamento ISSF e le regole per il tiro sportivo (RTSp) della FST. -

Verbale Assemblea Sonogno 2016 Il Verbale Viene Approvato All’Unanimità
VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ALPA, LUDIANO, 10 GIUGNO 2017 Convocazione e puBBlicazione L’Assemblea è stata regolarmente convocata con circolare inviata a tutti i Patriziati e pubblicata sulla Rivista Patriziale 1/2017. Luogo e data L’assemblea ha luogo il 10 giugno 2017, presso l’infrastruttura delle manifestazioni di Ludiano organizzata dai Patriziati di Ludiano, Malvaglia e Semione. Presenti in qualità di ospiti e assenti scusati Norman Gobbi, Consigliere di Stato, Thomas De Courten, cons. Nazionale e membro Fed. Svizzera patriziati, Elio Genazzi, capo Enti locali, Fausto Fornera, ispettore patriziati, Walter Gianora, Gran consigliere TI, Bianchetti Luca, sindaco di Serravalle, Ferrari Guido, presidente Patriziato di Ludiano. Sono scusati: Filippo Gianoni, Daniele Bindella. Patriziati presenti Airolo, Boggesi Alpe Prato, Anzonico, Generale di Aquila, Torre e Lottigna, Generale di Aranno, Cimo e Iseo, Arbedo-Castione, Arosio, Arzo, Ascona, Aurigeno, Avegno, Bedretto, Bellinzona, Biasca, Bidogno, Bignasco, Generale di Bioggio, Bosco Luganese e Muzzano, Bironico, Bodio, Bogno, Borgnone, Bosco Gurin, Brè s/Lugano, Brontallo, Brusino Arsizio, Buttino, Cabbio, Cadro, Cagiallo, Calonico, Camignolo, Camorino, Campestro, Carasso, Castagnola, Castel San Pietro, Castro, Cavagnago, Certara, Cevio-Linescio, Chiasso, Chiggiogna, Chironico, Cimadera, Claro, Coglio, Colla, Contone, Corippo, Corzoneso, Cresciano, Cugnasco, Dalpe, Daro, Dongio, Faido, Fichengo, Frasco, Fusio, Gerra Verzasca, Giornico, Gnosca, Gordevio, Gordola, Gorduno, Gribbio, -

Scheda Media Leventina
1 Scheda Media Leventina Piano cantonale delle aggregazioni 1 2 Spazio Comuni funzionale 1 Faido montagna 2 Sobrio retroterra Schede correlate Scheda 1 Scheda 1 Alta Leventina Scheda 3 Bassa Leventina Scheda 2 Scheda 3 Demografia Territorio Occupazione Popola- Variazione Sup. (ettari) Densità Posti di Variazione zione 2010 dal 2000 (ab/km2) lavoro dal 2001 TI = +9% TI = 83 2008 TI = +11% 3'476 +5% 13’252 26 1’116 -4% 2 Scheda Media Leventina Dati socio-economici e territoriali Demografia Territorio Occupazione 2 Popolazione Variazione dal Sup. (ettari) Densità (ab/km ) Posti di lavoro Variazione dal 2010 2000 (TI +9%) (TI 83) 2008 2001 (TI +11%) Faido 3’395 5% 12'613 27 1’107 -3% Sobrio 81 3% 639 13 9 -67% Media Leventina 3’476 5% 13'252 26 1’116 -4% Dati finanziari CL beneficiario 2011 CL neutro 2011 CL pagante 2011 Indice di forza finanziaria 2013-14 (TI=100) politico Moltiplicatore 2012 (ti=76) Risorse 2009 procapite (TI=3'630) Debito pubblico pro- capite 2010 (TI=3'526) IFF MP RF DP CL *Anzonico 2'341 12’271 x *Calpiogna 4'153 26’104 x *Campello 4'813 25’139 x *Cavagnago 2'152 14’617 x *Chironico 2'405 4'695 x Faido 67 95 2'343 ** 2'263** x *Mairengo 3'026 177 x *Osco 2'966 3’060 x Sobrio 63 100 2'309 22'087 x Media Leventina 2'542 3’972 +2.0 mio fr. * comuni aggregati dal 01.04.2012 ** dati riferiti al comune di Faido ante aggregazione 2 Aggregazioni Faido 1: aggregazione di Calonico, Chiggiogna, Faido e Rossura (entrata in vigore il 29.01.2006) Faido 2: aggregazione di Anzonico, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chironico, Faido, Mairengo e Osco (entrata in vigore il 01.04.2012) Diagnosi e prospettive: sintesi Tratti marcanti Risorse fisiche: patrimonio naturalistico di rilievo (Campolungo, Campo Tencia, Piumogna) e importanti riserve naturali; risorse idriche importanti; ampia reti di sentieri. -

Groups & Incentives in Ticino
Groups & Incentives in Ticino. meetings.ticino.ch/incentives Come for business, stay for lifestyle. Collina d’Oro, Lake Lugano Region Collina d’Oro, | 1 Ticino Turismo Index: Via C.Ghiringhelli 7 CH - 6501 Bellinzona Introduction. 4 Tel. +41 (0)91 825 70 56 Excursions & Nature. 6 [email protected] Culinary & Delights. 9 www.meetings.ticino.ch Sport & Fun. 11 Culture & Events. 15 Technical visits. 17 Contact: Webcode. Monica Reggiani The webcode is the number to be found in the blue box of each activity. XY Product Manager Meetings For further information, visit www.meetings.ticino.ch and click the search [email protected] botton in the upper right corner of the page, then type the webcode in the search box. Please contact us if you need more information, it would be a pleasure for us to help you organizing your great Ticino-experience! Ticino Turismo, in cooperation with various partners operating throughout the area, is able to offer professional and free assistance for the planning of meetings, incentives, conventions and events. See: www.meetings.ticino.ch/contact 2 | Did you know that in Ticino… • you can soak up 2,302 hours of sun every year? • you can find AlpTransit, the world’s largest construction site? It’s one of Switzerland’s sunniest regions! Here you can receive all the information on the new Gotthard tunnel at the Pollegio Information Centre: this is the longest tunnel in the world • clouds are not welcome? and is 57 km long! The maximum cloud formation in Lugano is 43%, compared to 65% in Milan! • you can suffer from -

Nei Dialetti Del Canton Ticino E Territorii Limitrofi : (Con 3 Carte)
Dei continuatori di *lcrta (* -u) nei dialetti del Canton Ticino e territorii limitrofi : (con 3 carte) Autor(en): Merlo, C. Objekttyp: Article Zeitschrift: Bollettino dell'opera del Vocabolario della Svizzera italiana Band (Jahr): 5 (1929) Heft 5 PDF erstellt am: 01.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-178761 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch 4 BOLLETT. OPERA DEL VOC. DELLA SVIZZERA ITALIANA (N. 5) *des-, donde *ds- e quindi *ts-; il *ts si è infine invertito in st-. L' il è sorto nelle rizatone per la vicinanza del ú '. t C. Salvioni. -

Qualità Del Paesaggio Agricolo Della Valle Leventina
Cantone Ticino Sezione dell’agricoltura Qualità del paesaggio agricolo della valle Leventina Rapporto di progetto Faido, 31 marzo 2016 Progetto qualità paesaggio valle Leventina Società Agricola di Leventina Impressum Contatto Cantone: ing. Daniela Linder Basso, Ufficio della consulenza agricola, Viale S. Franscini 17, 6500 Bellinzona Tel. 091/814 35 47, e-mail [email protected] Contatto ente promotore: Società agricola di Leventina, c/o Omar Pedrini, 6763 Osco Tel. 079/436 18 25, e-mail [email protected] Autori/redazione: Lucchini Mariotta Associati SA, 6715 Dongio, Fabrizio Conceprio e Nilde Dazzi [email protected] Progetto qualità paesaggio valle Leventina Società Agricola di Leventina Indice 1 Dati generali sul progetto .......................................................................................................................... 1 1.1 Iniziativa ............................................................................................................................................... 1 1.2 Organizzazione del progetto ................................................................................................................ 1 1.3 Comprensorio del progetto .................................................................................................................. 2 2 Andamento del progetto e procedura partecipativa ............................................................................... 8 3 Analisi del paesaggio.............................................................................................................................. -

Tabella Di Marcia 2 GP Ticino Cat. Elite, U23, Amateur Lodrino 2021
2° GRAN PREMIO TICINO BANCA STATO GARA NAZIONALE SU STRADA 2021 domenica, 11.07.2021 Tabella di marcia categoria Elite, U23, Amateur e Master Lodrino-Osogna-Claro-Preonzo-Lodrino-Biasca-Osogna-2 giri piccoli Riviera - Pollegio-Giornico-Chiggiogna-Nivo-Giornico-Biasca-Osogna-Lodrino, 2 giri grandi con Leventina Distanza Orario Orario Altezza Distanza Luogo percorso passaggio 40 passaggio 45 m/sM intermedia progressiva km/h km/h 262 Lodrino, aeroporto partenza 0.00 0.00 12:45 12:45 274 Osogna-Cresciano, stazione FFS 2.00 2.00 12:48 12:48 260 Cresciano 2.60 4.60 12:52 12:51 270 Claro rotonda, deviazione a destra 3.30 7.90 12:57 12:56 255 Bivio Preonzo-Claro 0.90 8.80 12:58 12:57 250 Preonzo 1.00 9.80 12:59 12:58 262 Lodrino rotonda 4.30 14.10 13:06 13:04 295 Iragna 3.70 17.80 13:11 13:09 295 Iragna, bivio per Biasca via Iragna 3.00 20.80 13:15 13:13 295 Biasca, strada Industriale 301 Biasca, via Industrie 1.70 22.50 13:18 13:15 1° GIRO PICCOLO RIVIERA 301 Biasca, via Traversa 22.50 301 Biasca, strada cantonale via Chiasso 1.00 23.50 13:20 13:17 274 Osogna, stazione FFS 4.60 28.10 13:26 13:23 260 Cresciano 2.60 30.70 13:30 13:26 270 Claro rotonda, deviazione a destra 3.30 34.00 13:35 13:30 255 Bivio Preonzo-Claro 0.90 34.90 13:36 13:31 250 Preonzo 1.00 35.90 13:38 13:32 262 Lodrino rotonda 4.30 40.20 13:44 13:38 295 Iragna 3.70 43.90 13:50 13:43 295 Iragna, bivio per Biasca via Iragna 3.00 46.90 13:54 13:48 2° GIRO PICCOLO RIVIERA 296 Pollegio rotonda Pasquerio 1.20 48.10 13:56 13:49 298 Pollegio 1.20 49.30 13:58 13:51 322 Bodio 2.80 52.10 -

Guided Visits to the Bodio-Pollegio Work Site the Visitor Centre Offers
Guided visits to the Bodio-Pollegio work site The Visitor Centre offers guided visits (reservation necessary) of approximately two hours for groups of 10 to 50 perso ns (visits for larger groups can be arranged on request). The accompanied visits are offered in the three national languages (Italian, French and German), in English and Spanish and may be combined with tourist packages in the Bellinzona and upper Tessin region . After an introduction to the project presented by the professional work site guides, the visitors are accompanied to the work area where they can closely observe the various aspects concerned in the construction and progress of the tunnel. Price for guided visit, adult: Fr. 12. -- Price for guided visit, children up to 16 years of age: Fr. 6.-- Guided visits to the Faido work site Infocentro AlpTransit offers guided visits of approximately three hours (reservation necessary) to the Faido multifunction station where visitors are taken to the inside of the tunnel. Visitors must be minimum 14 years of age and maximum 75 in good health (people with pacemakers and pregnant women are not permitted entry). The consumption of alcohol before the visit is forbidden. The accompanied visits are offered in the three national languages (Ita lian, French and German), in English and Spanish. After an introduction to the project presented by the professional work site guides at the Pollegio Visitor Centre, the visitors will receive equipment for the entry into the tunnel and will be accompanied to Faido where they can closely observe the excavations. Price for guided visit, per person : Fr. -

Cities. Myswitzerland.Com Art, Architecture & Design in 26 Swiss Cities
Cities. MySwitzerland.com Art, architecture & design in 26 Swiss cities. Prolong the UEFA European Foot- ball ChampionshipTM 2008 with a holiday in Switzerland. MySwitzerland.com/euro08 Schaffhausen Basel Winterthur Baden Zürich St. Gallen-Lake Constance Aarau Solothurn Zug Biel/Bienne Vaduz La Chaux-de-Fonds Lucerne Neuchâtel Bern Chur Riggisberg Fribourg Thun Romont Lausanne Montreux-Vevey Brig Pollegio Sierre Sion Bellinzona Geneva Locarno Martigny Lugano Contents. Strategic Partners Art, architecture & design 6 La Chaux-de-Fonds 46 Style and the city 8 Lausanne 50 Culture à la carte 10 AlpTransit Infocentre 54 Hunting grounds 12 Locarno 56 Natural style 14 Lucerne 58 Switzerland Tourism P.O. Box Public transport 16 Lugano 62 CH-8027 Zürich Baden 22 Martigny 64 608, Fifth Avenue, Suite 202, Aargauer Kunsthaus, Aarau 23 Montreux-Vevey 66 New York, NY 10020 USA Basel 24 Neuchâtel 68 Switzerland Travel Centre Ltd Bellinzona 28 Schaffhausen 70 1st floor, 30 Bedford Street Bern 30 Sion-Sierre 72 London WC2E 9ED, UK Biel/Bienne 34 Solothurn 74 Abegg Foundation, Riggisberg 35 St. Gallen 76 It is our pleasure to help plan your holiday: Brig 36 Thun 80 UK 00800 100 200 30 (freephone) Chur 38 Vaduz 82 [email protected] USA 1 877 794 8037 Vitromusée, Romont 39 Winterthur 84 [email protected] Fribourg 40 Zug 88 Canada 1 800 794 7795 [email protected] Geneva 42 Zürich 90 Contents | 3 Welcome. Welcome to Switzerland, where holidaymakers and conference guests can not only enjoy natural beauty, but find themselves charmed by city breaks too. Much here has barely changed for genera- tions – the historic houses, the romantic alleyways, the way people simply love life. -

Iniziativa Parlamentare
INIZIATIVA PARLAMENTARE presentata nella forma generica da Sergio Arigoni e cofirmatari per l'introduzione di una tariffa differenziata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del 19 ottobre 2009 Premessa I principi della politica ambientale, sia federale, sia cantonale, stabiliscono che i rifiuti siano trattati come una risorsa e che vada fatto tutto il possibile affinché questi siano separati, riciclati e valorizzati. Le principali disposizioni concernenti la ripartizione dei compiti riguardanti lo smaltimento dei rifiuti e il loro finanziamento sono contenute nella legge sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983. Lo smaltimento dei rifiuti compete ai Cantoni (art 31b cpv. LPAmb), che devono provvedere a una gestione economica degli impianti di trattamento dei rifiuti. Facendo uso della possibilità di cui all'art. 31 cpv. 2 LPAmb, con gli artt. 68 e segg. LALIA il compito di eliminare i rifiuti è stato delegato dal Cantone ai Comuni. L'art. 2 LPAmb sancisce il principio cosiddetto di causalità, spesso riassunto con il detto "chi inquina paga", che stabilisce che le spese delle misure prese secondo questa legge devono essere sostenute da chi ne è la causa. L'art. 32a LPAmb, in vigore dal 1° novembre 1997, precisa ulteriormente questa norma con riferimento ai costi di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) e stabilisce che gli impianti e i servizi necessari allo smaltimento dei rifiuti urbani devono essere finanziati in conformità del principio di causalità, tramite emolumenti, o altre tasse, proporzionali alla quantità dei rifiuti smaltiti (es. la tassa sul sacco). Non è quindi legale finanziare i costi di smaltimento tramite le normali entrate fiscali o una tassa fissa annua. -

21-24 Agosto 2019
APPUNTAMENTI 9 1 MERCOLEDÌ 21 AGOSTO 0 Ore 19.00 2 SA CH – 6760 Faido CH-6760 Faido Tel. +41 (0)91 866 12 14 Via Cantonale 15 Aperitivo offerto in compagnia CH – 6535 Roveredo Al Sabiòn 195D della Band “CHANSON-BOUTIQUE” buffet freddi catering aperitivi salumeria nostrana CH – 6900 Massagno formaggi della valle assortimento vini Via Miravalle 11 VENERDÌ 23 AGOSTO Ore 21.30 Tributo a Vasco Rossi con la Band “ZEROALIBI” SABATO 24 AGOSTO Denner satellite Via Saresc 4, 6760 Faido Lino Scarpati Business Analyst Ore 21.00 SA Azienda Forestale Ambientale Tel. +41 91 866 29 66 Telefax +41 91 866 04 02 agosto 21-24 Mobile +41 79 731 97 23 CH-6703 OSOGNA [email protected] PREMIAZIONE Tel. 091 863 25 01 Fax 091 863 34 80 Torneo Attivi Consulenza dalla A alla Z Ore 21.30 Agenzia generale Dewis Piccinali Piazza del Sole, 6500 Bellinzona Michele Dazzi, Capo Vendita Un sostenitore Musica Live con Karaoke in compagnia di ANDREA Mobile 079 337 32 47 6746 Nivo SABATO 24 AGOSTO – TORNEO 6 MIGLIORI UNDER 12 DEL TICINO BULLONERIA 10.00 ATTREZZERIA MACCHINE AGRICOLE Faido di Torneo FORESTALI GIARDINAGGIO OFFICINA SERVIZIO RIPARAZIONI ACB - Locarno Bellinzonese - Mendrisiotto 10.45 Alice Piemontesi Dipl. Lui e Lei devi grassi caratti Locarno - Luganese Mendrisiotto - Lugano pharmacieplus farm. dipl. FPH Piazza S. Franscini 7 grassi sa 6760 Faido via pian della croce 9 6760 faido P. Stefano Franscini 8 t. 091 866 12 06 Coiffure Lui e Lei Tel. 091 866 32 85 f. 091 866 02 17 Tel. +41 (0)91 866 15 55 www.farmaciagrassi.ch [email protected] www.hotelfaido.ch 11.30 ACB - Luganese Bellinzonese - Lugano RM Elettroimpianti Sagl Via San Gottardo 146 6776 Piotta Tel.