Bartolomeo Figari Pubblicato Su “Annuario 1957” Della Sezione Ligure
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Presentazione
PRESENTAZIONE L'idea di trasmettere agli Amici alcune notizie sul “nostro” MONTE CARMO mi balenava in mente da anni, ma ho sempre rimandato a iniziare tale opera. Solamente in occasione del 50° anniversario della posa dell'attuale Croce mi sono impegnato a raccogliere alcuni appunti, ma soprattutto con l'aiuto e con la fattiva collaborazione di mia moglie Piera, mi sono accinto a mettere "in bella" quanto ho raccolto in questi ultimi cinquanta anni. Con entusiasmo parlo del suo aspetto naturalistico, poiché già da bambino ho imparato ad ammirarlo nel suo manto verdeggiante, tappezzato di fiori endemici e frutti del sottobosco, o nella sua struttura scheletrica del pieno inverno, in cui le rocce diventano, nella loro essenzialità, più prepotenti e più minacciose, elevandosi dal manto innevato che si stende ai loro piedi. A rendere più affascinante la sua estensione, nelle gelide notti di luna piena si alzano verso il cielo, quasi timorosi, scuri rami rattrappiti, che offrono alla Signora della Notte, luccicanti e preziosi ornamenti, che la Fata Galaverna ha ricamato su di loro. Attirati da tanta bellezza, gli uomini ne diventano amici, ne fanno terra per lavorare, dimora stagionale, difesa dai nemici, ma anche campo di battaglia. Da mezzo secolo, sul Carmo, hanno issato una Croce, non in segno di lutto, ma di fede e pace, come meta di piacevoli passeggiate alla scoperta della sua vera serenità. E’ della storia delle Croci che vi parlo ora, perché è la storia di una parte della mia vita e di quella di tanti altri loanesi, che nello scorrere degli anni hanno contribuito, con il loro entusiasmo, ad avvolgere Monte Carmo con un manto di serenità, di gioia, di vero amore per la natura. -

Anno 2013 Nr.3
NOTIZIARIO DEL GRUPPO “Camminare nel bello ESCURSIONISTICO della natura e dell’arte” I MONTAGNIN periodico di informazione SOMMARIO quadrimestrale REDAZIONE 85 e 60 anni della nostra vita Pag. 1 Via S. Benedetto 11/3 16126 Genova Quando la TV non c'era " 3 Tel 010 252250 Lo scarpone ferito " 4 Fax 010 8597527 A Natûa " 6 e.mail: [email protected] Ricordo di Ruggero " 7 Sito internet: www.montagnin.it Addio Carnacina, orso buono " 8 Monte Carmo di Loano " 9 DIRETTORE Aiuto, mi sono persa (Racconto del mese) " 10 RESPONSABILE Riepilogo attività Nov '13 - Apr. '14 " 12 Umberto Torretta Trekking nelle Dolomiti di Sesto " 15 SEGRETARIA DI Spigolature sul soggiorno a San Cassiano 22 REDAZIONE Quest'estate una domenica " 23 Francesca Milazzo Cronaca Montagnin: terza pagina di copertina REDAZIONE Hanno collaborato a questo numero: Nadia Bottazzi - Elisa Benvenuto Alessandra Bruzzi - Silvana Maestroni Angela Gaglione - Luigi Capelli Paola Poddioli Gianfranco Robba DELEGATO DEL C.D. Gianfranco Robba STAMPA Status s.r.l. Via Paleocapa 67r Genova Autorizzazione n° 8/1991 del Tribunale di Genova. Diffusione gratuita ai Soci e ai simpatizzanti, non commercializzata. Pubblicità inferiore al 70% ANNO 2013 N° 3 85 e 60 anni della nostra vita e 25 della mia. Un’anno importante questo 2013 per la nostra Società: i Montagnin compiono 85 anni e il Notiziario, che ne riporta gli avvenimenti e i ricordi, raggiunge i 60. Pare solo ieri quando festeggiavamo gli allora ottant’anni, con amici e parenti nel teatro della chiesa in via Bologna, con l’intervento del Coro Monte Cauriol, le associazioni genovesi della FIE, con tante torte, tanta allegria e qualche amico in più che in questi cinque anni ci ha purtroppo lasciato. -

Scopri Le Alpi Liguri: Estate 2004
SCOPRI LE ALPI LIGURI Escursioni Estate 2017 Vi invitiamo a partecipare al ricco programma di escursioni nello splendido entroterra del Ponente Ligure, ogni gita in una valle diversa, per scoprirne le bellezze naturali, storico-artistiche in una piacevole atmosfera di gruppo. Maggio Domenica 7 Saint Agnes Pic Baudon (M) Difficoltà E, Tempi di Marcia 6 ore, dislivello 900 metri Domenica 14 Monte Grammondo da Castellar (R) Difficoltà E, Tempi di Marcia 7 ore, dislivello 1000 metri Domenica 21 Monte Ceppo da Ciabaudo (M) Difficoltà E, Tempi di Marcia 6 ore, dislivello 900 metri Domenica 28 Monte Carmo di Loano (M) Difficoltà E, Tempi di Marcia 6 ore, dislivello 600 metri Giugno Domenica 4 Monte Abellio da Airole (R) Difficoltà E, Tempi di Marcia 7 ore, dislivello 900 metri Domenica 11 Monte Ceppo da Bajardo (R) Difficoltà E, Tempi di Marcia 7 ore, dislivello 900 metri Domenica 18 Monte Toraggio da Gouta (M) Difficoltà E, Tempi di Marcia 7 ore, dislivello 900 metri Domenica 25 Monte Saccarello da Verdeggia per Rododendri (R) Difficoltà E, Tempi di Marcia 8 ore, dislivello 1100 metri Luglio Domenica 2 Monte Monega dal Passo Teglia (M) Difficoltà E, Tempi di Marcia 5 ore, dislivello 600 metri Domenica 9 Monte Forquin da Gouta (R) Difficoltà E, Tempi di Marcia 6 ore, dislivello 500 metri Domenica 16 Balconi di Marta da Colle Melosa (M) Difficoltà E, Tempi di Marcia 5 ore, dislivello 600 metri (500 senza scendere nel forte) Domenica 23 Cima delle Saline da Carnino (R) Difficoltà E, Tempi di Marcia 7 ore, dislivello 1200 metri Domenica 30 Rocca -

Il Finalese (Liguria Occidentale) E Le Dinamiche Di Scambio Preistoriche Fra Mediterraneo Ed Europa Continentale
Il Finalese (Liguria Occidentale) e le dinamiche di scambio Preistoriche fra Mediterraneo ed Europa Continentale Autori: Alfredo Pirondini*, Gian Paolo Bocca*, Filippo Pirondini*, Cecilia Pirondini* e Cesarina Villa* * Il Finalese: Studi e Ricerche http://ilfinalese.blogspot.it Riassunto Gli Autori, in seguito alla disamina di studi internazionali ed alle recenti osservazioni personali sull'argomento in esame, analizzano l'importanza della zona di Finale Ligure (Provincia di Savona, Liguria Occidentale, Italia), quale crocevia di culture e commerci fra aree distanti del Mediterraneo, dell'Italia e dell'Europa Transalpina durante la Preistoria. Introduzione Il Finalese rappresenta un'area unica dal punto di vista geologico, paleontologico e paletnologico. Si estende, in direzione dell'entroterra, dalla linea di costa fino al tracciato della attuale Autostrada A 10 e, lungo il litorale, da Capo Noli a Capo Caprazzoppa. Il territorio è geologicamente caratterizzato da una formazione rocciosa miocenica di origine bioclastica, nota come Pietra del Finale, formatasi nel Miocenico (20-10 milioni di anni fa) in quella che era una laguna di acque calde e tranquille, tra Capo Noli ed il Monte Carmo di Loano. Nell'arco di alcuni milioni di anni sedimenti fluviali, sabbie, ghiaie, scheletri calcarei e molluschi si accumularono nella parte centro orientale di questo bacino, formando il calcare bioclastico della Pietra del Finale (Foto 1). Foto 1 Con il ritiro del mare, rimase un ampio penepiano. La Pietra del Finale è stata poi soggetta ad intensi fenomeni carsici, sia superficiali (epigei), che sotterranei (ipogei), con la formazione di valli fossili, depositi di terre rosse, grotte e complessi ipogei ricchi di acque. -

Pictures from Valle Scrivia, Genoa, Italy
Siberix Report Writer Evaluation Version. Visit www.siberix.com for more information. Last Updated on 27/09/2021 13.59.33. 249 photo in this document. www.FotoValleScrivia.It Il porto e circonvallazione a monte Pietro Marcheselli - Olympus Camedia 3000 <2001 - Foto varie - Genova - Paesi Monte Galero e il Paese di Alto (Cuneo) Pietro Marcheselli - Olympus Camedia 3000 <2001 - Foto varie - Altro - Panorami Paesaggio ligure in Valle Arroscia (Imperia) Pietro Marcheselli - Olympus Camedia 3000 <2001 - Foto varie - Altro - Panorami Valle Arroscia (Imperia) Pietro Marcheselli - Olympus Camedia 3000 <2001 - Foto varie - Altro - Panorami Monte Castel Ermo Pietro Marcheselli - Olympus Camedia 3000 <2001 - Foto varie - Altro - Panorami Neve: pendici Monte. Bano (Montoggio) Pietro Marcheselli - Scanner <2001 - Inverno - Montoggio - Panorami Monte Castello e 'La Lumaca' dalla vetta del M. Reo Passo, con neve Pietro Marcheselli - Scanner <2001 - Inverno - Crocefieschi&Vobbia - Panorami www.FotoValleScrivia.It Page 1 of 36 Siberix Report Writer Evaluation Version. Visit www.siberix.com for more information. www.FotoValleScrivia.It Castello Fieschi con neve, Savignone Pietro Marcheselli - Scanner <2001 - Inverno - Savignone - Paesi Panorama da Pointe de la Masse (Val Thorens - Svizzera) Pietro Marcheselli - Scanner <2001 - Foto varie - Altro - Panorami Monte Bianco visto da Pointe de la Masse Pietro Marcheselli - Scanner <2001 - Foto varie - Altro - Panorami Genova: Quartieri di circonvallazione a monte sotto la neve (2001) Pietro Marcheselli - Olympus -

Itinerari Di Sport
Cover_sport_150x210_IT.fh 28-09-2011 11:57 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K Finale Ligure - Savona Noli - Savona Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “in Liguria” [email protected] www.turismoinliguria.it Emozioni sul mare Scenari d’arte Tracce di storia Profumi e sapori Itinerari di sport Giardini di Riviera Colori compositi Una vacanza andante con brio: la Liguria è bellezza in movimento. Info Editoriali Progetto Editoriale e Copyright su tutti i diritti riservato a Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “in Liguria”. Immagini: archivio Agenzia “in Liguria” - salvo pag. 6 Parco del Beigua Copyright - pag.7 Parco dell’Antola Copyright. Progetto grafico a cura di: Adam Integrated Communications - Torino - Stampa anno 2011 - Avviso sulla responsabilità: nonostante l’accurato controllo l’Agenzia “in Liguria” non assume alcuna responsabilità per i contenuti e le informazioni presenti. www.turismoinliguria.it Free Climbing Liguria un passo dopo l’altro: il cammino della scoperta. Sentieri e strade antiche, vie in selciato e itinerari tra le colline: dalla montagna al mare la Liguria è un gomitolo di percorsi da affrontare con scarpe comode, borraccia e pic nic nello zaino. Allora, appese al chiodo pinne e occhiali, è tempo di dedicarsi a tutte le attività all’area aperta che la regione sa offrire in ogni stagione. Il sole e la salsedine sono i compagni discreti d’intense immersioni a piedi in una natura intatta, mentre un caleidoscopio di spiagge, intrecci tortuosi, salite e dolci pendii sfila ai fianchi dei trekker in cammino da levante a ponente. Porto Venere www.turismoinliguria.it Trekking - Valle Arroscia 3 Promontorio Montemarcello Manarola Via dell’Amore Promontorio Portofino Antola Vetta Sentiero Azzurro, l’itinerario principe delle Cinque Terre. -

Ule Provv 04
CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE U.L.E. GENOVA Vico Carmagnola 7/5 - 16123 Genova Tel. e fax 010 565564 E-mail: [email protected] Sito: www.caiulegenova.it Apertura sede: martedì e venerdì ore 18.00 – 19.30 DELEGAZIONE DI MOLASSANA Via Bernadini - Giardini Maurizio Orengo Apertura: giovedì ore 17.30 – 19.00 SOTTOSEZIONE U.L.E. SESTRI P. Via Galliano 16/4 – 16153 Genova tel. 010 6531232 E-mail: [email protected] Sito: www.caisestri.com Apertura sede: martedì e venerdì ore 21.00 – 22.00 GENOVA Calendario attività sociali da LUGLIO a DICEMBRE 2018 I soci sono invitati a contattare per tempo la segreteria dell’ULE al fine di ottenere i recapiti dei direttori di gita interessati Calendario attività sociali da LUGLIO a DICEMBRE 2018 LUGLIO DATA/ DETTAGLI TECNICI DIRETTORI ATTIVITA’ S 30/6 Escursionismo Vie Ferrate – Gruppo Ferrate Sezionale 1° giorno D 1/7 VIA FERRATA DI CHIARONTO diff. : EEA/D Alpi Cozie – Valle Varaita disl. : 30 m + 250 m 2° giorno diff. : EEA/D F. Papini disl. : 260 m G. Gobbo mezzi di trasporto: F. Vernazza auto proprie S 30/6 Escursionismo Pedestre – Gruppo Escursionisti Sestri 1° giorno D 1/7 Ponente arrivo a Clavière, MONTE CHABERTON (3131 m) escursione nei dintorni Alpi Cozie – Val di Susa – Monginevro da definire, pernottamento 2° giorno Dal Village du Soleil presso Monginevro, in Francia, il sentiero risale salita al monte il vallone del Rio Secco e dopo agevole camminata raggiunge quello Chaberton che era il Ricovero delle Sette Fontane (2257 m). Da qui si sale diff. : E verso destra fino a raggiungere, dopo una salita impegnativa, il Colle disl. -

Sport Touren
Finale Ligure - Savona Noli - Savona Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “in Liguria” [email protected] www.turismoinliguria.it Erlebnisse am Meer Schauplätze der Kunst www.turismoinliguria.it Auf den Spuren der Geschichte Düfte und Köstlichkeiten Sport Touren Ein Garten Meer Ein Urlaub mit Schwung: Ligurien ist Schönheit in Bewegung. Milano Alessandria A7 A26 ITALIA Monte Antola Emilia Romagna Santo Stefano Monte Beigua D’Aveto Torino A10 A6 Arenzano A12 Albisola Superiore GENUA Piemonte Toscana San Fruttuoso Rapallo SAVONA Monte di Portofino Portofino Bergeggi Punta Manara Moneglia Parma Monte Carmo Giustenice Mare Ligure Riva Trigoso Finale Ligure A15 Toirano Deiva Marina A12 Monte Saccarello Loano Levanto FRANCIA Castelbianco Triora Garlenda Albenga LA SPEZIA Sarzana Monte Pietravecchia Muzzerone Lerici A10 Alassio Portovenere Montemarcello Livorno Castellaro IMPERIA Ospedaletti San Lorenzo al Mare Ventimiglia Montecarlo EUROPA ITALIA Liguria Roma Mare Mediterraneo Verlagsinformationen Verlagsprojekt und alle Urheberrechte sind der Agenzia Regionale per la Promozione Turistica „in Liguria“ vorbehalten. Abbildungen: Archiv der Agenzia „in Liguria“ - außer S. 3-4-5-13 Copyright „Parco delle Cinque Terre“; S. 12 Copyright „Parco del Beigua“. Graphische Gestaltung von: Adam Integrated Communications - Turin - Erscheinungsjahr 2008 - Hinweis zur Gewähr: trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt die Agenzia „in Liguria“ keine Gewähr für die Inhalte und die enthaltenen Informationen. www.turismoinliguria.it Trecking - Golfo Paradiso Ligurien einen Schritt nach dem anderen erleben: der Weg der Erkundung. Wege und antike Straßen, gepflasterte Straßen und Routen zwischen den Hügeln: vom Gebirge bis zum Meer ist Ligurien wie ein Knäuel von Routen, die mit bequemen Schuhen, Feldflasche und Picknick im Rucksack zurückzulegen sind. Also dann, Flossen und Taucherbrille an den Haken gehängt! Es ist Zeit, sich all den Aktivitäten im Freien zu widmen, die die Region zu jeder Jahreszeit bieten kann. -
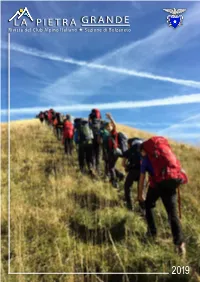
Pietragrande La
LA PIETRA GRANDE Rivista del Club Alpino Italiano « Sezione di Bolzaneto 2019 LA PIETRA GRANDE RIVISTA DEL CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di BOLZANETO Via C. Reta 16r - Tel. e Fax 010.740.61.04 - 16162 Genova Da Bologna a Santiago de Compostela....50 www.caibolzaneto.it - [email protected] di Giorgio Trotter Apertura Sede e tesseramento: giovedì ore 21 Api e Vale sull’Alta Via dei Monti Liguri.....52 di Franco Api e Valentina Vinci Un’esperienza di vita...............................54 LA PIETRA GRANDE Rivista del Club Alpino Italiano « Sezione di Bolzaneto di Stefano Camarda Cos’è Alvi Trail?.........................................56 Sommario di Marzia Gelai Capodanno in solitaria notturna..............57 di Marco Ferrando Trek in Portogallo dalla A alla Z...............60 CAI SEZIONE di BOLZANETO.......................2 di Sabrina Poggi e Michela Repetto Il socio agente del corretto rapporto con la Sulla Cima di Nasta..................................64 montagna.................................................3 di Bruna Carrossino di Nadia Benzi CULTURA.............................................68 Anno XII • Numero 12 2019 ALPINISMO.........................................5 Monte Carmo, storia di una croce di La Montagna si sconta... salendo..............5 vetta......................................................68 di Salvatore Gabbe Gargioni di Pietro Pitter Guglieri In copertina: “Verso il blu” 1...8 e 1…9 ma l’Alpinismo non dà i 25 aprile sull’Antola per ricordare Guido Foto di Valentina Vinci numeri!.......................................................7 -

Allegato a “RETE ESCURSIONISTICA Della LIGURIA ELENCO
SCHEMA N................ NP/2296 REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale DEL PROT. ANNO 2017 Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Parchi e biodiversità - Settore “RETE ESCURSIONISTICA della LIGURIA ELENCO PERCORSI” “Carta inventario percorsi escursionistici della Liguria” ex art. 4, l.r. 24/09 Allegato A (Gestione formalizzata) Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO (Geom. Maurizio Robello) 24/02/2017 (Dott. Roberta Rossi) Pag. 2 SCHEMA N................ NP/2296 REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale DEL PROT. ANNO 2017 Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Parchi e biodiversità - Settore Codice percorso Nome sentiero Ente proponente Soggetto Gestore Documentazione Dichiarazione Attestazi Istanza Lunghezza attestante la attestante i one Uso (in metri) gestione diretta o requisiti di pubblico l'affidamento in legge gestione GGEA10106CE Bivio Cascina Gargassina - Provincia di Ente Parco Beigua Si (indiretta) SI SI prot. n. 17784 2.077 Cascina Veirera Genova del 14.02.2013 GGEA10106PE Sciarborasca - Monte Rama Provincia di Ente Parco Beigua Si (indiretta) SI SI prot. n. 17784 6.850 Genova del 14.02.2013 GGEA10206PD Lerca - Bric Camulà - Monte Provincia di Ente Parco Beigua Si (indiretta) SI SI prot. n. 17784 5.663 Rama Genova del 14.02.2013 GGEA10306PE Arenzano - Monte Argentea Provincia di Ente Parco Beigua Si (indiretta) SI SI prot. n. 17784 10.074 Genova del 14.02.2013 GGEA10406PE Voltri - Passo della Gava - Provincia di Ente Parco Beigua Si (indiretta) SI SI prot. n. 17784 9.132 Monte Reixa Genova del 14.02.2013 GGEA10506PE Badia di Tiglieto - Bric del Provincia di Ente Parco Beigua Si (indiretta) SI SI prot. n. 17784 7.333 Dente Genova del 14.02.2013 GGEA10606PE Tiglieto - Colle Cima di Provincia di Ente Parco Beigua Si (indiretta) SI SI prot. -

Reg. (Ue) 1305/2013 Programma Nazionale Di Sviluppo
REG. (UE) 1305/2013 PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali SOTTOMISURA 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue ALLEGATO 2a NOTE ALL’ ART.5.2 “CRITERI DI AMMISSIBILITÀ” Si riportano di seguito le note richiamate all’art. 5.2, di chiarimento a quanto disposto dai “Criteri di ammissibilità”. A) Criteri di ammissibilità generali applicabili a tutte le operazioni Per il criterio di ammissibilità A3 si specifica quanto segue: Per i progetti sottoposti a VIA ai sensi dell’art. da 20 a 28 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., lo studio di impatto ambientale corredato dal parere di compatibilità ambientale rilasciato dall’autorità competente a valle della procedura, costituiscono la richiesta analisi ambientale, da allegare alla domanda di sostegno. Per i progetti per i quali la normativa nazionale non prevede la procedura di VIA il proponente dovrà comunque effettuare un’analisi ambientale di qualità adeguata e che consideri esplicitamente l’impatto del progetto sugli obiettivi ambientali della Direttiva Quadro Acque, da allegare alla richiesta di finanziamento. Per il criterio di ammissibilità A4 si specifica quanto segue: - Secondo la normativa nazionale (D. Lgs 219/210, art. 4) l’atto finale del processo pianificatorio è l’approvazione del Piano di gestione da parte dei Comitati Istituzionali e Tecnici delle Autorità di Bacino di rilevanza nazionale. -

Storia-Di-Loano.Pdf
Storia di Loano «(Loano) DANTE solo poeta degno di te, o GARIBALDI, saluta con un suo verso la madre tua ROSA RAIMONDI che ebbe il natale in questo paesello sorriso dalla natura e illuminato dalla tua gloria : Benedetta colei che in te s'incinse. Epigrafe di Mario Rapisardi» Di origini preromane (sono recenti i ritrovamenti preistorici presso il colle di San Damiano e preromani presso l'attuale città vecchia), durante l'epoca romana il territorio loanese era costellato da ville anche di un certo rilievo; un mosaico romano di età imperiale è visibile presso il piano nobile di palazzo Doria. Nell'VIII secolo per donazione carolingia il territorio denominato Lovenis (corrispondente al primo toponimo loanese) fu donato al monastero benedettino di San Pietro in Varatella(Toirano) che fondarono nei pressi del porto la chiesa-santuario di Nostra Signora di Loreto. Nel corso dei secoli XI-XII fu dominio vescovile della vicina Albenga e durante l'episcopato di Lanfranco Dinegro (1263) il territorio di Loano fu investito ad Oberto Doria che come vassallo dotò il feudo, ancora sviluppato lungo le pendici dell'entroterra per paura delle sempre più frequenti scorrerie dei pirati, di autonomia giuridica e amministrativa e, soprattutto, non soggetto alle dipendenze di una Repubblica di Genova che iniziò da tale secolo la sua espansione territoriale verso il ponente ligure. Intorno al 1300 fu il nuovo signore Raffo Doria, figlio di Oberto, a concedere ai capi famiglia del Poggio nuovi spazi terrieri più verso la costa dove, nel tempo, cominciarono a sorgere nuovi nuclei urbani e attività commerciali e manifatturiere.