Facoltà Di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche E Studi Orientali
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
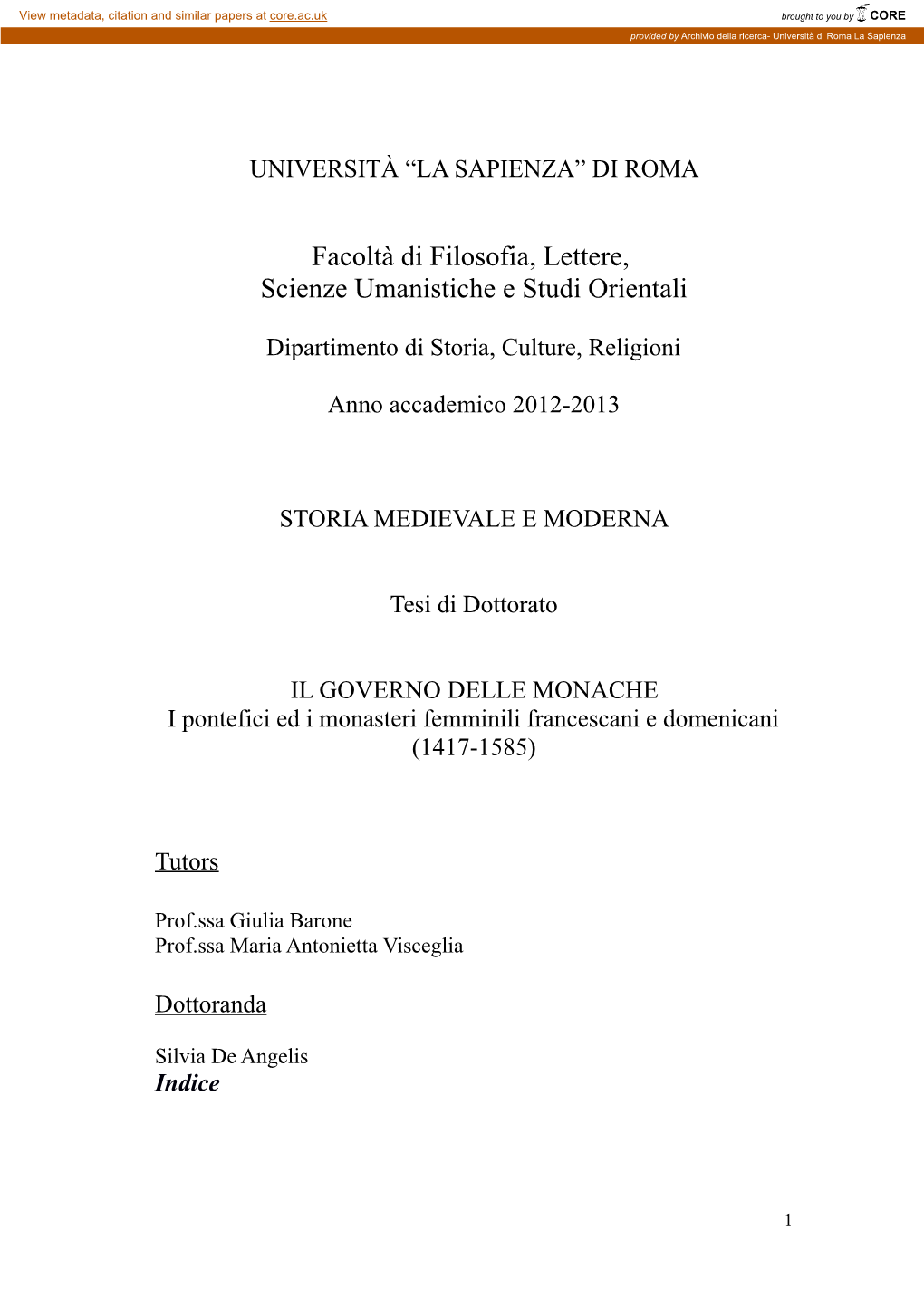
Load more
Recommended publications
-

Acollection of Correspondence
© 2012 Capuchin Friars of Australia. All Rights Reserved. A COLLECTION OF CORRESPONDENCE Some Letters … and other things, from Sixteenth Century Italy in their original languages Bernardo, ben potea bastarvi averne Co’l dolce dir, ch’a voi natura infonde, Qui dove ‘l re de’ fiume ha più chiare onde, Acceso i cori a le sante opre eterne; Ché se pur sono in voi pure l’interne Voglie, e la vita al destin corrisponde, Non uom di frale carne e d’ossa immonde, Ma sète un voi de le schiere sperne. Or le finte apparenze, e ‘l ballo, e ‘l suono, Chiesti dal tempo e da l’antica usanza, A che così da voi vietate sono? Non fôra santità,capdox fôra arroganza Tôrre il libero arbitrio, il maggior dono Che Dio ne diè ne la primera stanza.1 Compiled by Paul Hanbridge Fourth edition, formerly “A Sixteenth Century Carteggio” Rome, 2007, 2008, Dec 2009 1 “Bernardo, it should be enough for you / With that sweet speech infused in you by Nature, / To light our hearts to high eternal works, / Here where the King of Rivers flows most clearly. / Since your own inner wishes are sincere, / And your own life reflects a pure intent, / You’re ra- ther an inhabitant of heaven. /As to these masquerades, dances, and music, /Sanctioned by time and by ancient custom - /Why do you now forbid them in your sermons? /Holiness it is not, but arrogance to take away free will, the highest gift/ Which God bestowed on us from the begin- ning.” Tullia d’Aragona (c. -

A Transcription and Translation of Ms 469 (F.101R – 129R) of the Vadianische Sammlung of the Kantonsbibliothek of St. Gallen
A SCURRILOUS LETTER TO POPE PAUL III A Transcription and Translation of Ms 469 (f.101r – 129r) of the Vadianische Sammlung of the Kantonsbibliothek of St. Gallen by Paul Hanbridge PRÉCIS A Scurrilous Letter to Pope Paul III. A Transcription and Translation of Ms 469 (f.101r – 129r) of the Vadianische Sammlung of the Kantonsbibliothek of St. Gallen. This study introduces a transcription and English translation of a ‘Letter’ in VS 469. The document is titled: Epistola invectiva Bernhardj Occhinj in qua vita et res gestae Pauli tertij Pont. Max. describuntur . The study notes other versions of the letter located in Florence. It shows that one of these copied the VS469, and that the VS469 is the earliest of the four Mss and was made from an Italian exemplar. An apocryphal document, the ‘Letter’ has been studied briefly by Ochino scholars Karl Benrath and Bendetto Nicolini, though without reference to this particular Ms. The introduction considers alternative contemporary attributions to other authors, including a more proximate determination of the first publication date of the Letter. Mario da Mercato Saraceno, the first official Capuchin ‘chronicler,’ reported a letter Paul III received from Bernardino Ochino in September 1542. Cesare Cantù and the Capuchin historian Melchiorre da Pobladura (Raffaele Turrado Riesco) after him, and quite possibly the first generations of Capuchins, identified the1542 letter with the one in transcribed in these Mss. The author shows this identification to be untenable. The transcription of VS469 is followed by an annotated English translation. Variations between the Mss are footnoted in the translation. © Paul Hanbridge, 2010 A SCURRILOUS LETTER TO POPE PAUL III A Transcription and Translation of Ms 469 (f.101r – 129r) of the Vadianische Sammlung of the Kantonsbibliothek of St. -

Fire, Smoke and Vapour. Jan Brueghel's 'Poetic Hells
FIRE, SMOKE AND VAPOUR. JAN BRUEGHEL’S ‘POETIC HELLS’: ‘GHESPOOCK’ IN EARLY MODERN EUROPEAN ART Christine Göttler Karel van Mander, in the ‘Life of Jeronimus Bos’ in his Schilder-Boeck of 1604, speaks of the ‘wondrous or strange fancies’ (wonderlijcke oft seldsaem versieringhen), which this artist ‘had in his head and expressed with his brush’ – the ‘phantoms and monsters of hell ( ghespoock en ghe- drochten der Hellen) which are usually not so much kindly as ghastly to look upon’.1 Taking one of Bosch’s depictions of the Descent of Christ into the Limbo of the Fathers as an example, van Mander further notes that ‘it’s a wonder what can be seen there of odd spooks (oubolligh ghespoock); also, how subtle and natural (aerdigh en natuerlijck) he was with ames, \ res, smoke and vapours’.2 In the Schilder-Boeck, van Mander frequently uses the word ‘aerdigh’ to describe the aesthetically pleasing quality of small works or small details;3 here, ‘aerdigh’ refers to the natural and lively depiction of res. As it has been observed, van Mander’s list of Bosch’s painterly expres- sions echoes Erasmus’s often-cited eulogy on Dürer in the Dialogus de recta Latini Graecique sermonis pronuntiatione (Dialogue About the Correct Pro- nunciation of Latin and Greek), published in Basel in 1528. According to 1 Mander K. van, The Lives of the Illustrious Netherlandish and German Painters, from the \ rst edition of the Schilder-boeck (1603–1604), ed. H. Miedema, 6 vols. (Davaco: 1994–99) I 124f. (f. 216v): ‘Wie sal verhalen al de wonderlijcke oft seldsaem versieringhen/die Ieronimus Bos in’t hooft heeft ghehadt/en met den Pinceel uytghedruckt/van ghe- spoock en ghedrochten der Hellen/dickwils niet alsoo vriendlijck als grouwlijck aen te sien.’ Here and in the following, my translation is largely based on the one given in Miedema’s edition of The Lives; I use, however, a more literal translation of van Mander’s expressions. -

UCC Library and UCC Researchers Have Made This Item Openly Available
UCC Library and UCC researchers have made this item openly available. Please let us know how this has helped you. Thanks! Title Warriors and musicians: notes from the Colonna family archive Author(s) Marshall, Melanie L. Publication date 2011-05 Original citation Marshall, Melanie L. ; (2011) 'Warriors and Musicians: Notes from the Colonna Family Archive'. Early Music, 39 (2):195-201. Type of publication Article (peer-reviewed) Link to publisher's http://em.oxfordjournals.org/cgi/reprint/car026? version ijkey=Zc3kCNwRFq8rWpm&keytype=ref http://dx.doi.org/10.1093/em/car026 Access to the full text of the published version may require a subscription. Rights © The Author 2011. Published by Oxford University Press. All rights reserved. This is a pre‐copy‐editing, author‐produced PDF of an article accepted for publication in Early Music following peer review. The definitive publisher‐authenticated version (Melanie L. Marshall, ‘Warriors and Musicians: Notes from the Colonna Family Archive’, Early Music 2011; doi: 10.1093/em/car026) is available online at http://em.oxfordjournals.org/cgi/reprint/car026? ijkey=Zc3kCNwRFq8rWpm&keytype=ref. Embargo information Access to the full text of this article is restricted by request of the publisher. Full Text will be available from 1 May 2013. Item downloaded http://hdl.handle.net/10468/771 from Downloaded on 2021-10-04T03:35:03Z Warriors and Musicians: Notes from the Colonna Family Archive* Dr Melanie L. Marshall (University College Cork) This is a pre‐copy‐editing, author‐produced PDF of an article accepted for puBlication in Early Music following peer review. The definitive puBlisher‐authenticated version (Melanie L. -

Galilæana Viii
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Institutional Research Information System University of Turin BIBLIOTECA DI GALILÆANA VIII COPERNICUS BANNED The Entangled Matter of the anti-Copernican Decree of 1616 edited by Natacha Fabbri and Federica Favino LEO S. OLSCHKI EDITORE MMXVIII Tutti i diritti riservati Casa Editrice Leo S. Olschki Viuzzo del Pozzetto, 8 50126 Firenze www.olschki.it ISBN 978 88 222 6584 5 CONTENTS Introduction . Pag . VII Roberto Bondì, Dangerous Ideas: Telesio, Campanella and Galileo . » 1 Natacha Fabbri, Threats to the Christian Cosmos. The Reckless As- sault on the Heavens and the Debate over Hell . » 29 Franco Motta, Nature, Faith and the Judge of Faith. Some Consid- erations on the Historical-Political Context of Copernicus’ Con- demnation . » 57 Luigi Guerrini, The Archbishop and Astronomy. Alessandro Marzi- medici and the 1604 Supernova . » 101 Federica Favino, Alchemical Implication of 1616 Affaire. On the Par- ish Priest Attavanti, the Knight Ridolfi and the Cardinal Orsini . » 127 Giovanni Pizzorusso, Francesco Ingoli: Knowledge and Curial Ser- vice in 17th-century Rome . » 157 Édouard Mehl, Kepler’s second Copernican Campaign. The Search for an Annual Stellar Parallax after the Roman Decree (1616) . » 191 Rienk Vermij, Copernicanism and the Bible in the Dutch Republic around 1616: a non-debate . » 211 Steven Vanden Broecke, An Astrologer in the World-Systems Debate. Jean-Baptiste Morin on Astrology and Copernicanism (1631-1634) . » 223 Index of Names . » 243 — V — Franco Motta NATURE, FAITH AND THE JUDGE OF FAITH Some Considerations on the Historical-Political Context of Copernicus’ Condemnation 1. The denunciation of Galileo and the first examination of Coperni- canism by the Inquisition The dossier against Galileo that reached the desk of the Prefect of the Index, Cardinal Sfondrati, in February 1615 contains several interest- ing charges. -

A Florentine Diary
THE LIBRARIES A FLORENTINE DIARY A nderson SAVONAROLA From the portrait by Fra Bartolomeo. A FLORENTINE DIARY FROM 1450 TO 1516 BY LUCA LANDUCCI CONTINUED BY AN ANONYMOUS WRITER TILL 1542 WITH NOTES BY IODOCO DEL B A D I A 0^ TRANSLATED FROM THE ITALIAN BY ALICE DE ROSEN JERVIS & PUBLISHED IN LONDON IN 1927 By J. M. DENT & SONS LTD. •8 *« AND IN NEW YORK BY « « E. P. DUTTON & COMPANY TRANSLATOR'S PREFACE ALTHOUGH Del Badia's ample and learned notes are sufficient for an Italian, it seemed to me that many allu sions might be puzzling to an English reader, especially to one who did not know Florence well; therefore I have added short notes on city-gates, churches and other buildings which now no longer exist; on some of the festivals and customs; on those streets which have changed their nomenclature since Landucci's, day; and also on the old money. His old-fashioned spelling of names and places has been retained (amongst other peculiarities the Florentine was in the habit of replacing an I by an r) ; also the old calendar; and the old Florentine method of reckoning the hours of the day (see notes to 12 January, 1465, and to 27 April, 1468). As for the changes in the Government, they were so frequent and so complex, that it is necessary to have recourse to a consecutive history in order to under stand them. A. DE R. J. Florence 1926. The books to which I am indebted are as follows: Storia della Repubblica di Firenze (2 vols.), Gino Capponi. -

Life and Writings of Juán De Valdés, Otherwise Valdesso, Spanish
fS" '"%IIMiiiK'i«a?..;?L.l!"3" "e VaWes 3 1924 029 olln 228 370 DATE DUE DECQjpg Cornell University Library ^^,^4^€^^/ The original of tliis book is in tlie Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/details/cu31924029228370 LIFE AND WEITINGS OP JUAN DE VALDES. LONDON PHIKTED BY SPOTTISWOODE AND CO. NEW-STREET SQUARE LIFE AND WEITINGS OF JUAN DE YALDES, SPAl^ISH EEFOEMER IN THE SIXTEENTH CENTURY, BY BENJAMIN B?^'^FFEN. WITH ^ 'translation from tfte Italian OF HIS BY JOHN T. BETTS. TAUJESIO HISPANTTS SCarPTORE SUPEKBIAT ORBIS. Daniel Rogers. NON 'MoBTruBA.~&iulia Oomaga's Motto, p. 112. ^ LONDON: BEENAED QUAEITCH, 15 PICCADILLY. 1865. ix [_T/te Hghf of Tramlation and npprodiiHiov reserved^ *®6cse JWeUitatfons \xitxt UEStpeB to txtxtt tn tje goul t^E lobe ana fear of C&oii; anti tSeg ougfit to 6e realr, not in tfic Surrg of iustness, ftut in rettwmtnt; in fragments, get smtessiklB ; tje reaUer laging tjbem at once astfte loSen fie is foearg.' ANSELM. /]^36f;f .^^^^- "'^ I T!.3 "^^ Pre:i:lonc White Library PREFACE The book entitled The Hundred and Ten Considera- tions OF SiSNiOK John Valdesso, printed at Oxford in 1638, 4to., has become scarce. It is shut up in libraries, and should a stray copy come abroad, it is rarely to be obtained by him who seeks for it. This is not so much because the work is sought for by many, and largely known; for the principles it teaches are almost as much in advance of the present times as they were in the days of the 'sainted George Herbert' and Nicholas Ferrar, who first published it in English. -

1. Humanism and Honour in the Making of Alessandro Farnese 35
6 RENAISSANCE HISTORY, ART AND CULTURE Cussen Pope Paul III and the Cultural Politics of Reform of Politics Cultural the and III Paul Pope Bryan Cussen Pope Paul III and the Cultural Politics of Reform 1534-1549 Pope Paul III and the Cultural Politics of Reform Renaissance History, Art and Culture This series investigates the Renaissance as a complex intersection of political and cultural processes that radiated across Italian territories into wider worlds of influence, not only through Western Europe, but into the Middle East, parts of Asia and the Indian subcontinent. It will be alive to the best writing of a transnational and comparative nature and will cross canonical chronological divides of the Central Middle Ages, the Late Middle Ages and the Early Modern Period. Renaissance History, Art and Culture intends to spark new ideas and encourage debate on the meanings, extent and influence of the Renaissance within the broader European world. It encourages engagement by scholars across disciplines – history, literature, art history, musicology, and possibly the social sciences – and focuses on ideas and collective mentalities as social, political, and cultural movements that shaped a changing world from ca 1250 to 1650. Series editors Christopher Celenza, Georgetown University, USA Samuel Cohn, Jr., University of Glasgow, UK Andrea Gamberini, University of Milan, Italy Geraldine Johnson, Christ Church, Oxford, UK Isabella Lazzarini, University of Molise, Italy Pope Paul III and the Cultural Politics of Reform 1534-1549 Bryan Cussen Amsterdam University Press Cover image: Titian, Pope Paul III. Museo di Capodimonte, Naples, Italy / Bridgeman Images. Cover design: Coördesign, Leiden Lay-out: Crius Group, Hulshout isbn 978 94 6372 252 0 e-isbn 978 90 4855 025 8 doi 10.5117/9789463722520 nur 685 © B. -

Poesía, Corte Y Epistolaridad Entre España E Italia: Cuarenta Y Seis
Poesía, corte y epistolaridad entre España e Italia: cuarenta y seis cartas inéditas de Diego de Silva y Mendoza, Conde de Salinas, con el cardenal Ascanio Colonna (1560-1608) PATRICIA MARÍN CEPEDA Universidad Pompeu Fabra Resumen El presente artículo ofrece el estudio y la edición de cuarenta y seis cartas inéditas manuscritas pertenecientes al epistolario del cardenal italiano Ascanio Colonna (1560 - 1608), localizadas en el Archivio Colonna, custodiado por la Biblioteca Statale en el monasterio benedictino de Santa Scolastica de Subiaco (Roma). Las cartas fueron intercambiadas por dos personalidades fundamentales en el campo político y literario de finales del siglo XVI: el prolífico poeta y político avezado Diego de Silva y Mendoza, Conde de Salinas, y el cardenal italiano, protector de escritores del círculo de Miguel de Cervantes y Virrey de Aragón, Ascanio Colonna (1560- 1608). Su correspondencia constituye una pieza clave para entender la red de relaciones, tanto de amistad como clientelares, que ambos trazaron en el campo político y literario de las dé- cadas finales del reinado de Felipe II, entre España e Italia. Su lectura debe incardinarse en el amplio mapa que dibujan las más de veinte mil cartas conservadas en el cartulario de Ascanio Colonna, intercambiadas con las principales cortes europeas y con importantes escritores es- pañoles del Siglo de Oro (como fray Luis de León, Luis Gálvez de Montalvo, Pedro Fernández de Navarrete, Juan Rufo, Juan Bautista de Vivar, Luis de Vargas y el ya citado Conde de Salinas). Dicha correspondencia entre Salinas y Colonna revela, en última instancia, un ejemplo elocuente de las dinámicas de clientelismo y patronazgo entre los escritores y la nobleza italo-española de la temprana modernidad. -

Exegesis and Dissimulation in Visual Treatises
Political Art of the Papacy: Visual Representations of the Donation of Constantine in the Early Modern Period by Silvia Tita A dissertation submitted in partial fulfillment on the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (History of Art) in the University of Michigan 2013 Doctoral Committee: Professor Megan L. Holmes, Co-Chair Lecturer Thomas C. Willette, Co-Chair Professor Celeste A. Brusati Professor Louise K. Stein Associate Professor Achim Timmermann © Silvia Tita 2013 Acknowledgments The research period of this project brought me great intellectual joy. This would not have happened without the assistance of many professionals to whom I am much indebted. My deep gratitude to the staffs of the Biblioteca Apostolica Vaticana (with special thanks to Dott. Paolo Vian), the Archivio Segreto Vaticano, the Archivio di Stato Roma, the Biblioteca Angelica, the Biblioteca Casanatense, the Biblioteca Centrale di Roma, the Bibliotheca Hertziana, the Biblioteca di Storia dell'Arte et Archeologia, the Istituto Nazionale per la Grafica in Rome, the Biblioteca Marucelliana in Florence, Bibliothèque Nationale de France in Paris, the Departement des Arts Graphique and the Departement des Objets d'Art of the Louvre. I would also like to thank to the curators of the Kunstkammer Department of the Kunsthistorisches Museum in Vienna, especially to Dr. Konrad Schlegel who generously informed me on the file of the Constantine Cabinet. The project was born and completed as it is in Michigan. I would like to thank all members of my committee. Tom Willette deeply believed in the project and my ideas from the very beginning and offered great advice during our long conversations. -

Revisión Historiográfica Del Concilio De Trento Manuel Teruel Gregorio De Tejada
Revisión historiográfi ca del Concilio de Trento Manuel Teruel Gregorio de Tejada Resum La bibliografi a sobre el Concili de Trento és molt abundosa, particularment pel que fa als temes teològics i canònics, pero la que tracta dels aspectes his- tòrics és més modesta. S’ha parat poca atenció a la fenomenologia, als aspec tes externs (sociopolítics) i als que, tot i semblar només formals, són importants per a la seva comprensió. Tots poden explicar per què el Tridentí ha ocupat un lloc de primer ordre en la història quan va veure’s sacsejat pels aconteixe- ments. Després d’oferir un breu panorama historiogràfi c i descriure el període de gestació, llarg i confl ictiu, l’article s’ocupa d’altres varis aspectes: el lloc de la seva celebració, la denominació com a expresió de la seva pròpia naturalesa sinodal, la mecànica conciliar, el problema de la representativitat i ecumeni- citat, la recepció de les seves decisions. I acaba amb una síntesi de la seva apres- sada clausura, formulada signifi cativament en la butlla de confi rmació, amb el tema concomitant de la professió de fe jurada. Paraules clau: Concili de Trento, revisió historiogràfi ca, conciliarisme. Resumen La bibliografía del Concilio de Trento es muy abundante, particularmente en lo que se refi ere a los temas teológicos y canónicos, pero la historiografía es más modesta y, aun así, se ha prestado poca atención a la fenomenología, a los aspectos externos (sociopolíticos) y a los que siendo aparentemente forma- Pedralbes, 30 (2010), 123-205, ISSN: 0211-9587 13444 Rev Pedralbes 30.indd 123 28/01/13 15:04 124 manuel teruel gregorio de tejada les son importantes para su comprensión. -

Famiglie Nobili
FAMIGLIE NOBILI RACCOLTE DAL NAPOLI STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEL CAV. G. DE ANGELIS E FIGLIO Strada Portamedina alla Pignasecca, 44 MEMORIE DELLE FAMIGLIE NOBILI MEMORIE D E I.I.E FAMIGLIE NOBILI •BELLE •PROVINCE M ERIDIONALI D’ ITALIA RACCOLTE DAL CONTE BERARDO CANDIDA GONZAGA^ VOLUME SECONDO '■"% _ ........ NAPOLI STAB. TIPOG. DEL CAV. G. DE ANGELIS E FIGLIO PORTAMEDINA ALLA PIGNASECCA, 44 PROPRIETÀ LETTER Biblioteka Jagielloriska 1001385478 1001385478 AYERBO D’ARAGONA Questa famiglia ebbe origine da D. Pietro Signore di Ayerbo procreato da D. Giacomo Re di Aragona con D. Teresa Gii di Viduara, dama di Valenza. Il Re D. Giacomo, per ragioni di Stato, fu obbligato di sposare D. Violante di Castiglia, con la quale procreò D. Pietro Re di Aragona, detto il Grande. Ot tenne però dal Pontefice di legittimare i figli D. Pietro signor di Ayerbo, e D. Giacomo Signor d’ Ixerice , o Ixerico, il quale diede origine alla famiglia di tal nome. Ottenne pure che , estinte le linee maschili dei figli di D. Violante di Castiglia, succedessero nel Regno a preferenza delle femmine, i discendenti dei figli di D. Teresa Gii di Viduara. La famiglia Ayerbo venne nel Regno di Napoli col Re Alfonso i.° d’Aragona, ed essendo stata dichiarata di Regio Sangue, godette molti privilegi e fu immune dai pagamenti fiscali. Ha goduto nobiltà in Napoli al Seggio di Porto, Catanzaro, Cotrone, Stilo e Grotteria. Vestì l’abito di Malta nel 1546. ■ Della detta famiglia sorgono monumenti in Napoli nel Duomo e nella Chiesa di S. Maria del Popolo. Vuoisi che Giovanni d’Ayerbo ottenuta da Re Alfonso I la signoria di Cestara desse origine alla famiglia Cestari.